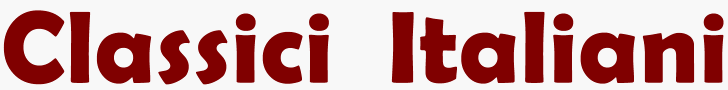La virtù sconosciuta è un’operetta in forma di dialogo composta da Alfieri durante il soggiorno in Alsazia nel 1786, e stampata la prima volta nel 1788 (ma con data 1786). L’autore immagina che compaia dinanzi a lui l’ombra di Francesco Gori, suo amico carissimo da poco scomparso. Nel dialogo sono messi a confronto due scelte di vita: quella del poeta che si fa carico di una missione pubblica di verità e quella di chi invece spende la propria grandezza nell’intimo dell’animo e dei pochi rapporti privati. Il confronto dà occasione all’Alfieri di ritornare sui temi fondamentali del suo pensiero: la libertà dell’individuo di fronte al tiranno, l’ignavia della grandissima maggioranza degli uomini (“la folla dei nati-morti”), il disinganno della gloria. Lo stile, sostenutissimo, dà alla prosa cadenze ritmiche prossime a quelle della poesia. (Da Dizionari Zanichelli)
Note
Diritti d’autore: no
Edizione di riferimento: tratto da Vittorio Alfieri, Della tirannide; Del principe e delle lettere; La virtù sconosciuta, Rizzoli BUR, Milano 1996.
Vittorio Alfieri.
La virtù sconosciuta.
DIALOGO.
Paulum sepultae distat inertiae
Celata virtus.
Orazio, Ode 9, Libro 4
Interlocutori: FRANCESCO GORI, VITTORIO ALFIERI
VITTORIO
Qual voce, quale improvvisa e viva voce dal profondo sonno mi appella e mi trae? Ma, che veggio? al fosco e muto ardere della notturna mia lampada un raggiante infuocato chiarore si è aggiunto! Soavissimo odore per tutta la cameretta diffondesi… Son io, son io ben desto, o in dolce sogno rapito?
FRANCESCO
E che? non conosci la voce, l’aspetto non vedi del già dolce tuo amico del cuore, e dell’animo?
VITTORIO
Oh vista! e fia vero? gli attoniti abbagliati miei occhi a gran pena in cotanta tua luce fissarti si attentano… Ma sì, tu sei desso; quella tua voce, che quand’eri mortale, amistade e virtù mi suonava, rispetto or m’infonde, e con dolcezza misto uno ignoto tremore.
FRANCESCO
Riconfortati. Dagli Elisj vengo io a rivederti, consolarti, ed alquanto star teco; dalle tue sì spesse lagrime e sospiri già ben due anni chiamato, ora, concedendolo il fato, alfin mi rivedi.
VITTORIO
A gran pena i miei sensi ripiglio. – Ma già già quel timore, che di maraviglia nasceva, dileguasi; ed al tuo caro, e sospirato cospetto non può nel mio core albergar più temenza.
Assai cose mi rimaneano a dirti, e ad udire da te, quando (ahi lasso me!) per poche settimane lasciarti credendomi, senza saperlo, io l’ultimo abbraccio ti dava. Desolato io, ed orbo mi sono da quel giorno funesto; né altra scorta al ben vivere, ed alle poche e deboli opere del mio ingegno mi rimase, se non la calda memoria di tue possenti parole, e di quella tua tanta virtù, di cui nobile ed eccelsa prova al mondo lasciare ti avean tolto i nostri barbari tempi, l’umil tua patria, un certo tuo stesso forse ben giusto disdegno, ed in fine l’acerba inaspettata tua morte.
FRANCESCO
Nel reputarmi tu di cose grandi capace, forse all’affetto tuo smisurato, più che al tuo bastante intendimento, credevi. Comunque ciò fosse, morte ch’io non temeva, né bramava; morte che a me dolse soltanto perché, senza neppur più vederti negli ultimi miei momenti, io lasciava te immerso fra le tempeste di mille umane passioni; ma pure, morte che al mio cuore e pensamento giovava, poiché da tanti sì piccioli e nauseosi aspetti per sempre toglieami, ogni tuo amichevole dubbio spettante a me disciolto ha per sempre.
Privato ed oscuro cittadino nacqui io di picciola, e non libera cittade; e, nei più morti tempi della nostra Italia vissuto, nulla vi ho fatto né tentato di grande; ignoto agli altri, ignoto quasi a me stesso, per morire io nacqui, e non vissi; e nella immensissima folla dei nati-morti non mai vissuti, già già mi ha riposto l’oblio.
VITTORIO
Sprezzator di te stesso io ti conobbi pur sempre già in vita; ed in ciò altresì, come in ogni altra cosa, del tutto ti conobbi dissimile, già non dirò dai volgari, ma dai più sommi uomini ancora: e perciò degno ti credeva, e ti credo (soffri ch’io il dica; adulazion qui non entra) degno d’esser primo fra i sommi.
Morto sei; né di te traccia alcuna in questo cieco mondo tu lasci, nol niego, per cui abbiano i presenti e futuri uomini a sapere con loro espresso vantaggio, che la rara tua luce nel mondo già fu. Ignoto ai contemporanei tuoi tu vivevi, perché degni non erano di conoscerti forse; e ad un reo silenzio mal mio grado ostinandoti, d’essere a’ tuoi posteri ignoto sceglievi, perché forse la presaga tua mente, con vero e troppo dolore antivedea, che in nulla migliori delle presenti le future generazioni sarebbero. Ma io, ben rimembrartelo dei, tante volte pur ti diceva, che uffizio e dovere d’ogni alto ingegno con umano cuore accoppiato si era il tentare almeno di renderle migliori d’alquanto, tramandando ad esse sublimi verità in sublime stile notate.
FRANCESCO
Sì, mel dicevi, e il rimembro. Ma rispondevati io, (ed al mio rispondere, ben mi sovviene, tu muto rimanevi, e piangente) rispondevati io; che de’ libri, benché pochi sian gli ottimi, e ch’io tali fatti mai non gli avrei, bastanti pure ve ne sono nel mondo, a chi volesse ben leggerli, per ogni cosa al retto e sublime vivere necessaria imparare. A ciò ti aggiungea; che ufficio e dovere d’uomo altamente pensante egli era ben altrimenti il fare che il dire; che ogni ben fare essendoci interdetto dai nostri presenti vili governi, e il virtuoso e bello dire essendo stato così degnamente già preoccupato da liberi uomini che d’insegnare il da lor praticato bene aveano assai maggior dritto di noi, temerità pareami il volere dalla feccia nostra presente sorger puro ed illibato d’esempio; e che viltà mi parea lo imprendere a dire ciò, che fare da noi non si ardirebbe giammai; e che stolto orgoglio in fin mi parea l’offendere i nostri conservi con liberi ed alti sensi, che i loro non sono, poiché pur si stanno; i quai sensi in me più accattati da’ libri, che miei proprj, riputerebbero essi; e con ragione forse, vedendomi di sì alti sensi severo maestro, e di sì vile vita, quale è la nostra, arrendevol discepolo.
VITTORIO
Che tu, figliuol di te stesso, per te stesso altamente pensavi, io ben lo seppi, che vivo conobbiti; saputo del pari lo avrebbero con lor vantaggio e stupore quegli uomini tutti, che da’ tuoi scritti conosciuto ti avessero. Ma in te più lo sdegno dei presenti tempi potea, che l’amor di te stesso e d’altrui.
Eppure degno non eri, né sei, di questa morte seconda; e se io lena e polso mi avessi, se dal pietoso alto e giusto desio d’onorare eternando il tuo nome, pari all’ardore le forze traessi; se in pochi, ma caldi periodi mi venisse pur fatto di esprimere la quintessenza, direi, della sublime tua anima; di quella fama che tu non curasti, verrei forse io in tal guisa ad acquistartene parte; non tutta, no, mai; che ciò solo alla tua luce creatrice aspettavasi, non alla mia per sé stessa sì poca, e che se nulla in tant’opra valesse, tutto terrebbe dalla sublime dignità del soggetto.
FRANCESCO
La tua amicizia per me in ciò ti lusinga, non men che l’amor di te stesso. Fama non ottiene, e non merita, chi per acquistarla instancabilmente non spese il sudore, il sangue, e la vita. Tu da te stesso la speri, ben so, co’ tuoi scritti: a ciò t’incoraggiva pur io, credendoti, per tue circostanze ed età, più di me atto ad entrar nell’aringo; e gli stessi miei argomenti tu ritorcevi spesso contro di me per risolvermi ad impugnare la penna. Se cosa del mondo piegar mi poteva a ciò fare, tu solo potuto l’avresti; ma la più verace ragione che men distolse, fu, che a ciò non m’essendo io destinato fin dalla prima età mia, le poche forze del mio ingegno tutte al pensare, e al dedurre rivolsi assai più che allo scrivere: onde lo stile, quella possente magica arte delle parole, per cui sola vincitore e sovrano si fa essere il vero, lo stile mancavami affatto.
VITTORIO
E in ciò, soffri che io a te contraddica, sommamente pur t’ingannavi. Nato nel più puro grembo della tosca favella, auree parole non ti poteano mancar mai; pieno, ridondante di forti, veraci, e sublimi pensieri, avresti senza avvedertene l’ottimo tuo naturale stile perfettissimo ridotto scrivendo; e da libro nessuno non lo avendo imparato, uscito sarebbe dal tuo robusto capo col getto della originalità da imitazione nessuna contaminato.
Nuove cose in nuovi modi a te si aspettava di scrivere; ed hai pure, col non volerlo, agli uomini tolto il diletto, il vantaggio, e la maraviglia; a me la infinita dolcezza di vederti degnamente conosciuto e onorato; a te stesso la gloria ed il nome. Finché vivo dintorno a me ti vedea, (me misero!) sulla fallace instabilità delle umane cose affidandomi, nella mente tua nobile, e nel caldo tuo cuore, come in un vivo e continuo libro, te, gli uomini tutti, e me stesso imparava io a studiare, e conoscere. Allettato dal tuo dotto, piacevole, saggio, eppure sì appassionato parlare, securo io troppo nella tua ancor verde età riposando, più a goderne pensava, che a porne con sollecitudine in salvo il migliore, insistendo, incalzandoti, e anche bisognando, amichevolmente sforzandoti a scrivere per tutti, e per me, in vece di parlar per me solo; poiché tu con ogni altro uomo quasi del tutto chiuso vivevi. Di questa mia inescusabile sconsideratezza e notte e giorno piango io: questa è, sol questa, la verace tua morte, che me addolora e dispera; questo è il fiero irreparabile comune e mio danno, che mi martira. Te sfuggito e sottratto alle noje, al servire, al tremare, alla vecchiezza, alle infermità, e più di tutto al dolore immenso e continuo di conoscere il bene ed il grande, e non poterlo né ritrovar né eseguire, te invidio bensì, ma te non compiango giammai.
FRANCESCO
Venendo io dalla magione del disinganno, potrei su questo umano delirio, che amor di fama si appella, dirti e dimostrarti tai cose, che non solo ti consolerebbero di questa tua ideale mia fama, da me non acquistata, (né acquistabile mai) ma ad un tempo istesso ti trarrebbero forse del cuore l’ardentissimo desiderio che della tua propria tu nutri nel petto.
Ma, cessi il cielo, che così dolce ed utile chimera io voglia giammai negli umani petti né pur menomare, non che distruggerla. Cagione essa sola d’ogni umana bell’opera, sovra chi più è nato ad intraprendere ed eseguire il bello, più dispotica regni. E pur troppo già di essa il moderno pensare è nemico; e quindi la sempre maggiore scarsezza d’uomini grandi, e di alte cose.
Non biasimo dunque in te, né mi offende, questo amorevole tuo rammarico che della intera mia nullità mi dimostri; e, se a rivivere avessi, per compiacerti e darti indubitabile prova che la tua stima mi sarebbe caldo incentivo al ben fare, mi proverei in quale stadio potessi atleta riuscire. Posso io più espressamente teco ricredermi della passata mia infingardaggine?
VITTORIO
Questo tardo tuo pentimento, e la ragione che vi ti muove, vieppiù sempre mi accorano. Ora sappi, che cercando io, non sollievo, ma pascolo al mio dolore colla tua amata memoria, di alcune tue carte fra mani cadutemi pensai di far uso, un qualche saggio che tu sei stato mandandone al pubblico colla stampa. Quelle sono, in cui col vivacissimo pennello della tua bollente, ma giusta ed erudita fantasia, tu descrivi presso che tutti i migliori dipinti della tua città; la quale, benché poco si sappia dai più, ne è pure abbondantissima.
FRANCESCO
Nol far, deh, nol fare, se davvero tu m’ami. Tu sai, che per mio solo passatempo e diletto io già, così come dava la penna, buttava in carta l’effetto che mi parea ricever nell’animo dalla vista ed esame di quelle pitture. Nessuna idea, neppur leggerissima, di far su ciò libri mi cadde mai nella mente; e benché corra adesso questa smania di belle arti, ed alcuni, nulla potendo essere per sé stessi, né far del loro, abbiano creata questa nuova arte di chiacchierar sull’altrui; tu sai che io sempre ho reputato esser questa una mera impostura: perché il vero senso del bello si può assai più facilmente provare, che esprimere. E a questi entusiasti di belle arti chi credere veramente potrà nel vederli così caldi ammiratori di un Bruto dipinto, e così freddi lettori poi di un Bruto da Livio scolpito?
Il forte sentire, credilo a me, egli è una liquida sottile infiammabile qualità, che per ogni nostra vena e fibra trascorre, ed a tutti i sensi si affaccia. Or, che saran questi grandi, che in altro nol sono, che nella potenza degli occhi? Nol sono in quella neppure; s’infingono, s’ingannano, per ingannare.
Io mi diedi ad osservare e gustar le belle arti alcun poco, ma chiuso in me stesso; e ciò feci allor quando vidi e convinto mi fui, che l’osservare e il gustare le forti e magnanime imprese era in questi nostri tempi cagione di più infelicità e dolore. Se uomo mai pianse, si rose, e consumò in sé stesso per lo trovarsi le vie tutte al forte operare impedite, certo sono io stato un di quelli. Vedi ora se con sì feroce tarlo nel cuore io posso aver amato le arti per altro, che per deviare, direi così, la troppa mia bile; né scritto di esse per altro, che per mio mero piacere, senza intenzion nessuna di riportarne la più minima lode pur mai.
VITTORIO
Ed appunto per ciò traluce in questi tuoi scritti un certo vero, e non affettato né ingrandito senso del bello, dal quale vorrei che con loro vergogna imparassero codesti moderni entusiasti, che le gran parole, grandi cose non sono; e che il caldo dell’anima di chi ha osservato e sentito il bello, non trapassa veramente nel cuore di chi ne legge il resultato, se non per via della più naturale semplicità.
Quindi io avea presso che risoluto in me stesso di dare in luce quelle tue sole descrizioni dei dipinti della sala del palazzo pubblico in Siena; i quali, per essere bei fatti di storia d’amor patrio, e di libertà, non avrebbero meno testimoniato il tuo finissimo tatto nell’arte, che il tuo forte entusiasmo per le vere e sublimi virtù; e mi parea di vederviti in poche tue parole vivamente dipinto te stesso; e mi bastava ciò, per mostrare di te quasi un raggio al volgo degli uomini: e, per tutto in somma svelarti, a quel tuo brevissimo scritto disegnava io di far precedere una tua brevissima vita, in cui dimostrato avrei, ma con modeste parole, del pari il tuo raro valore, e la mia calda amicizia e ammirazione vera per te.
FRANCESCO
Vita? che dici? Per la nostra amicizia caldamente ten prego, nol fare.
Le vite scriveansi altre volte de’ santi, affinché le leggessero gl’idioti; e quelle degli uomini politicamente grandi in virtù, affinché leggendole i pochi che di grandezza aveano alcun seme nel cuore, più fortemente, e più tosto, mossi da nobile maraviglia ed invidia, lo sviluppassero; e leggendole gli altri moltissimi impotenti, se ne maravigliassero soltanto. Le vite si scrivono presentemente d’ogni principe che fatto abbia o disfatto delle leggi, e vinte o perdute delle battaglie; e d’ogni autore, che schiccherato abbia comunque alcuni fogli di carta.
Ma, quali che sian stati costoro, la base pur sempre di questa loro terrena apoteosi si è l’essere essi stati conosciuti almeno, o saputi: ma lo scriver la vita di uno che nulla ha fatto, e che nessuno sa che sia stato, sarebbe giustamente reputato espressa follia: che se fra i termini della mediocrità d’ogni cosa in cui vissi, tu mi rappresentassi dal vero, direbbero i pochi che ti leggessero: Una comune virtù, meritava ella vita? Se, o con lusinga di stile, o con ingrandimento del vero, tu dalla sola e cieca amicizia guidato, imprendessi a ritrarmi, direbbero con più ragione i lettori: Ma, che ha egli fatto costui, per meritar sì grandi laudi?
Tu vedi dunque che le vite vogliono essere scritte di coloro soltanto, che o gran bene o gran male agli uomini han fatto. E, degli antichi scrivendo, perfetto modello di ciò ne ha lasciato il divino Plutarco: e a scrivere dei moderni (di cui un volume d’assai minor mole farebbesi) non è sorto ancora un Plutarco novello. Benché tutto dì delle vite si scrivano, non si dà però vita a nessuno, né la ottiene per sé lo scrittore. Saviamente dunque, e da molto più verace mio amico farai, di me soltanto ricordandoti, se pur ti giova, ma tacitamente nel tuo cuore; e nulla affatto di me mai scrivendo; perché in qualunque modo tu ponessi in carta questo tuo affetto per me, potresti con tuo dolore e mio danno dal tristo esito di un tale tuo scritto ritrarne il disinganno della opinione, in che tu mi tieni.
VITTORIO
E queste stesse cose che ora dicendo mi vai, deh, perché il mondo intero non le ascolta? Dalla tua nobile e natural non curanza di te stesso, quanta grandezza dell’alto tuo animo non trasparirebbe a quei pochi che conoscono il vero, e che non sempre giudicano le cose dall’effetto? Io per l’appunto nell’accennare al pubblico alcuni tuoi tratti, e brevemente sovra essi ragionando, nutriva assai fondata speranza di poter con evidenza dimostrare, che la virtù vi può essere anco nei più servili tempi, e nei più viziosi governi; che tal virtù vi può essere, la quale, anche nulla operando, a quella che il più operasse giammai, si pareggi; e che in somma, quando ella nasce e dimora là dove tutto l’impedisce, la distrugge, o la scaccia, egli è ufficio di retto uomo, non che di verace amico, il manifestarla a tutti per consolare e incoraggire i pochissimi buoni, e per vie più confondere e intimorire i moltissimi rei. E se io dalla tua ignotissima vita, dai privati e semplici tuoi costumi mi riprometteva pure di trarre, senza alterare il vero, luminosi saggi di fortezza ed altezza d’animo, di umanissimo cuore, di acutissimo ingegno, di maschio e libero petto; di ritrarne in somma un raro complesso delle più pregiate cittadine virtù di Roma, o d’Atene, velate da così amabile modestia, e in tempi cotanto ad esse contrarj con sì discreta disinvoltura senza niuno offendere praticate; non avrei io forse con un tale scritto potuto muovere la curiosità degli uomini tutti? non avrei io potuto la malignità dei più ammutolire coll’evidenza? non l’amore e la maraviglia di quelli destare, che dalla piccolezza del muto tuo stato vie più argomentando, come si dee, la grandezza delle tue doti, ed a me pienamente credendo, (perché chi il vero scrive facilmente con colori di verità lo dipinge) avrebbero la tua virtù non de’ tempi, doppiamente sentita, e fors’anche, come nuova e inaudita cosa imitata l’avrebbero?
FRANCESCO
Questo lungo tuo sfogo ho io conceduto alla calda amistà: le lodi che dare a me vivo non avresti ardito, (troppo m’amavi per farmi cotanto arrossire) niuno ascoltandoci, soffro che alla ombra mia tu le dii; me non offendono, perché a te un verace affetto le detta; me non lusingano, perché da ogni mortale umana picciolezza son tolto: e purché a chi che sia tu mai non le narri, io godo assai, che la memoria mia sì saldo ed onorato loco entro il tuo petto ritenga. Quelle virtù che a me presti, poiché sì ben le conosci ed apprezzi, fa che sian tue; e non nel tuo scrivere soltanto, ma nella pratica della vita, per quanto i tempi il comportano: e, poiché tanto me stimi, pensa dunque a tutta meritar la mia stima; pensa che io da te non rivolgo mai gli occhi, e che ogni tuo più interno e nascosto senso io leggo e discopro.
VITTORIO
E ciò sia: e se non sempre, anzi le più rade volte, scorgerai nel mio pur troppo picciolo cuore sane ed alte cagioni che il muovano; a quest’una di parlar di te, d’amarti, e apprezzarti più che cosa del mondo, son certo che niuna vile cagione, nessun basso fine vedrai che mi muova.
Ma, poiché tu mi vieti che io faccia di te mai menzione nel mondo, ed or ora tu stesso parlandomi, notasti il mio ardire, col quale io in faccia ti laudava, cosa che a te vivo non avrei fatta io mai; piacciati per mia consolazione, sollievo, e istruzione rendere a me solo ragione di molte tue particolarità di cui non mi sono attentato in vita richiedertela. E ciò non sia prova che l’uno amico all’altro nulla tacesse; ma che, siccome base dell’amistà nostra non erano le mutue lusinghe, ma l’amor del vero, non tutte quelle cose ricercavamo noi l’un dall’altro, alle quali per soddisfar pienamente era d’uopo sagrificare in alcuna parte alla verità la modestia. Quindi io delle tue virtù ogni giorno ne andava discoprendo qualcuna, ma il fonte di esse non sempre ti pregava io di scoprirmi. Rispondimi ora dunque su alcune; e come quegli che è
Sciolto da tutte qualitati umane,
non mi tacere omai nulla, te ne scongiuro, ancorché alla dilicata e modesta tua indole costar ne potesse non poco.
FRANCESCO
Ogni cosa farò per compiacerti, in questo brevissimo tempo in cui la tua vista a me vien concessa dal fato: ma non bene tu festi di non richiedermene francamente in vita; alto segno d’amicizia vera dato mi avresti; ed io altissimo rendere tel potea snudandoti il vero-vero dell’anima mia. E forse spessissimo la fonte di ciò che virtù chiamavi, e che tal ti parea, avresti visto esser tale da dovermi costar lo svelartelo, non modestia, no, ma bensì ardire molto e vergogna.
VITTORIO
Conosco la umana natura e me stesso. Di me, o di tutt’altr’uomo, ciò credo esser vero che or tu mi accenni; ma di te non lo credo; o meno assai, che d’uomo nessuno del mondo.
Né ingannarmi tu puoi a quest’ora di te stesso parlandomi, come forse in vita fatto lo avresti (non dico, narrandomi il falso, ma non tutto il vero del sublime tuo animo discoprendomi) per non offender forse, discreto troppo, la minoranza del mio. Ora dunque tacermi nulla tu puoi di te stesso: divisi siamo, e il siam per sempre, pur troppo! nulla di te mi rimane che la memoria del valor tuo; fa dunque che me l’abbia io intera.
E da prima rispondimi: Tu nato non nobile, ma cittadino in tempi che questo nobilissimo nome, di cui si fregiava un Scipione, per non v’essere più vera città, vien dato in suono di sprezzo alla classe posta fra i nobili e il popolo, deh, dimmi; tu nato non nobile, co’ nobili che in cuore giustamente sprezzar tu dovevi, come, donde cavavi quel tuo dignitoso contegno, per cui tacitamente, senza però offenderli mai, ti venivi a mostrare tu il vero patrizio, ed essi nel tuo cospetto confessarsi pareano d’esser meno che plebe?
FRANCESCO
Delicato tasto mi tocchi, e questo soltanto ben festi forse di non ricercarmi in vita. Risponderotti pur ora assai francamente.
Ancorché nella natura umana inevitabile sia (benché ascondibile, e dai più scaltri amatori di sé stessi nascoso) quell’odio che si porta ai maggiori di noi, o creduti tali, non odiava io perciò i nobili, perché paragonandomi con essi, in nessuna cosa mi ritrovava io minore di loro, ed in molte maggiore. Dal mio negozio, dove, più per rispetti di famiglia, che per avidità di guadagno, mi stava trafficando di seta, vedeva io spesso pel maggior foro della città scioperati, e carichi oppressi d’ozio e di noja codesti nobili passeggiare; ed io li vedea standomi tal volta con Tacito, o con altro sommo classico in mano: come mai odiarli potea? Tacito, o altro libro dicevami, che né io, né essi in questi governi eravamo, né essere potevamo giammai veri uomini: niuna differenza passava tra essi e me nel servire, se non che io d’esser servo sapeva, e doleamene, e vergognava; essi nol sapeano, o se ne gloriavano. Indegno sarei stato del tutto di poter essere un vero uomo, se più assai compatita non avessi tal gente che odiata. E in ciò ti svelo schietto il mio cuore; o fosse natura, o fosse in me frutto del molto leggere, e del più pensare, io gli uomini tutti amava davvero: i pochi buoni, perché tali; i tanti rei, perché rei non son quasi mai per sé stessi, ma per fatalità di circostanze, e insufficienza di leggi. Odiava io bensì sommamente quelle prime cagioni, che gli uomini fanno, o lasciano esser rei, ma non gli uomini mai. Era dunque tale lo stato dell’anima mia, che io neppure i più disprezzabili dispregiava; nessuna cosa abborriva fuorché la violenza usata agli uomini fuor dell’aspetto di legittima legge; molto conosceva, e poco apprezzava me stesso; e non invidiava pure nessuno, cotanti vedendone a me sovrastare; e non desiderava altro al mondo che il poter praticar la virtù: di quella parlo, che sola è la vera, poiché agli altri uomini giova; quella, che conoscer si può, ma immedesimarsela non mai, se non col continuo, pubblico, libero, e laudato esercizio di essa. Tale era io, standomi umilmente a bottega; e non aveva altro sollievo al mondo, che l’andar leggendo i pochi ottimi libri; ed altro martirio al mondo non aveva ad un tempo, che il paragonare me, e i miei tempi, con quegli uomini e tempi, di cui leggeva.
L’umiltà dei natali doluta forse mi sarebbe oltre modo, se avendo io una vera patria, mi avesse ciò escluso dal poterla servire, e giovarle; il che, dove vera patria fu, non accadde pur mai: ma dove la chiarezza del sangue prerogativa altra non dà, che di lasciar rimirar più da presso la fucina vile, in cui le comuni catene di tutti si temprano, somma ventura io reputai il non averla sortita; poiché quindi alla oscurità del mio nascere io poteva più assai facilmente congiungere la purità della mia, non ardirò già dir libera, ma ignorata e indipendente esistenza. Da tutto ciò, forse, nacque, senza che io me ne avvedessi, quel mio contegno, qual ch’ei fosse, co’ nobili, di cui tu mi chiedi ragione.
VITTORIO
Oh anima veramente sublime, che tutto innalza quanto ella tocca! anima, che per nulla aver fatto, ed ogni cosa sentito, tanto è maggiore d’ogni altra, e direi, di sé stessa!
FRANCESCO
Deh, modera questi tuoi affettuosi trasporti. Tanti altri uomini vi sarà, che così pensano e praticano tutto dì…
VITTORIO
Ed ecco ancora un’altra particolar tua grandezza. Gli uomini conosci, ed i tempi; e sì pure ti ostini a reputare non rara cosa la virtù, ed il vero. Senza avvedertene, tu giudichi altrui da te stesso; e così, senza volerlo, te sovra ogni altro fai grande.
Ma, dimmi ancora: come mai col cuore e la mente così pieni e infiammati del bello (cioè del vero); con una tempra di carattere così magnanimamente sdegnoso, impaziente, e bollente; come potevi tu essere coi dotti, o pretesi tali, cotanto modesto; cogli ignoranti così umano; coi saputi così discreto; e coi soverchiatori in fine cotanto signor del tuo sdegno?
FRANCESCO
Non fare mai, né dir nulla invano, fu sempre la principale mia massima. E siccome, per mostrarmi io erudito, (se pure stato lo fossi) già non avrei in tutti costoro scemato l’orgoglio, ma di gran lunga bensì accresciuto in essi l’odio e la rabbia della lor dimostrata insufficienza, mi solea perciò tacere, o non parlare, se non richiesto: e ciò brevemente facea, e accompagnando sempre le parole mie col mi pare; formola, che tengono essi cotanto cara in altrui, mentre pure non esce mai di lor bocca. Ma, non crederai tu per ciò, che io avessi concepito il puerile e basso disegno di piacere a tutti, compiacendo ai più, che son di costoro; no; di pochissimi volli, e giovommi, aver l’amore e la stima; degli altri soltanto non volli aver l’odio, il quale, anche non meritato, sempre ad un uomo buono riesce uno spiacevole carico; e sempre suppone che molti hai offeso: e quand’anche ciò facciasi, non se ne accorgendo l’uomo, o col solo valer più degli altri, o col lasciarlo conoscere, a ogni modo viver dovendo fra gli uomini, e non potendo loro giovare offendendoli, se pure d’alcun pensiero si è fatto tesoro, va goduto per sé, o coi pochissimi amici, e interamente dissimulato coi rimanenti. Queste regole del bene, o per dir meglio, del queto vivere, alquanto debilette parranno alla tua indomita impetuosa indole: ma, non si vuole, né si può vivere in Siena e nella presente Italia, come già in Roma, in Sparta, e in Atene: e siccome in quelle città molti forse, che per sé amata non l’avrebbero, praticavano, od onoravano almeno la virtù, perché ciò voleva la imperiosa opinione dei più; così nelle presenti città, dove i più non la conoscono, ovvero l’abborriscono, è forza il fingere di non conoscerla, o di non apprezzarla molto più che essi l’apprezzino.
Confesso però, che tra quelle quattro specie d’uomini che mi hai mentovate, i dotti, gl’ignoranti, e i saputi, mi hanno fatto ridere alcuna volta, e più spesso a compassione destato; ma i soverchiatori mi hanno assai volte infiammato di sdegno: non udirono per ciò essi mai da me quelle brevissime e forti verità, che di vergogna e confusione riempiendoli, lievemente ammutoliti gli avrebbero; tacque il mio labbro, e non ch’io parlare temessi, ma vano il reputava del tutto; parlò con essi tacitamente il mio aspetto; e ciò mi bastò per non essere quasi mai soverchiato.
VITTORIO
Ciò ch’io più pregio in te ed ammiro, si è, che tu nato buono, e fatto poi ottimo dal molto pensare, e dal molto conoscere le umane cose, godevi pur d’esserlo per te stesso; e se mostrar tale ti dovevi, sempre di alquanto minor valore che il tuo non era, ti mostravi. Tu fra questi presenti uomini mi parevi quasi una gemma nel fango, che per meno rilucere vi si nasconde; ma per esser bruttata non perde già ella il suo splendore e virtù; e chiunque la raccoglie e terge, sel vede. Da questo tuo parlare ben ora comprendo perché allor quando l’acerba morte rapivati, ancorché da pochissimi ben conosciuto, e da tutti dissimile, tu eri pur pianto e desiderato da tutti. La virtù, benché occulta, gli animi dunque tutti, ed i men virtuosi, pienamente, e mal grado loro, soggioga. Ma vero è, ch’ella era di sì gran vaglia la tua, che occulta parendo, non l’era. Ignote eran forse le tue parti sublimi di verace antica virtù che ti avrebbero fatto di tua propria luce brillare in mezzo ai più sommi uomini di Roma libera; ma quelle virtù secondarie, che altro non sono se non se negazione di vizj, e che nella presente nostra meschinità pur somme si chiamano, (e, visti i governi nostri, forse elle il sono) quelle possedevi pur tutte, e ogni giorno, come corrente moneta, senza avvedertene, le spendevi. Quindi nasceva il rispetto, quindi l’universale amore sì grande e verace, che quando io mi accompagnava con te per le vie, dal più infimo fino al più grande, io vedeva in ogni volto manifestamente nel salutarti scolpita quella tacita venerazione, che non si può aver dagli uomini mai per altr’uomo, se non per chi non ha macchia nessuna. Nel volto dei buoni, che erano per lo più i bassi, la rimirava io mista d’amore; in quel degli altri traspariva fra un nuvoletto di sdegno; ma così picciolo egli era, che io l’avrei creduto acceso più contro sé stessi, che contro di te: guai però, guai, se coloro ti avessero creduto ricco delle tue tante altre virtù! ti si perdonavano le triviali e morali, perché ad ognuno parea di poterle, volendolo, praticare. Tacitamente frattanto io osservava in me stesso, e giubilava di doppia gioja, ravvisando in te due così ben distinti, e così raramente accozzati personaggi: il Gori di tutti, e il Gori di sé stesso; e direi, il Gori mio, se questa parola mio in contrapposto del tutti non suonasse qui forse orgoglio e baldanza.
FRANCESCO
Ed io, per provarti che amico vero in morte ti sono come già in vita ti fui, render ti voglio, non grazie per lodi, ma biasimo: e dirti voglio, che se pure in me tu commendi l’aver cogli antichi pensato, e ai moderni non dispiaciuto, in ciò solo imitarmi dovresti. Giacché pure incominciato hai di scrivere, e del tutto forse non sei fuor di strada, libero e sublime sfogo nelle sole tue carte concedi alla splendida e soverchia tua bile; sottilmente, e con discrezione negli scritti adoprata, ella è codesta bile il più incalzante maestro d’ogni alto insegnamento: ma fra gli uomini viventi raffrenarla si debbe: nessuno mai correggerai coll’offenderlo; né maggiore de’ tuoi stessi minori mostrarti potrai, se maggiore in prima non ti fai di te stesso. Pensa coi classici; coll’intelletto e coll’anima spazia, se il puoi, infra Greci e Romani; scrivi, se il sai, come se da quei grandi soli tu dovessi esser letto; ma vivi, e parla, co’ tuoi. Di questo secolo servile ed ozioso, tutto, ben so, ti è nausea e noja; nulla t’inalza; nulla ti punge; nulla ti lusinga: ma, né cangiarlo tu puoi, né in un altro tu esistere, se non col pensiero, e coi scritti. Pensa dunque, ancor tel ridico, pensa, e scrivi, a tuo senno; ma parla, e vivi, ed opera cogli uomini a senno dei più. E su ciò fortemente t’incalzo, perché ti vorrei amato dai pochi bensì, e dai soli buoni stimato, ma non odiato mai da nessuno.
VITTORIO
Comune non è questo pregio, poich’egli era il tuo. Io non ho in me quella umanità, agevolezza, e blanda natura, che era pur tutta tua: sovrana dote, per cui, senza lusinga, né sforzo nessuno, in vece di abbassar te fino agli altri, parevi gli altri innalzar fino a te. E questa, credilo, è l’arte sola, che fa e lascia convivere i grandi co’ piccioli: ma dei veri grandi parlo io, e dei veri piccioli; che mai non son quelli, chiamati tali dal mondo.
Ma, che laudo io in te queste sociali virtù secondarie, mentre un solo esempio ch’io recassi d’una delle altre tue, basterebbe per porti sovra ogni uomo del nostro secolo guasto? Qual fu la cagione della immatura tua morte? la pietà vera, e il raro amore che pel tuo fratello nutrivi. In questi tempi, in cui noi tutti pur troppo dal vorace lusso incalzati, noi tutti quasi, non che piangere di vero cuore la morte dei nostri, crudelmente la desideriamo, od almen l’aspettiamo; la insaziabile abbominevol peste della cupidità delle ricchezze altrui (peste altre volte nelle sole case dei re meritamente albergata) ora, dacché dai moltiplicati bisogni più servi siam fatti, invaso anche ha i più umili tetti: e, tolto il nobile, e sempre di noi men servo agricoltore, il quale nella sua numerosa famiglia la ricchezza amore e felicità sua piena ripone, gli altri tutti barbaramente s’invidiano fra loro la vita; del troppo longevo padre la invidiano i figli, della moglie il marito, del fratello il fratello; e nessuno in somma ben vivo si reputa, fin che non ha i suoi tutti sepolto. Ma tu, diverso in tutto da tutti, fosti anco in ciò diverso dai pochi sommi uomini, che per lo più tenerissimi esser non sogliono dei loro congiunti: né dir saprei se in te fosse maggiore la sublimità della mente, o quella del cuore. Questo fratello tuo, minore di te in ogni cosa come negli anni, di cui tu, quasi amoroso padre, cotanta cura pigliavi; per cui solo attendevi a quel tuo così a te dispiacevole traffico, che necessario non t’era per vivere agiato, e di tanto disturbo ti riusciva per viver pensante; questo tuo fratello in somma, ottimo giovine e di nobil’indole anch’egli, ma in nessuna cosa superiore né al suo stato, né ai tempi, ed in nessunissima a te vicino, egli era pure la sola remora, l’ostacolo solo alla tua intera felicità: poiché tu, come saggio, in null’altro riponendola che nel viver libero, e pensare e dire a tuo senno, disegnavi acquistartela, emendando il tuo nascere, col ricercarla e goderla in quelle contrade dove ella in tutta securtà si ritrova e s’alligna. Eppure quando la morte, percotendo da prima il tuo fratello, pareva aprirtene la via, poteva nel tuo petto assai più la pietà e il dolor per altrui, che non l’amor per te stesso. Non t’adirare, deh, se io qui a virtù grande ti ascrivo que’ sensi, che in migliori tempi, e fra miglior gente, verrebbe tenuto mostruosità il non averli: ma così rara cosa mi pare fra noi la cagion di tua morte, e di così naturale e nuova grandezza ripiena, che ai nostri tempi dove né vivere né morire da grandi mai non si può, parmi, direi così, che la natura in te solo sfoggiando impreso abbia a deridere le tirannidi nostre; col tuo chiaro esempio mostrando, che ogni picciol tetto può esser campo a magnanimità e virtù, ancorché ad esse tolto ne venga ogni altro pubblico campo. E se il dolore di un fratello semplicemente di sangue, e non di virtù, cotanto pure potea nella ben nata e calda tua anima, chi negarmi ardirà, che tu, in altra più felice contrada nato, per la patria, per la virtù, e per la verace gloria, di ogni più sublime sforzo non saresti stato capace?
FRANCESCO
Deh, basti. Non so se il solo dolore del premorto fratello mi uccidesse, e nol credo; ma certo il mio corpo, già non robustissimo, gran crollo ne riceveva. Doleami il fratello, poco curava io di me stesso, e tu presente non eri; propizio era il punto. All’età mia non m’era possibile oramai di rinascere a vera vita; tu sai che il dolor di non vivere quale potuto forse l’avrei, andava consumando i miei giorni; l’aggiunta dell’estraneo dolore fu quella forse che colmò la misura; e morte, che in petto mi albergava pur sempre, trovò in quelI’istante tutte dischiuse le vie a diffondersi pel debil mio corpo. E ciò fu il meglio per me: alle tante mie noje non v’ho aggiunto vecchiezza, e i suoi fastidj moltissimi.
VITTORIO
Ah, crudele! ma non era già il meglio per me, che nel perderti, la metà, e la migliore, dell’esser mio smarrita ho per sempre; e altro sollievo non serbo, che il sempre pascermi piangendo della tua memoria ed immagine.
FRANCESCO
Doler non mi posso dell’immenso amor tuo; ma ti biasmerò bensì molto del lasciarti così in preda al dolore, e del dirmi, o pensare, che in me tu perdesti la metà del tuo essere. Nel fior de’ tuoi anni; acquistata (ancorché a carissimo prezzo) a te stesso quella libertà, che se a farti vero cittadino insufficiente è pur sempre, poiché tal non sei nato, a non impedirti di essere e dimostrarti uomo pur basta; ed in oltre dolcemente ripieno il tuo cuore di nobile e degno amore; infelice a tai patti reputar non ti dei: né io ti concedo che tu sii colla fortuna tua ingiusto ed ingrato. Che di me ti dolga mi è dolce; poiché il moderato dolore agli animi teneri e grandi è pascolo, che ad essi anco arreca un loro particolare diletto; ma che tu ten disperi, nol voglio. Assai gran parte ti resta di quelle cose che all’umano cuore più giovano: anzi tutte ti restano, poiché quella stessa santa amistà che tra noi passava, e che pure, nol niego, è così importante e necessario sollievo alla umana miseria, tu la ritrovi tuttora, e sotto più piacevol e lusinghiero aspetto, nel cuore dell’amata tua donna. Con essa delle più alte cose parlare ti è dato; ella tutte le intende, le assapora, le sente. Sovrano impulso al ben fare dal dolce e sublime suo conversare trarrai, e l’hai tratto finora.
VITTORIO
O dolcissimo amico, tu mi parli di cosa, che sola di seguitarti impedivami; argomentar puoi quindi s’io l’ami. Sostegni della mia vita, d’ogni opera mia entrambi voi l’anima siete; e tu, sì, benché tolto dagli occhi miei, tu il sei tuttavia; e se in essa te tutto ritrovato non avessi, i soli legami d’amore a ritenermi in vita eran pochi. Ma spesso, tu il sai, crudelmente costretto son io di lasciarla; e son quelli i momenti terribili del mio più feroce delirio. Di te mi ritrovo io privo per sempre, di essa troppo più a lungo ch’io sostenere nol posso; in preda solamente a me stesso in tal guisa rimasto, me stesso invano ricerco, e non trovo. Ed ecco come alla accesa mia fantasia altro sfogo o rimedio non soccorre, che il pianto, o le rime. Ed ecco come, ora desiando, ora immaginando di vederti e parlarti, io ho vissuti questi due anni dacché mi sei tolto. Ma pur troppo in me sento un funesto presagio che questa prima volta sarà la sola ed ultima, in cui mi fia dato il favellarti e l’udirti: e il crudel fato alle eterne sue leggi per or derogando, quest’una forse conceduta non mi ha, che come un lieve compenso all’inopinato e barbaro modo con cui rapito mi fosti.
FRANCESCO
Vero è, (così pur nol fosse!) che prima ed ultima volta fia questa, in cui scambievolmente vederci ed udirci potremo oramai; ma la fervida memoria che di me tu conservi, mi ti renderà bene spesso presente, ed in parte così verrai a deludere le inesorabili leggi di morte. Dal vano pianto io ti scongiuro dunque a cessare; non ardirò dirti interamente lo stesso quanto alle tue tante rime; sì delle poche che per me hai fatte o farai, sì delle molte, e troppe, che per la tua donna scrivesti e scrivi tuttora. Ma siccome tu fama da esse non pretendi né aspetti, più nobile e dolce sfogo della mestizia dell’animo tuo, amichevolmente ti dico che ritrovare non puoi. E molto mi piace che dell’amata tua donna, più assai che i crin d’oro e i negr’occhi, ne vai laudando la candidissima alma, il dolce costume, gli alti sensi, e il nobile acuto e modesto ingegno. Ma sieno, ten prego, codeste rime il tuo pensiero secondo; le tragedie vadano innanzi; e pensa, che alla nostra Italia ben altramente bisognano altezza d’animo e forza, che non soavità di sospiri. Non ti stancare di adoperar sovr’esse la lima penosa; e un certo discreto numero non ne eccedere. Il bollore degli anni impiegato hai finora nel bollor del creare; i rimanenti, che l’età intiepidisce più sempre, alla freddezza della lima consecrali; e, per ultimo prego mio, cui ben fitto ti scongiuro di sempre portarti nel cuore, giunto che sarai ad una certa discreta età, conosciti e datti per vecchio, anche anzi d’esserlo; e le Muse abbandona, prima ch’elle ti lascino. Né in ciò ti voglio concedere che coi più grandi scrittori tu pecchi; convinto sii, che varcato dall’uomo il nono lustro, o poco più in là, ogni poeta che scrive, va togliendo a sé stesso la già acquistata fama.
VITTORIO
Il nobile e giusto consiglio, che interamente pure al mio pensare si adatta, da te riconoscere il voglio, e, come d’ogni altro tuo prego, a me far di questo una legge inviolabile. Due cose sole a chiederti mi rimane; ed è l’una; se non isdegneresti che io in alcuna parte ti ponessi una semplice marmorea lapide, con sopravi poche parole, ove testimoniando al mondo il mio immenso amore per te, il tuo alto valore almen vi accennassi.
FRANCESCO
Negar non tel voglio, se ciò al tuo dolore è sollievo; ma se con ciò speri di farmi più noto al mondo, ti pregherò pur di nol fare. Ad ogni uomo si pongono tutto dì delle lapidi, e inosservate meritamente elle passano. Ogni, anche ottimo verso, che sulla tomba di un estinto si legga, non equivale mai al semplice nome di chi alcuna chiara cosa operava: nulla rimane di chi nulla fece, ancorché vi si sforzi in contrario ogni più alto ingegno. Tomba dunque assai degna, e la sola ch’io brami, ottenuta ho io finché voi vivete, nel tuo cuore, e nell’altro, che al tuo sì strettamente allacciato è per sempre. Estinti voi, con voi non dorrammi di affatto perire, se così vuole il vostro destino: ma se la fama pure delle opere tue dal sepolcro ti trae, quella picciola parte di essa me ne basta che disgiungersi non può dalla tua in chi tanto amasti, e cotanto ti amava.
VITTORIO
Noi dunque quanto alla lapide seguiteremo il dettato del nostro addolorato cuore; senza scordarci però della sublimità vera di questi tuoi ultimi detti.
L’estremo mio prego, di cui sconsolato oltre modo ne andrei se a me tu il negassi, si è, che ti piaccia concedermi che io intitoli al tuo per me sacro nome la mia Congiura de’ Pazzi; tragedia, in cui quanto più altamente ho saputo, quei sensi stessi ho spiegati, che dal tuo infiammato petto sì spesse volte prorompere udiva con energia e brevità tanta di maschie e sugose parole.
FRANCESCO
Ciò che in codesta tragedia non debolmente, parmi, esprimesti, non nego io d’averlo già fortemente sentito; ed in ciò eravamo noi pari: ma ella è ben tua la tragedia, e come cosa tua, e degna di te, l’accetto io; e come cara e somma dimostrazione del tuo affetto la tengo; purché con troppe laudi non vogli in quella dedica più onore né parte ascriverne a me, di quello che a me se ne aspetti. In vita, rimembrami, di ciò ti parlava fin da quando a me destinata l’avevi, e ricevutala io; benché le fortissime verità che là entro si leggono, poteano di danno riuscirmi non lieve, finché costretto era io di vivermi entro il mio carcer natio: alla tirannide, il sai, non meno dispiace chi dire osa il vero, che chi riceverlo ardisce. Ma tu, amico mio non meno discreto che caldo, tra le altre ragioni per cui ne sospendesti la stampa, fu anche una quella, di non volermi, né la tragedia datami togliere, né, col darmela, intorbidare in parte nessuna la tranquillità, o per dir meglio, il sopore della servile e tremante mia vita. Tu, generoso, per me ti assumesti di esser timido e vile; ed assai forte prova, in ciò fare, della tua rara ed immensa amicizia mi davi. Ma pure, tu il sai, che io a ricevere la tragedia tua era pronto; e che ogni mio danno, se toccarmene alcun men dovea, io riputava guadagno, qualor per te lo soffriva.
VITTORIO
Il pianto mi strappi dal cuore; parlare, né respirare più quasi non posso. Ogni tuo consiglio prego e volere, sarà pienamente adempito da me… Ma, oimè! già già ti dilegui !… Deh, ti arresta;… odimi ancora…
FRANCESCO
Tutto udii; tutto dissi. Irresistibile forza dagli occhi tuoi mi sottrae. Felice vivi, e possanza nessuna di tempo dal tuo cor mi scancelli.
FINE DEL DIALOGO
SONETTI
I.
Posto avea di mia vita assai gran parte
Nella soave tua schietta amistade;
E mi sei tolto in assai verde etade,
Mentr’io credei per pochi dì lasciarte!
Dalla tua propria man vergate carte
Mi fean vivere in tutta securtade;
Quando, improvviso, come il fulmin cade,
Giunge la nuova che lo cor mi parte.
Chi pensato l’avrebbe? in dirti addio,
Era l’estremo! e rivederti io mai
Più non doveva in questo mondo rio!
Ma, sugli occhi pur troppo ognor mi stai;
E vie più caldo accendi in me il desio
Delle virtù, che in te solo trovai.
II.
Oh più assai che Fenice amico raro,
Che amavi me, nulla da me volendo;
Che di vita tempravi a me l’amaro
Meco i miei studj e i pianti dividendo;
Deh, sapess’io laudarti in stil sì chiaro,
Che dal sepolcro il tuo nome traendo,
Io nel mandassi riverito e caro
All’altre età, cui di piacer più intendo!
Ciò per te stesso far potuto avresti
Meglio assai ch’io, se avversi i tempi e il loco
Non t’eran, dove occulti dì vivesti.
Ben d’ingiusta fortuna è crudo il giuoco;
Voler che il fango vile in luce resti,
E ignoto e muto il più sublime fuoco.
III.
Oltre all’ottavo lustro un anno appena
Varcando iva lo amico del mio cuore,
Quando il fratello suo morendo il mena
Seco in tomba, sì grave ei n’ha dolore.
Eppur l’infermo, che duo dì premuore,
Doppio aver lascia e libertade piena
Al mio, che esemplo di fraterno amore,
Perde a sì fera vista e polso e lena.
Né già gli è tolto nel german l’amico;
Ancor ch’ottimi entrambi, eran dispari
D’alma, d’ingegno, d’indole, e di brama.
Pietà fu sola (e in ver, del tempo antico)
Che orbato ha Siena, e me, d’uno dei rari,
Ch’ebber alte virtudi, ed umil fama.
IV.
Era l’amico, che il destin mi fura,
Picciol di corpo, e di leggiadre forme;
Brune chiome, occhi ardenti, atto conforme;
E scritto in viso: Io son d’alta natura.
Liberissimo spirto in prigion dura
Nato, ei vi stava qual leon che dorme;
Ma il viver nostro fetido e difforme
Ben conoscea quell’alma ardita e pura.
Null’uom quasi apprezzando, (a dritto forse)
Nullo pur ne odïava; e a tutti umano,
Sol ben oprando ei stesso, i rei rimorse.
Troppa era ei macchia al guasto mondo insano:
Invidia, credo, i lividi occhi torse,
E a Morte cruda lo accennò con mano.
V.
Deh! Torna spesso entro a’ miei sogni, o solo
Vero amico ch’io avessi al mondo mai:
Deh! dal tuo avello torna a udir mie’ guai;
Che il pianger teco a me pur scema il duolo.
Fuor del carcer terren seguìto a volo
Ti avrei quel dì, che a forza io mi strappai
Dall’amata; quel dì, ch’io invan chiamai
Te, cui già muto racchiudeva il suolo:
Ma colei che dell’uom sempre s’indonna,
Speme, vuol ch’io sorviva, e aspetti l’ora,
Che riunir dovrammi alla mia donna.
Fra noi ti alberga, ombra adorata, allora.
Calda memoria in noi mai non assonna;
Che, te vivo, in tre corpi un’alma fora.
Vittorio Alfieri