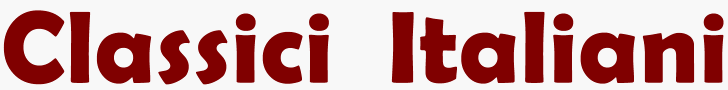Giacomo Leopardi.
Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica.
|
Note Link esterni |
Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica.
Introduzione. Commento di Riccardo Nania
Nonostante sia impossibile riportare il contenuto di un’illustre opera come il Discorso di un italiano sopra la poesia romantica in un banale testo di sintesi, senza mortificarne la forma eccelsa, desidero tentare di mettere in luce le parti salienti di tale opera. Con la stesura del Discorso, Leopardi dimostra la sua volontà di partecipare all’acceso dibattito tra classicisti e romantici sorto in seguito alla pubblicazione dell’articolo di Madam de Staël del 1816. Come ha fatto Pietro Giordani, egli prende le parti dei classicisti e, desideroso di mettere in luce la vacuità e le “scelleratezze” della poesia romantica (da lui definita misera e vana), passa in rassegna le principali teorie dei romantici e le smonta una ad una. Innanzitutto sottolinea la prima incongruenza del loro sistema: essi accusano i classicisti di restare ancorati al passato, disprezzano la loro imitazione di modelli greci e latini e si autodefiniscono “moderni”, quando in realtà loro stessi attingono a piene mani dalle culture nordiche e orientali e sono tutt’altro che moderni e originali. Poi, si occupa della teoria dell’Illusione poetica. I Romantici sostengono che quella degli antichi sia una poesia ingenua, e quella dei moderni sentimentale: mentre gli antichi, poveri di nozioni scientifiche, erano parte integrante della natura e non percepivano un distacco con essa, i moderni vivono in un mondo pervaso dalla tecnologia, in un ambiente artificiale, e vedono, di conseguenza, la natura come un bene perduto. La consapevolezza di tale perdita, del distacco, sta alla base della poesia moderna, una poesia sentimentale. Ed è proprio qui il grossolano errore dei Romantici che Leopardi mette in luce: è vero che gli antichi, poveri di nozioni scientifiche, erano ingenui nell’interpretare la natura e i suoi fenomeni e si lasciavano ingannare sul piano dell’intelletto, ma tale ingenuità e tale inganno ricevuto non stanno alla base della poesia. La poesia antica, a differenza di quanto sostengono i romantici, può esistere anche con la scienza del mondo moderno, in quanto il poeta non inganna l’intelletto, ma già da tempi remotissimi inganna la fantasia.
L’illusione poetica non riguarda, quindi, l’intelletto, ma l’immaginazione, e la poesia non è ricevuta passivamente da un lettore che viene ingannato sul piano dell’intelletto, bensì consiste in una libera scelta del lettore che desidera farsi ingannare sul piano della fantasia, facoltà che resterà uguale per sempre. L’inganno dell’intelletto può avvenire soltanto in un lettore ignorante, ed è per questo che Leopardi sostiene l’istanza classica dell’aristocrazia intellettuale, cioè della fruizione della poesia soltanto da parte di chi è abbastanza colto da apprezzarla. “ Il volgo non deve fruire della poesia, si lascia ingannare nell’intelletto, non solo nell’immaginazione: la poesia non debba essere popolare” dice il conte. Il poeta riporta l’uomo nella sua fantasia allo stato primitivo, lo pone nell’atavica condizione di poter contemplare la natura e riceverne diletto: è dunque artefice di illusioni.
Il poeta, affinché persegua il suo scopo di farsi artefice di illusioni nella fantasia del lettore, deve imitare la natura, seguendo determinate regole. Nella loro imitazione poetica, i Romantici cercano negli oggetti il singolare, qualcosa di raro e poco noto alla moltitudine, cose che pochi hanno veduto o sentito, avvenimenti che poche volte succedono: cercano “ col candelino”, quelle più strane cose che si possono immaginare, le stravaganze. E, nella loro spasmodica ricerca del singolare, sfociano nell’imitazione di cose vili, oscene, fetide e schifose, non affatto straordinarie.
I poeti romantici rappresentano la natura nella sua orridezza, quello da loro chiamato il sublime, mentre i classicisti colgono la natura nel suo equilibrio e nella sua armonia, nella sua perfezione: sono fautori di una poesia bella davvero, non semplicemente sorprendente. Gli antichi, dice Leopardi, tessevano una poesia naturalmente sentimentale, spontanea, vereconda e ignara di se medesima: il cuore dettava loro la poesia. I romantici, invece, spremono il cuore, e il sentimentale è manifestamente voluto, consapevole di se stesso e vanaglorioso. La vera sensibilità non è sfacciata, ma timida, cerca le tenebre e non la luce, mentre quella romantica è contaminata e corrotta.
I Romantici, come ho detto prima, pretendono di generare sentimenti proponendo al lettore soggetti singolari, per usare un eufemismo, oggetti lontani dalla sensibilità comune, in cui nessuno può identificarsi. Ma in realtà, sottolinea Leopardi, il diletto poetico scaturisce soltanto dalla somiglianza che il lettore trova tra se stesso e l’oggetto della poesia. Occorre un legame empatico tra lettore e oggetto della poesia: a esempio di ciò, Leopardi propone dei versi di Byron, a suo avviso obbrobriosi, in cui è cantata una rosa che “arrossisce” alla vista dell’usignolo di cui è innamorata. In tale finzione, il poeta non ha fatto altro che trasformare la rosa in una donna, in quanto, nell’immaginazione di chiunque, prima che la rosa possa arrossire o compiere qualunque altra azione umana come un sospiro, deve trasformarsi in essere umano: Lord Byron e gli altri Romantici pretendono la realizzazione di una poesia in cui da un oggetto nascano immediatamente dei sentimenti, ma ciò è impossibile perché nell’uomo nasce un sentimento soltanto nel rapporto con entità simili a lui: prima che si possa provare qualche emozione per un oggetto inanimato, occorre che il poeta vi dia un’anima. La pretesa romantica di un’immediata trasformazione da oggetto a sentimento risulta impossibile e il sublime romantico, nella sua orrida maestosità ed enorme lontananza dall’umano, non può di certo generare sentimenti. Il poeta deve quindi imitare qualcosa che il lettore senta vicino, o perlomeno dare a questa cosa una connotazione che faccia nascere nel lettore un confronto con se stesso: tutto ciò, come ho detto prima, seguendo le leggi e difficoltà della poesia; altrimenti si sfocia nel triviale, e il poeta altro non è che una macchina che riproduce ciò che vede. E se la poesia romantica, come ribadisce più volte il conte, trova in quegli anni numerosi consensi, è solo perché è un nuovo genere.
” Avviene che taluno stufo del dolce sia più dilettato dall’amaro, diremo per questo che l’amaro sia meglio del dolce?” dice Leopardi. L’amara poesia romantica è più apprezzata della dolce classica meramente per la novità.
Per concludere in merito all’infondatezza delle teorie dei romantici, tratterò l’accusa di pedanteria, rivolta ai classicisti. Il bello eterno, secondo Leopardi, non esiste.
“Tutto noia si fa, l’amore e il suono
E i dolci canti e i graziosi balli.”
Dice Omero. E “nessuna cosa è tanto bella né piacevole che a lungo andare non annoi: così la nostra maniera poetica, per quanto dilettevole e prossima al divino, può tediare senza fallo” dice Leopardi. L’essere classicista, spiega il conte, non significa, dunque, copiare i poeti antichi, non significa osservare ciecamente regole e precetti, accettare dogmaticamente tutto ciò che è stato fatto da loro, essere schiavi e ignavi. Il poeta deve piuttosto avere in comune col poeta antico l’imitazione della natura, la sola e stessa natura che hanno in comune, ma deve imitare in maniera originale: tutti i grandi maestri, infatti, sono simili tra loro, ma allo stesso tempo diversi, perché ognuno interpreta con il suo genio, sulla base del sentire comune del suo tempo, del contesto in cui scrive, della propria personalità, diverse sfumatura della natura e colora tali sfumature con il suo talento personale.
Cambia il mondo e di conseguenza, anche la poesia, ma ciò che deve essere eterno è il substrato all’interno di ogni coscienza poetica, il modo classico di vedere il mondo. L’accusa di essere pedanti, di copiare sterilmente gli illustri predecessori è infondata e , dice il conte, proprio l’accanimento contro i pedanti, molto diffuso in quegli anni, è l’unica vera pedanteria, e ancora più pedante risulta l’accettare letteratura straniera soltanto perché alcuni tedeschi e inglesi la accolgono con entusiasmo, soltanto perché lo si vede fare agli altri.
Al giorno d’oggi, l’atteggiamento che dilaga nell’italiano medio di disprezzare il proprio paese, ripetere sempre che non c’è lavoro e non c’è alcuna strada da percorrere, quasi come un disco rotto, ha di certo la stessa natura della pedanteria ai tempi di Leopardi.
Leggendo le parole del conte, mi rendo conto che tale modo di pensare è fortemente radicato nella mentalità degli italiani: non c’è da stupirsi, capita spesso che l’insicurezza porti a cambiare il meglio con il peggio: il peggio si impone con prepotenza, attacca il timido meglio e lo soggioga. Un esempio banale è quello della diffusione dei costumi alimentari anglosassoni a scapito della dieta mediterranea: è scientificamente provato che quest’ultima sia preferibile a quella inglese e americana, per la salute e la forma fisica e tuttavia nelle nostre tavole sempre più spesso a salutari piatti italiani si sostituiscono pietanze straniere nocive.
Che si tratti di cibo o di poesia, alla base di tutto ciò c’è la scarsa considerazione che l’italiano ha di sé, lo scarso valore che l’Italia dà a se stessa. A questo proposito, il Discorso di un italiano sopra la poesia romantica non è da ritenere soltanto un testo scolastico, una mera forma di erudizione, bensì è un importante messaggio ai posteri: non vergogniamoci di essere italiani, non soccombiamo nel confronto con altri paesi, ma difendiamo la nostra patria e, soprattutto, non sfociamo nella pedante ripetizione che il nostro è un paese finito. Non sputiamo sulla nostra terra, non disprezziamo la nostra culla natale, non disdegniamo noi stessi, non denigriamo la nostra bella nazione. Amiamola piuttosto, e cerchiamo di rilanciarla. Noi possiamo fare la differenza.
Riccardo Nania