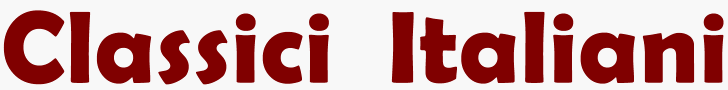La coscienza di Zeno. Capitolo 8. Psico-analisi
Prima pubblicazione: 1º maggio 1923, Premiato Stabilimento tipografico Licinio Cappelli in Rocca di San Casciano (FC).
Note
Diritti d’autore: no
Edizione di riferimento: Italo Svevo, Romanzi, Einaudi-Gallimard, Torino 1993 .
Capitolo 8. Psico-analisi
3 Maggio 1915
L’ho finita con la psico-analisi. Dopo di averla praticata assiduamente per sei mesi interi sto peggio di prima. Non ho ancora congedato il dottore, ma la mia risoluzione è irrevocabile. Ieri intanto gli mandai a dire ch’ero impedito, e per qualche giorno lascio che m’aspetti. Se fossi ben sicuro di saper ridere di lui senz’adirarmi, sarei anche capace di rivederlo. Ma ho paura che finirei col mettergli le mani addosso.
In questa città, dopo lo scoppio della guerra, ci si annoia più di prima e, per rimpiazzare la psico-analisi, io mi rimetto ai miei cari fogli. Da un anno non avevo scritto una parola, in questo come in tutto il resto obbediente alle prescrizioni del dottore il quale asseriva che durante la cura dovevo raccogliermi solo accanto a lui perché un raccoglimento da lui non sorvegliato avrebbe rafforzati i freni che impedivano la mia sincerità, il mio abbandono. Ma ora mi trovo squilibrato e malato più che mai e, scrivendo, credo che mi netterò più facilmente del male che la cura m’ha fatto. Almeno sono sicuro che questo è il vero sistema per ridare importanza ad un passato che più non duole e far andare via più rapido il presente uggioso.
Tanto fiduciosamente m’ero abbandonato al dottore che quando egli mi disse ch’ero guarito, gli credetti con fede intera e invece non credetti ai miei dolori che tuttavia m’assalivano. Dicevo loro: «Non siete mica voi!». Ma adesso non v’è dubbio! Son proprio loro! Le ossa delle mie gambe si sono convertite in lische vibranti che ledono la carne e i muscoli.
Ma di ciò non m’importerebbe gran fatto e non è questa la ragione per cui lascio la cura. Se le ore di raccoglimento presso il dottore avessero continuato ad essere interessanti apportatrici di sorprese e di emozioni, non le avrei abbandonate o, per abbandonarle, avrei atteso la fine della guerra che m’impedisce ogni altra attività. Ma ora che sapevo tutto, cioè che non si trattava d’altro che di una sciocca illusione, un trucco buono per commuovere qualche vecchia donna isterica, come potevo sopportare la compagnia di quell’uomo ridicolo, con quel suo occhio che vuole essere scrutatore e quella sua presunzione che gli permette di aggruppare tutti i fenomeni di questo mondo intorno alla sua grande, nuova teoria? Impiegherò il tempo che mi resta libero scrivendo. Scriverò intanto sinceramente la storia della mia cura. Ogni sincerità fra me e il dottore era sparita ed ora respiro. Non m’è più imposto alcuno sforzo. Non debbo costringermi ad una fede né ho da simulare di averla. Proprio per celare meglio il mio vero pensiero, credevo di dover dimostrargli un ossequio supino e lui ne approfittava per inventarne ogni giorno di nuove. La mia cura doveva essere finita perché la mia malattia era stata scoperta. Non era altra che quella diagnosticata a suo tempo dal defunto Sofocle sul povero Edipo: avevo amata mia madre e avrei voluto ammazzare mio padre.
Né io m’arrabbiai! Incantato stetti a sentire. Era una malattia che mi elevava alla più alta nobiltà. Cospicua quella malattia di cui gli antenati arrivavano all’epoca mitologica! E non m’arrabbio neppure adesso che sono qui solo con la penna in mano. Ne rido di cuore. La miglior prova ch’io non ho avuta quella malattia risulta dal fatto che non ne sono guarito. Questa prova convincerebbe anche il dottore. Se ne dia pace: le sue parole non poterono guastare il ricordo della mia giovinezza. Io chiudo gli occhi e vedo subito puro, infantile, ingenuo, il mio amore per mia madre, il mio rispetto ed il grande mio affetto per mio padre.
Il dottore presta una fede troppo grande anche a quelle mie benedette confessioni che non vuole restituirmi perché le riveda. Dio mio! Egli non studiò che la medicina e perciò ignora che cosa significhi scrivere in italiano per noi che parliamo e non sappiamo scrivere il dialetto. Una confessione in iscritto è sempre menzognera. Con ogni nostra parola toscana noi mentiamo! Se egli sapesse come raccontiamo con predilezione tutte le cose per le quali abbiamo pronta la frase e come evitiamo quelle che ci obbligherebbero di ricorrere al vocabolario! È proprio così che scegliamo dalla nostra vita gli episodi da notarsi. Si capisce come la nostra vita avrebbe tutt’altro aspetto se fosse detta nel nostro dialetto.
Il dottore mi confessò che, in tutta la sua lunga pratica, giammai gli era avvenuto di assistere ad un’emozione tanto forte come la mia all’imbattermi nelle immagini ch’egli credeva di aver saputo procurarmi. Perciò anche fu tanto pronto a dichiararmi guarito.
Ed io non simulai quell’emozione. Fu anzi una delle più profonde ch’io abbia avuta in tutta la mia vita. Madida di sudore quando l’immagine creai, di lagrime quando l’ebbi. Io avevo già adorata la speranza di poter rivivere un giorno d’innocenza e d’ingenuità. Per mesi e mesi tale speranza mi resse e m’animò. Non si trattava forse di ottenere col vivo ricordo in pieno inverno le rose del Maggio? Il dottore stesso assicurava che il ricordo sarebbe stato lucente e completo, tale che avrebbe rappresentato un giorno di più della mia vita. Le rose avrebbero avuto il loro pieno effluvio e magari anche le loro spine.
È così che a forza di correr dietro a quelle immagini, io le raggiunsi. Ora so di averle inventate. Ma inventare è una creazione, non già una menzogna. Le mie erano delle invenzioni come quelle della febbre, che camminano per la stanza perché le vediate da tutti i lati e che poi anche vi toccano. Avevano la solidità, il colore, la petulanza delle cose vive. A forza di desiderio, io proiettai le immagini, che non c’erano che nel mio cervello, nello spazio in cui guardavo, uno spazio di cui sentivo l’aria, la luce ed anche gli angoli contundenti che non mancarono in alcuno spazio per cui io sia passato.
Quando arrivai al torpore che doveva facilitare l’illusione e che mi pareva nient’altro che l’associazione di un grande sforzo con una grande inerzia, credetti che quelle immagini fossero delle vere riproduzioni di giorni lontani. Avrei potuto sospettare subito che non erano tali perché, appena svanite, le ricordavo, ma senz’alcun’eccitazione o commozione. Le ricordavo come si ricorda il fatto raccontato da chi non vi assistette. Se fossero state vere riproduzioni avrei continuato a riderne e a piangerne come quando le avevo avute. E il dottore registrava. Diceva: «Abbiamo avuto questo, abbiamo avuto quello». In verità, noi non avevamo più che dei segni grafici, degli scheletri d’immagini.
Fui indotto a credere che si trattasse di una rievocazione della mia infanzia perché la prima delle immagini mi pose in un’epoca relativamente recente di cui avevo conservato anche prima un pallido ricordo ch’essa parve confermare. C’è stato un anno nella mia vita in cui io andavo a scuola e mio fratello non ancora. E pareva fosse appartenuta a quell’anno l’ora che rievocai. Io mi vidi uscire dalla mia villa una mattina soleggiata di primavera, passare per il nostro giardino per scendere in città, giù, giù, tenuto per mano da una nostra vecchia fantesca, Catina. Mio fratello nella scena che sognai non appariva, ma ne era l’eroe. Io lo sentivo in casa libero e felice mentre io andavo a scuola. Vi andavo coi singhiozzi nella gola, il passo riluttante e, nell’animo, un intenso rancore. Io non vidi che una di quelle passeggiate alla scuola, ma il rancore nel mio animo mi diceva che ogni giorno io andavo a scuola ed ogni giorno mio fratello restava a casa. All’infinito, mentre in verità credo che, dopo non lungo tempo, mio fratello più giovine di me di un anno solo, sia andato a scuola anche lui. Ma allora la verità del sogno mi parve indiscutibile: io ero condannato ad andare sempre a scuola mentre mio fratello aveva il permesso di restare a casa. Camminando a canto a Catina calcolavo la durata della tortura: fino a mezzodì! Mentre lui è a casa! E ricordavo anche che nei giorni precedenti dovevo essere stato turbato a scuola da minaccie e rampogne e che io avevo pensato anche allora: a lui non possono toccare. Era stata una visione di un’evidenza enorme. Catina che io avevo conosciuta piccola, m’era parsa grande, certamente perché io ero tanto piccolo. Vecchissima m’era sembrata anche allora, ma si sa che i giovanissimi vedono sempre vecchi gli anziani. E sulla via che io dovevo percorrere per andare a scuola, scorsi anche i colonnini strani che arginavano in quel tempo i marciapiedi della nostra città. Vero è che io nacqui abbastanza presto per vedere ancora da adulto quei colonnini nelle nostre vie centriche. Ma nella via che io con Catina quel giorno percorsi, non ci furono più non appena io uscii dall’infanzia.
La fede nell’autenticità di quelle immagini perdurò nel mio animo anche quando, presto, stimolata da quel sogno, la mia fredda memoria scoperse altri particolari di quell’epoca. Il principale: anche mio fratello invidiava me perché io andavo a scuola. Ero sicuro d’essermene avvisto, ma non subito ciò bastò ad infirmare la verità del sogno. Più tardi gli tolse ogni aspetto di verità: la gelosia in realtà c’era stata, ma nel sogno era stata spostata.
La seconda visione mi riportò anch’essa ad un’epoca recente, benché anteriore di molto a quella della prima: una stanza della mia villa, ma non so quale, perché più vasta di qualunque altra che vi è realmente. È strano che io mi vedevo chiuso in quella stanza e che subito ne seppi un particolare che dalla semplice visione non poteva essere risultato: la stanza era lontana dal posto ove allora soggiornavano mia madre e Catina. Ed un secondo: io ancora non sono stato a scuola.
La stanza era tutta bianca ed anzi io non vidi giammai una stanza tanto bianca né tanto completamente illuminata dal sole. Il sole di allora passava traverso le pareti? Esso era certamente già alto, ma io mi trovavo tuttavia nel mio letto con in mano una tazza da cui avevo sorbito tutto il caffelatte e nella quale continuavo a lavorare con un cucchiaino traendone lo zucchero. Ad un certo punto il cucchiaio non arrivò più a raccoglierne altro ed allora io tentai di arrivare al fondo della tazza con la mia lingua. Ma non vi riuscii. Perciò finii col tenere la tazza in una mano e il cucchiaio nell’altra e stetti a guardare mio fratello coricato nel letto accanto al mio come, tardivo, stava ancora sorbendo il suo caffè col naso nella tazza. Quando levò finalmente la faccia, io la vidi tutta come si contrasse ai raggi del sole che la colpirono in pieno mentre la mia (Dio ne sa il perché) si trovava nell’ombra. Il suo viso era pallido ed un poco imbruttito da un lieve prognatismo. Mi disse:
– Mi presti il tuo cucchiaio?
Allora appena m’avvidi che Catina aveva dimenticato di portargli il cucchiaio. Subito e senz’alcuna esitazione gli risposi:
– Sì! Se mi dài in compenso un poco del tuo zucchero.
Tenni in alto il cucchiaio per farne rilevare il valore. Ma subito la voce di Catina risuonò nella stanza:
– Vergogna! Strozzino!
Lo spavento e la vergogna mi fecero ripiombare nel presente. Avrei voluto discutere con Catina, ma lei, mio fratello ed io, come ero fatto allora, piccolo, innocente e strozzino, sparimmo ripiombando nell’abisso.
Rimpiansi di aver sentita tanto forte quella vergogna da aver distrutta l’immagine cui ero arrivato con tanta fatica. Avrei fatto tanto bene di offrire invece mitemente e gratis il cucchiaino e non discutere quella mia mala azione ch’era probabilmente la prima che avessi commessa. Forse Catina avrebbe invocato l’ausilio di mia madre per infliggermi una punizione ed io finalmente l’avrei rivista.
La vidi però pochi giorni appresso o credetti di rivederla. Avrei potuto intendere subito ch’era un’illusione perché l’immagine di mia madre, come l’avevo evocata, somigliava troppo al suo ritratto che ho sul mio letto. Ma devo confessare che nell’apparizione mia madre si mosse come una persona viva.
Molto, molto sole, tanto da abbacinare! Da quella ch’io credevo la mia giovinezza mi perveniva tanto di quel sole ch’era difficile dubitare non fosse dessa. Il nostro tinello nelle ore pomeridiane. Mio padre è ritornato a casa e siede su un sofà accanto a mamma che sta imprimendo con certo inchiostro indelebile delle iniziali su molta biancheria distribuita sul tavolo a cui essa siede. Io mi trovo sotto il tavolo dove giuoco con delle pallottole. M’avvicino sempre più a mamma. Probabilmente desidero ch’essa s’associ ai miei giuochi. A un dato punto, per rizzarmi in piedi fra di loro, m’aggrappo alla biancheria che pende dal tavolo e allora avviene un disastro. La boccetta d’inchiostro mi capita sulla testa, bagna la mia faccia e le mie vesti, la gonna di mamma e produce una lieve macchia anche sui calzoni di papà. Mio padre alza una gamba per appiopparmi un calcio…
Ma io in tempo ero ritornato dal mio lontano viaggio e mi trovavo al sicuro qui, adulto, vecchio. Devo dirlo! Per un istante soffersi della punizione minacciatami e subito dopo mi dolse di non aver potuto assistere all’atto di protezione che senza dubbio sarà partito da mamma. Ma chi può arrestare quelle immagini quando si mettono a fuggire traverso quel tempo che giammai somigliò tanto allo spazio? Quest’era il mio concetto finché credetti nell’autenticità di quelle immagini! Ora, purtroppo (oh! quanto me ne dolgo!) non ci credo più e so che non erano le immagini che correvano via, ma i miei occhi snebbiati che guardavano di nuovo nel vero spazio in cui non c’è posto per fantasmi.
Racconterò ancora delle immagini di un altro giorno alle quali il dottore attribuì tale importanza da dichiararmi guarito.
Nel mezzo sonno cui m’abbandonai ebbi un sogno dall’immobilità dell’incubo. Sognai di me stesso ridivenuto bambino e soltanto per vedere quel bambino come sognava anche lui. Giaceva muto in preda ad una letizia che pervadeva il suo minuto organismo. Gli pareva di aver finalmente raggiunto il suo antico desiderio. Eppure giaceva là solo e abbandonato! Ma vedeva e sentiva con quell’evidenza come si sa vedere e sentire nel sogno anche le cose lontane. Il bambino, giacendo in una stanza della mia villa, vedeva (Dio sa in quale modo) che sul tetto della stessa ci fosse una gabbia murata su basi solidissime, priva di porte e di finestre, ma illuminata di quanta luce può far piacere e fornita di aria pura e profumata. Ed il bambino sapeva che a quella gabbia egli solo avrebbe saputo giungere e senza neppur andare perché forse la gabbia sarebbe venuta a lui. In quella gabbia non v’era che un solo mobile, una poltrona e su questa sedeva una donna formosa, costruita deliziosamente, vestita di nero, bionda, dagli occhi grandi e azzurri, le mani bianchissime e i piedi piccoli in scarpine laccate delle quali, di sotto alle gonne, sporgeva solo un lieve bagliore. Devo dire che quella donna mi pareva una cosa sola col suo vestito nero e le sue scarpine di lacca. Tutto era lei! Ed il bambino sognava di possedere quella donna, ma nel modo più strano: era sicuro cioè di poter mangiarne dei pezzettini al vertice e alla base.
Adesso, pensandoci, sono stupito che il dottore che ha letto, a quanto ne dice, con tanta attenzione il mio manoscritto non abbia ricordato il sogno ch’io ebbi prima di andar a raggiungere Carla. A me qualche tempo dopo, quando ci ripensai, parve che questo sogno non fosse altro che l’altro un po’ variato, reso più infantile.
Invece il dottore registrò accuratamente tutto eppoi mi domandò con aspetto un po’ melenso:
– Vostra madre era bionda e formosa?
Fui stupito della domanda e risposi che anche mia nonna era stata tale. Ma per lui ero guarito, ben guarito. Spalancai la bocca per gioirne con lui e m’adattai a quanto doveva seguire, cioè non più indagini, ricerche, meditazioni, ma una vera e assidua rieducazione.
Da allora quelle sedute furono una vera tortura ed io le continuai solo perché m’è sempre stato tanto difficile di fermarmi quando mi movo o di mettermi in movimento quando son fermo. Qualche volta, quando egli me ne diceva di troppo grosse, arrischiavo qualche obbiezione. Non era mica vero – com’egli lo credeva – che ogni mia parola, ogni mio pensiero fosse di delinquente. Egli allora faceva tanto d’occhi. Ero guarito e non volevo accorgermene! Era una vera cecità questa: avevo appreso che avevo desiderato di portar via la moglie – mia madre! – a mio padre e non mi sentivo guarito? Inaudita ostinazione la mia: però il dottore ammetteva che sarei guarito ancora meglio quando fosse finita la mia rieducazione in seguito alla quale mi sarei abituato a considerare quelle cose (il desiderio di uccidere il padre e di baciare la propria madre) come cose innocentissime per le quali non c’era da soffrire di rimorsi, perché avvenivano frequentemente nelle migliori famiglie. In fondo che cosa ci perdevo? Egli un giorno mi disse ch’io oramai ero come un convalescente che ancora non s’era abituato a vivere privo di febbre. Ebbene: avrei atteso di abituarmivi.
Egli sentiva che non ero ancora ben suo ed oltre alla rieducazione, di tempo in tempo, ritornava anche alla cura. Tentava di nuovo i sogni, ma di autentici non ne ebbimo più alcuno. Seccato di tanta attesa, finii coll’inventarne uno. Non l’avrei fatto se avessi potuto prevedere la difficoltà di una simile simulazione. Non è mica facile di balbettare come se ci si trovasse immersi in un mezzo sogno, coprirsi di sudore o sbiancarsi, non tradirsi, eventualmente diventar vermigli dallo sforzo e non arrossire: parlai come se fossi ritornato alla donna della gabbia e l’avessi indotta a porgermi per un buco improvvisamente prodottosi nella parete dello stanzino un suo piede da succhiare e mangiare. «Il sinistro, il sinistro!», mormorai mettendo nella visione un particolare curioso che potesse farla somigliare meglio ai sogni precedenti. Dimostravo così anche di aver capito perfettamente la malattia che il dottore esigeva da me. Edipo infantile era fatto proprio così: succhiava il piede sinistro della madre per lasciare il destro al padre. Nel mio sforzo d’immaginare realmente (tutt’altro che una contraddizione, questa) ingannai anche me stesso col sentire il sapore di quel piede. Quasi dovetti recere.
Non solo il dottore ma anch’io avrei desiderato di esser visitato ancora da quelle care immagini della mia gioventù, autentiche o meno, ma che io non avevo avuto bisogno di costruire. Visto che accanto al dottore non venivano più, tentai di evocarle lontano da lui. Da solo ero esposto al pericolo di dimenticarle, ma già io non miravo mica ad una cura! Io volevo ancora rose del Maggio in Dicembre. Le avevo già avute; perché non avrei potuto riaverle?
Anche nella solitudine m’annoiai abbastanza, ma poi, invece delle immagini venne qualche cosa che per qualche tempo le sostituì. Semplicemente credetti di aver fatta un’importante scoperta scientifica. Mi credetti chiamato a completare tutta la teoria dei colori fisiologici. I miei predecessori, Goethe e Schopenhauer, non avevano mai immaginato dove si potesse arrivare maneggiando abilmente i colori complementari.
Bisogna sapere ch’io passavo il mio tempo gettato sul sofà di faccia alla finestra del mio studio donde vedevo un pezzo di mare e d’orizzonte. Ora una sera dal tramonto colorito nel cielo frastagliato di nubi, m’indugiai lungamente ad ammirare su un lembo limpido, un colore magnifico, verde, puro e mite. Nel cielo c’era anche molto color rosso gettato sui margini delle nubi a ponente, ma era un rosso ancora pallido, sbiaccato dai diretti, bianchi raggi del sole. Abbacinato, dopo un certo intervallo di tempo, chiusi gli occhi e si vide che al verde era stata rivolta la mia attenzione, il mio affetto, perché sulla mia rètina si produsse il suo colore complementare, un rosso smagliante che non aveva nulla da fare col rosso luminoso, ma pallido nel cielo. Guardai, accarezzai quel colore fabbricato da me. La grande sorpresa la ebbi quando una volta aperti gli occhi, vidi quel rosso fiammeggiante invadere tutto il cielo e coprire anche il verde smeraldo che per lungo tempo non ritrovai più. Ma io, dunque, avevo scoperto il modo di tingere la natura! Naturalmente l’esperimento fu da me ripetuto più volte. Il bello si è che v’era anche del movimento in quella colorazione. Quando riaprivo gli occhi, il cielo non accettava subito il colore dalla mia rètina. V’era anzi un istante di esitazione nel quale arrivavo ancora a rivedere il verde smeraldo che aveva figliato quel rosso da cui sarebbe stato distrutto. Questo sorgeva dal fondo, inaspettato e si dilatava come un incendio spaventoso.
Quando fui sicuro dell’esattezza della mia osservazione, la portai al dottore nella speranza di ravvivare con essa le nostre noiose sedute. Il dottore mi saldò dicendomi che io avevo la rètina più sensibile causa la nicotina. Quasi mi sarei lasciato scappar detto che in allora anche le immagini, che noi avevamo attribuite a riproduzioni di avvenimenti della mia gioventù, potevano invece esser derivate dall’effetto dello stesso veleno. Ma così gli avrei rivelato che non ero guarito ed egli avrebbe cercato d’indurmi a ricominciare la cura da capo.
Eppure quel bestione non sempre mi credette tanto avvelenato. Ciò viene provato anche dalla rieducazione ch’egli tentò per guarirmi da quella ch’egli diceva la mia malattia del fumo. Ecco le sue parole: il fumo non mi faceva male e quando mi fossi convinto ch’era innocuo sarebbe stato veramente tale. Eppoi continuava: oramai che i rapporti con mio padre erano stati riportati alla luce del giorno e ripresentati al mio giudizio di adulto, potevo intendere che avevo assunto quel vizio per competere con mio padre e attribuito un effetto velenoso al tabacco per il mio intimo sentimento morale che volle punirmi della mia competizione con lui.
Quel giorno lasciai la casa del dottore fumando come un turco. Si trattava di fare una prova ed io mi vi prestai volontieri. Per tutto il giorno fumai ininterrottamente. Seguì poi una notte del tutto insonne. La mia bronchite cronica aveva rifiorito e di quella non c’era dubbio perché era facile scoprirne le conseguenze nella sputacchiera.
Il giorno appresso raccontai al dottore di aver fumato molto e che ora non me ne importava più. Il dottore mi guardò sorridendo e io indovinai che il petto gli si gonfiava dall’orgoglio. Con calma riprese la mia rieducazione! Procedeva con la sicurezza di veder fiorire ogni zolla su cui poneva il piede.
Di quella rieducazione ricordo pochissimo. Io la subii e quando uscivo da quella stanza mi scotevo come un cane ch’esce dall’acqua ed anch’io restavo umido, ma non bagnato.
Ricordo però con indignazione che il mio educatore asseriva che il dottor Coprosich avesse avuto ragione di dirigermi le parole che avevano provocato tanto mio risentimento. Ma allora io avrei meritato anche lo schiaffo che mio padre volle darmi morendo? Non so se egli abbia detto anche questo. So invece con certezza ch’egli asseriva ch’io avessi odiato anche il vecchio Malfenti che avevo messo al posto di mio padre. Tanti a questo mondo credono di non saper vivere senza un dato affetto; io, invece, secondo lui, perdevo l’equilibrio se mi mancava un dato odio. Ne sposai una o l’altra delle figliuole ed era indifferente quale perché si trattava di mettere il loro padre ad un posto dove il mio odio potesse raggiungerlo. Eppoi sfregiai la casa che avevo fatta mia come meglio seppi. Tradii mia moglie ed è evidente che se mi fosse riuscito avrei sedotta Ada ed anche Alberta. Naturalmente io non penso di negare questo ed anzi mi fece da ridere quando dicendomelo il dottore assunse l’aspetto di Cristoforo Colombo allorché raggiunse l’America. Credo però ch’egli sia il solo a questo mondo il quale sentendo che volevo andare a letto con due bellissime donne si domanda: vediamo perché costui vuole andare a letto con esse.
Mi fu anche più difficile di sopportare quello ch’egli credette di poter dire dei miei rapporti con Guido. Dal mio stesso racconto egli aveva appreso dell’antipatia che aveva accompagnato l’inizio della mia relazione con lui. Tale antipatia non cessò mai secondo lui e Ada avrebbe avuto ragione di vederne l’ultima manifestazione nella mia assenza dal suo funerale. Non ricordò ch’io ero allora intento nella mia opera d’amore di salvare il patrimonio di Ada, né io mi degnai di ricordarglielo.
Pare che il dottore a proposito di Guido abbia fatte anche delle indagini. Egli asserisce che, scelto da Ada, egli non poteva essere quale io lo descrissi. Scoperse che un grandioso deposito di legnami, vicinissimo alla casa dove noi pratichiamo la psico-analisi, era appartenuto alla ditta Guido Speier e C. Perché non ne avevo io parlato?
Se ne avessi parlato sarebbe stata una nuova difficoltà nella mia esposizione già tanto difficile. Quest’eliminazione non è che la prova che una confessione fatta da me in italiano non poteva essere né completa né sincera. In un deposito di legnami ci sono varietà enormi di qualità che noi a Trieste appelliamo con termini barbari presi dal dialetto, dal croato, dal tedesco e qualche volta persino dal francese (zapin p.e. e non equivale mica a sapin ). Chi m’avrebbe fornito il vero vocabolario? Vecchio come sono avrei dovuto prendere un impiego da un commerciante in legnami toscano? Del resto il deposito legnami della ditta Guido Speier e C. non diede che delle perdite. Eppoi non avevo da parlarne perché rimase sempre inerte, salvo quando intervennero i ladri e fecero volare quel legname dai nomi barbari, come se fosse stato destinato a costruire dei tavolini per esperimenti spiritistici.
Io proposi al dottore di prendere delle informazioni su Guido da mia moglie, da Carmen oppure da Luciano ch’è un grande commerciante noto a tutti. A mio sapere egli non s’indirizzò a nessuno di costoro e devo credere che se ne astenne per la paura di veder precipitare per quelle informazioni tutto il suo edificio di accuse e di sospetti. Chissà perché si sia preso di tale odio per me? Anche lui dev’essere un istericone che per aver desiderata invano sua madre se ne vendica su chi non c’entra affatto.
Finì che mi sentii molto stanco di quella lotta che dovevo sostenere col dottore ch’io pagavo. Credo che anche quei sogni non m’abbiano fatto bene, eppoi la libertà di fumare quanto volevo finì con l’abbattermi del tutto. Ebbi una buona idea: andai dal dottor Paoli.
Non l’avevo visto da molti anni. Era un po’ incanutito, ma la sua figura di granatiere non era ancora troppo arrotondata dall’età, né piegata. Guardava sempre le cose con un’occhiata che pareva una carezza. Quella volta scopersi perché mi sembrasse così. Evidentemente a lui fa piacere di guardare e guarda le belle e le brutte cose con la compiacenza con cui altri accarezza.
Ero salito da lui col proposito di domandargli se credeva dovessi continuare la psico-analisi. Ma quando mi trovai dinanzi a quel suo occhio, freddamente indagatore, non ne ebbi il coraggio. Forse mi rendevo ridicolo raccontando che alla mia età m’ero lasciato prendere ad una ciarlataneria simile. Mi spiacque di dover tacere, perché se il Paoli m’avesse proibita la psico-analisi, la mia posizione sarebbe stata semplificata di molto, ma mi sarebbe spiaciuto troppo di vedermi troppo a lungo carezzato da quel suo grande occhio.
Gli raccontai delle mie insonnie, della mia bronchite cronica, di un’espulsione alle guancie che allora mi tormentava, di certi dolori lancinanti alle gambe e infine di strane mie smemoratezze.
Il Paoli analizzò la mia orina in mia presenza. Il miscuglio si colorì in nero e il Paoli si fece pensieroso. Ecco finalmente una vera analisi e non più una psico-analisi. Mi ricordai con simpatia e commozione del mio passato lontano di chimico e di analisi vere: io, un tubetto e un reagente! L’altro, l’analizzato, dorme finché il reagente imperiosamente non lo desti. La resistenza nel tubetto non c’è o cede alla minima elevazione della temperatura e la simulazione manca del tutto. In quel tubetto non avveniva nulla che potesse ricordare il mio comportamento quando per far piacere al dottor S. inventavo nuovi particolari della mia infanzia che dovevano confermare la diagnosi di Sofocle. Qui, invece, tutto era verità. La cosa da analizzarsi era imprigionata nel provino e, sempre uguale a se stessa, aspettava il reagente. Quand’esso arrivava essa diceva sempre la stessa parola. Nella psico-analisi non si ripetono mai né le stesse immagini né le stesse parole. Bisognerebbe chiamarla altrimenti. Chiamiamola l’avventura psichica. Proprio così: quando s’inizia una simile analisi è come se ci si recasse in un bosco non sapendo se c’imbatteremo in un brigante o in un amico. E non lo si sa neppure quando l’avventura è passata. In questo la psico-analisi ricorda lo spiritismo.
Ma il Paoli non credeva che si trattasse di zucchero. Voleva rivedermi il giorno appresso dopo di aver analizzato quel liquido per polarizzazione.
Io, intanto, me ne andai glorioso, carico di diabete. Fui in procinto di andare dal dottor S. a domandargli com’egli avrebbe ora analizzato nel mio seno le cause di tale malattia per annullarle. Ma di quell’individuo ne avevo avuto abbastanza e non volevo rivederlo neppure per deriderlo.
Devo confessare che il diabete fu per me una grande dolcezza. Ne parlai ad Augusta ch’ebbe subito le lacrime agli occhi:
– Hai parlato tanto di malattie in tutta la tua vita, che dovevi pur finire coll’averne una! – disse; poi cercò di consolarmi.
Io amavo la mia malattia. Ricordai con simpatia il povero Copler che preferiva la malattia reale all’immaginaria. Ero oramai d’accordo con lui. La malattia reale era tanto semplice: bastava lasciarla fare. Infatti, quando lessi in un libro di medicina la descrizione della mia dolce malattia, vi scopersi come un programma di vita (non di morte!) nei varii suoi stadii. Addio propositi: finalmente ne ero libero. Tutto avrebbe seguito la sua via senz’alcun mio intervento.
Scopersi anche che la mia malattia era sempre o quasi sempre molto dolce. Il malato mangia e beve molto e di grandi sofferenze non ci sono se si bada di evitare i bubboni. Poi si muore in un dolcissimo coma.
Poco dopo il Paoli mi chiamò al telefono. Mi comunicò che non v’era traccia di zucchero. Andai da lui il giorno appresso e mi prescrisse una dieta che non seguii che per pochi giorni e un intruglio che descrisse in una ricetta illeggibile e che mi fece bene per un mese intero.
– Il diabete le ha fatto molta paura? – mi domandò sorridendo.
Protestai, ma non gli dissi che ora che il diabete m’aveva abbandonato mi sentivo molto solo. Non m’avrebbe creduto.
In quel torno di tempo mi capitò in mano la celebre opera del dottor Beard sulla nevrastenia. Seguii il suo consiglio e cambiai di medicina ogni otto giorni con le sue ricette che copiai con scrittura chiara. Per alcuni mesi la cura mi parve buona. Neppure il Copler aveva avuto in vita sua tale abbondante consolazione di medicinali come io allora. Poi passò anche quella fede, ma intanto io avevo rimandato di giorno in giorno il mio ritorno alla psico-analisi.
M’imbattei poi nel dottor S. Mi domandò se avevo deciso di lasciare la cura. Fu però molto cortese, molto più che non quando mi teneva in mano sua. Evidentemente voleva riprendermi. Io gli dissi che avevo degli affari urgenti, delle quistioni di famiglia che mi occupavano e preoccupavano e che non appena mi fossi trovato in quiete sarei ritornato da lui. Avrei voluto pregarlo di restituirmi il mio manoscritto, ma non osai; sarebbe equivaluto a confessargli che della cura non volevo più saperne. Riservai un tentativo simile ad altra epoca quand’egli si sarebbe accorto che alla cura non ci pensavo più e vi si fosse rassegnato.
Prima di lasciarmi egli mi disse alcune parole intese a riprendermi:
– Se lei esamina il suo animo, lo troverà mutato. Vedrà che ritornerà subito a me solo che s’accorga come io seppi in un tempo relativamente breve avvicinarla alla salute.
Ma io, in verità, credo che col suo aiuto, a forza di studiare l’animo mio, vi abbia cacciato dentro delle nuove malattie.
Sono intento a guarire della sua cura. Evito i sogni ed i ricordi. Per essi la mia povera testa si è trasformata in modo da non saper sentirsi sicura sul collo. Ho delle distrazioni spaventose. Parlo con la gente e mentre dico una cosa tento involontariamente di ricordarne un’altra che poco prima dissi o feci e che non ricordo più o anche un mio pensiero che mi pare di un’importanza enorme, di quell’importanza che mio padre attribuì a quei pensieri ch’ebbe poco prima di morire e che pur lui non seppe ricordare.
Se non voglio finire al manicomio, via con questi giocattoli.
15 Maggio 1915
Passammo due giorni di festa a Lucinico nella nostra villa. Mio figlio Alfio deve rimettersi di un’influenza e resterà nella villa con la sorella per qualche settimana. Noi ritorneremo qui per le Pentecoste.
Sono riuscito finalmente di ritornare alle mie dolci abitudini, e a cessar di fumare. Sto già molto meglio dacché ho saputo eliminare la libertà che quello sciocco di un dottore aveva voluto concedermi. Oggi che siamo alla metà del mese sono rimasto colpito della difficoltà che offre il nostro calendario ad una regolare e ordinata risoluzione. Nessun mese è uguale all’altro. Per rilevare meglio la propria risoluzione si vorrebbe finire di fumare insieme a qualche cosa d’altro, il mese p.e. Ma salvo il Luglio e Agosto e il Dicembre e il Gennaio non vi sono altri mesi che si susseguano e facciano il paio in quanto a quantità di giorni. Un vero disordine nel tempo!
Per raccogliermi meglio passai il pomeriggio del secondo giorno solitario alle rive dell’Isonzo. Non c’è miglior raccoglimento che star a guardare un’acqua corrente. Si sta fermi e l’acqua corrente fornisce lo svago che occorre perché non è uguale a se stessa nel colore e nel disegno neppure per un attimo.
Era una giornata strana. Certamente in alto soffiava un forte vento perché le nubi vi mutavano continuamente di forma, ma giù l’atmosfera non si moveva. Avveniva che di tempo in tempo, traverso le nubi in movimento, il sole già caldo trovasse il pertugio per inondare dei suoi raggi questo o quel tratto di collina o una cima di montagna, dando risalto al verde dolce del Maggio in mezzo all’ombra che copriva tutto il paesaggio. La temperatura era mite ed anche quella fuga di nubi nel cielo, aveva qualche cosa di primaverile. Non v’era dubbio: il tempo stava risanando!
Fu un vero raccoglimento il mio, uno di quegl’istanti rari che l’avara vita concede, di vera grande oggettività in cui si cessa finalmente di credersi e sentirsi vittima. In mezzo a quel verde rilevato tanto deliziosamente da quegli sprazzi di sole, seppi sorridere alla mia vita ed anche alla mia malattia. La donna vi ebbe un’importanza enorme. Magari a pezzi, i suoi piedini, la sua cintura, la sua bocca, riempirono i miei giorni. E rivedendo la mia vita e anche la mia malattia le amai, le intesi! Com’era stata più bella la mia vita che non quella dei cosidetti sani, coloro che picchiavano o avrebbero voluto picchiare la loro donna ogni giorno salvo in certi momenti. Io, invece, ero stato accompagnato sempre dall’amore. Quando non avevo pensato alla mia donna, vi avevo pensato ancora per farmi perdonare che pensavo anche alle altre. Gli altri abbandonavano la donna delusi e disperando della vita. Da me la vita non fu mai privata del desiderio e l’illusione rinacque subito intera dopo ogni naufragio, nel sogno di membra, di voci, di atteggiamenti più perfetti.
In quel momento ricordai che fra le tante bugie che avevo propinate a quel profondo osservatore ch’era il dottor S., c’era anche quella ch’io non avessi più tradita mia moglie dopo la partenza di Ada. Anche su questa bugia egli fabbricò le sue teorie. Ma là, alla riva di quel fiume, improvvisamente, con spavento, ricordai ch’era vero che da qualche giorno, forse dacché avevo abbandonata la cura, io non avevo ricercata la compagnia di altre donne. Che fossi stato guarito come il dottor S. pretende? Vecchio come sono, da un pezzo le donne non mi guardano più. Se io cesso dal guardare loro, ecco che ogni relazione fra di noi è tagliata.
Se un dubbio simile mi fosse capitato a Trieste, avrei saputo solverlo subito. Qui era alquanto più difficile.
Pochi giorni prima avevo avuto in mano il libro di memorie del Da Ponte, l’avventuriere contemporaneo del Casanova. Anche lui era passato certamente per Lucinico ed io sognai d’imbattermi in quelle sue dame incipriate dalle membra celate dalla crinolina. Dio mio! Come facevano quelle donne ad arrendersi così presto e tanto di frequente essendo difese da tutti quegli stracci?
Mi parve che il ricordo della crinolina, ad onta della cura, fosse abbastanza eccitante. Ma il mio era un desiderio alquanto fatturato e non bastò a rassicurarmi.
L’esperienza che cercavo l’ebbi poco dopo e fu sufficiente per rassicurarmi, ma non mi costò poco. Per averla, turbai e guastai la relazione più pura che avessi avuta nella mia vita.
M’imbattei in Teresina, la figlia anziana del colono di una tenuta situata accanto alla mia villa. Il padre, da due anni, era rimasto vedovo e la sua numerosa figliuolanza aveva ritrovata la madre in Teresina, una robusta fanciulla che si levava di mattina per lavorare, e cessava il lavoro per coricarsi e raccogliersi per poter riprendere il lavoro. Quel giorno essa guidava l’asinello di solito affidato alle cure del fratellino e camminava accanto al carretto carico di erba fresca, perché il non grande animale non avrebbe saputo portare su per l’erta lieve anche il peso della fanciulla.
L’anno prima Teresina m’era sembrata tuttavia una bimba e non avevo avuta per lei che una simpatia sorridente e paterna. Ma anche il giorno prima, quando l’avevo rivista per la prima volta, ad onta che l’avessi ritrovata cresciuta, la bruna faccina divenuta più seria, le esili spalle allargate sopra il seno che andava arcuandosi nello sviluppo parco del piccolo corpo affaticato, avevo continuato a vederla una bimba immatura di cui non potevo amare che la straordinaria attività e l’istinto materno di cui fruivano i fratellini. Se non ci fosse stata quella maledetta cura e la necessità di verificare subito in quale stato si trovasse la mia malattia, anche quella volta avrei potuto lasciare Lucinico senz’aver turbata tanta innocenza.
Essa non aveva la crinolina. E la faccina pienotta e sorridente non conosceva la cipria. Aveva i piedi nudi e faceva vedere nuda anche metà della gamba. La faccina e i piedini e la gamba non seppero accendermi. La faccia e le membra che Teresina lasciava vedere erano dello stesso colore; all’aria appartenevano tutte e non c’era niente di male che all’aria fossero abbandonate. Forse perciò non riuscivano ad accendermi. Ma al sentirmi tanto freddo mi spaventai. Che dopo la cura mi fosse occorsa la crinolina?
Cominciai coll’accarezzare l’asinello cui avevo procurato un po’ di riposo. Poi tentai di ritornare a Teresina e le misi in mano niente meno che dieci corone. Era il primo attentato! L’anno prima, a lei e ai suoi fratellini, per esprimere loro il mio affetto paterno, avevo messo nelle manine solo dei centesimi. Ma si sa che l’affetto paterno è altra cosa. Teresina fu stupita del ricco dono. Accuratamente sollevò il suo gonnellino per riporre in non so che tasca celata il prezioso pezzo di carta. Così vidi un ulteriore pezzo di gamba, ma anch’esso sempre bruno e casto.
Ritornai all’asinello e gli diedi un bacio sulla testa. La mia affettuosità provocò la sua. Allungò il muso ed emise il suo grande grido d’amore che io ascoltai sempre con rispetto. Come varca le distanze e com’è significante con quel primo grido che invoca e si ripete, attenuandosi poi e terminando in un pianto disperato. Ma sentito così da vicino, mi fece dolere il timpano.
Teresina rideva e il suo riso m’incoraggiò. Ritornai a lei e subito l’afferrai per l’avambraccio sul quale salii con la mano, lento, verso la spalluccia, studiando le mie sensazioni. Grazie al cielo non ero guarito ancora! Avevo cessata la cura in tempo.
Ma Teresina con una legnata fece procedere l’asino per seguirlo e lasciarmi.
Ridendo di cuore perché io restavo lieto anche se la villanella non voleva saperne di me, le dissi:
– Hai lo sposo? Dovresti averlo. E peccato tu non l’abbia già!
Sempre allontanandosi da me, essa mi disse:
– Se ne prendo uno, sarà certamente più giovine di lei!
La mia letizia non s’offuscò per questo. Avrei voluto dare una lezioncina a Teresina e cercai di ricordarmi come da Boccaccio «Maestro Alberto da Bologna onestamente fa vergognare una donna la quale lui d’esser di lei innamorato voleva far vergognare». Ma il ragionamento di Maestro Alberto non ebbe il suo effetto perché Madonna Malgherida de’ Ghisolieri gli disse: «Il vostro amor m’è caro sì come di savio e valente uomo esser dee; e per ciò, salva la mia onestà, come a cosa vostra ogni vostro piacere imponete sicuramente».
Tentai di fare di meglio:
– Quando ti dedicherai ai vecchi, Teresina? – gridai per essere inteso da lei che m’era già lontana.
– Quando sarò vecchia anch’io, – urlò essa ridendo di gusto e senza fermarsi.
– Ma allora i vecchi non vorranno più saperne di te. Ascoltami! Io li conosco!
Urlavo, compiacendomi del mio spirito che veniva direttamente dal mio sesso.
In quel momento, in qualche punto del cielo le nubi s’apersero e lasciarono passare dei raggi di sole che andarono a raggiungere Teresina che oramai era lontana da me di una quarantina di metri e di me più in alto di una decina o più. Era bruna, piccola, ma luminosa!
Il sole non illuminò me! Quando si è vecchi si resta all’ombra anche avendo dello spirito.
26 Giugno 1915
La guerra m’ha raggiunto! Io che stavo a sentire le storie di guerra come se si fosse trattato di una guerra di altri tempi di cui era divertente parlare, ma sarebbe stato sciocco di preoccuparsi, ecco che vi capitai in mezzo stupefatto e nello stesso tempo stupito di non essermi accorto prima che dovevo esservi prima o poi coinvolto. Io avevo vissuto in piena calma in un fabbricato di cui il pianoterra bruciava e non avevo previsto che prima o poi tutto il fabbricato con me si sarebbe sprofondato nelle fiamme.
La guerra mi prese, mi squassò come un cencio, mi privò in una sola volta di tutta la mia famiglia ed anche del mio amministratore. Da un giorno all’altro io fui un uomo del tutto nuovo, anzi, per essere più esatto, tutte le mie ventiquattr’ore furono nuove del tutto. Da ieri sono un po’ più calmo perché finalmente, dopo l’attesa di un mese, ebbi le prime notizie della mia famiglia. Si trova sana e salva a Torino mentre io già avevo perduta ogni speranza di rivederla.
Devo passare la giornata intera nel mio ufficio. Non vi ho niente da fare, ma gli Olivi, quali cittadini italiani, hanno dovuto partire e tutti i miei pochi migliori impiegati sono andati a battersi di qua o di là e perciò devo restare al mio posto quale sorvegliante. Alla sera vado a casa carico delle grosse chiavi del magazzino. Oggi che mi sento tanto più calmo, portai con me in ufficio questo manoscritto che potrebbe farmi passar meglio il lungo tempo. Infatti esso mi procura un quarto d’ora meraviglioso in cui appresi che ci fu a questo mondo un’epoca di tanta quiete e silenzio da permettere di occuparsi di giocattoletti simili.
Sarebbe anche bello che qualcuno m’invitasse sul serio di piombare in uno stato di mezza coscienza tale da poter rivivere anche soltanto un’ora della mia vita precedente. Gli riderei in faccia. Come si può abbandonare un presente simile per andare alla ricerca di cose di nessun’importanza? A me pare che soltanto ora sono staccato definitivamente dalla mia salute e dalla mia malattia. Cammino per le vie della nostra misera città, sentendo di essere un privilegiato che non va alla guerra e che trova ogni giorno quello che gli occorre per mangiare. In confronto a tutti mi sento tanto felice – specie dacché ebbi notizie dei miei – che mi sembrerebbe di provocare l’ira degli dei se stessi anche perfettamente bene.
La guerra ed io ci siamo incontrati in un modo violento, ma che adesso mi pare un poco buffo.
Augusta ed io eravamo ritornati a Lucinico a passarvi le Pentecoste insieme ai figliuoli. Il 23 di Maggio io mi levai in buon’ora. Dovevo prendere il sale di Carlsbad e fare anche una passeggiata prima del caffè. Fu durante questa cura a Lucinico che m’accorsi che il cuore, quando si è a digiuno, attende più attivamente ad altre riparazioni irraggiando su tutto l’organismo un grande benessere. La mia teoria doveva perfezionarsi quel giorno stesso in cui mi si costrinse di soffrire la fame che mi fece tanto bene.
Augusta, per salutarmi, levò la testa tutta bianca dal guanciale e mi ricordò che avevo promesso a mia figlia di procurarle delle rose. Il nostro unico rosaio era appassito e bisognava perciò provvedere. Mia figlia s’è fatta una bella fanciulla e somiglia ad Ada. Da un momento all’altro, con essa avevo dimenticato il fare dell’educatore burbero ed ero passato a quello del cavaliere che rispetta la femminilità anche nella propria figliuola. Subito essa s’accorse del suo potere e con grande divertimento mio e d’Augusta ne abusò. Voleva delle rose e bisognava procurargliene.
Mi proposi di camminare per un due orette. Faceva un bel sole e visto che il mio proposito era di camminare sempre e di non arrestarmi finché non ero ritornato a casa, non presi meco neppure la giubba e il cappello. Per fortuna ricordai che avrei dovuto pagare le rose e non lasciai perciò a casa insieme alla giubba anche il portafoglio.
Prima di tutto mi recai alla campagna vicina, dal padre di Teresina, per pregarlo di tagliare le rose che sarei venuto a prendere al mio ritorno. Entrai nel grande cortile cinto da un muro alquanto rovinato e non vi trovai nessuno. Urlai il nome di Teresina. Uscì dalla casa il più piccolo dei bambini che allora avrà avuto sei anni. Posi nella sua manina qualche centesimo ed egli mi raccontò che tutta la famigliuola di buon’ora s’era recata al di là dell’Isonzo, per una giornata di lavoro, su un suo campo di patate di cui la terra aveva bisogno di essere rassodata.
Ciò non mi spiaceva. Io conoscevo quel campo e sapevo che per giungervi abbisognavo di circa un’ora di tempo. Visto che avevo stabilito di camminare per un due ore, mi piaceva di poter attribuire alla mia passeggiata uno scopo determinato. Così non c’era la paura d’interromperla per un assalto improvviso d’infingardaggine. M’avviai traverso la pianura ch’è più alta della strada e di cui perciò non vedevo che i margini e qualche corona d’albero in fiore. Ero veramente giocondo: così in maniche di camicia e senza cappello mi sentivo molto leggero. Aspiravo quell’aria tanto pura e, come usavo spesso da qualche tempo, camminando facevo la ginnastica polmonare del Niemeyer che m’era stata insegnata da un amico tedesco, una cosa utilissima a chi fa una vita piuttosto sedentaria.
Arrivato in quel campo, vidi Teresina che lavorava proprio dalla parte della strada. M’avvicinai a lei e allora m’accorsi che più in là lavoravano insieme al padre i due fratellini di Teresina di un’età che io non avrei saputo precisare, fra’ dieci e i quattordici anni. Nella fatica i vecchi si sentono magari esausti, ma per l’eccitazione che l’accompagna, sempre più giovini che nell’inerzia. Ridendo m’accostai a Teresina:
– Sei ancora in tempo, Teresina. Non tardare.
Essa non m’intese ed io non le spiegai nulla. Non occorreva. Giacché essa non ricordava, si poteva ritornare con lei ai nostri antichi rapporti. Avevo già ripetuto l’esperimento ed aveva avuto anche questa volta un risultato favorevole. Indirizzandole quelle poche parole l’avevo accarezzata altrimenti che col solo occhio.
Col padre di Teresina m’accordai facilmente per le rose. Mi permetteva di tagliarne quante volevo eppoi non si avrebbe litigato per il prezzo. Egli voleva subito ritornare al lavoro mentre io m’accingevo di mettermi sulla via del ritorno, ma poi si pentì e mi corse dietro. Raggiuntomi, a voce molto bassa, mi domandò:
– Lei non ha sentito niente? Dicono sia scoppiata la guerra.
– Già! Lo sappiamo tutti! Da un anno circa, – risposi io.
– Non parlo di quella, – disse lui spazientito. – Parlo di quella con… – e fece un segno dalla parte della vicina frontiera italiana. – Lei non ne sa nulla? – Mi guardò ansioso della risposta.
– Capirai, – gli dissi io con piena sicurezza, – che se io non so nulla vuol proprio dire che nulla c’è. Vengo da Trieste e le ultime parole che sentii colà significavano che la guerra è proprio definitivamente scongiurata. A Roma hanno ribaltato il Ministero che voleva la guerra e ci hanno ora il Giolitti.
Egli si rasserenò immediatamente:
– Perciò queste patate che stiamo coprendo e che promettono tanto bene saranno poi nostre! Vi sono tanti di quei chiacchieroni a questo mondo! – Con la manica della camicia s’asciugò il sudore che gli colava dalla fronte.
Vedendolo tanto contento, tentai di renderlo più contento ancora. Amo tanto le persone felici, io. Perciò dissi delle cose che veramente non amo di rammentare. Asserii che se anche la guerra fosse scoppiata, non sarebbe stata combattuta colà. C’era prima di tutto il mare dove era ora si battessero, eppoi oramai in Europa non mancavano dei campi di battaglia per chi ne voleva. C’erano le Fiandre e varii dipartimenti della Francia. Avevo poi sentito dire – non sapevo più da chi – che a questo mondo c’era oramai tale un bisogno di patate che le raccoglievano accuratamente anche sui campi di battaglia. Parlai molto, sempre guardando Teresina che piccola, minuta, s’era accovacciata sulla terra per tastarla prima di applicarvi la vanga.
Il contadino perfettamente tranquillizzato ritornò al suo lavoro. Io, invece, avevo consegnato una parte della mia tranquillità a lui e ne restava a me molto di meno. Era certo che a Lucinico eravamo troppo vicini alla frontiera. Ne avrei parlato ad Augusta. Avremmo forse fatto bene di ritornare a Trieste e forse andare anche più in là o in qua. Certamente Giolitti era ritornato al potere, ma non si poteva sapere se, arrivato lassù, avrebbe continuato a vedere le cose nella luce in cui le vedeva quando lassù c’era qualcuno d’altro.
Mi rese anche più nervoso l’incontro casuale con un plotone di soldati che marciava sulla strada in direzione di Lucinico. Erano dei soldati non giovini e vestiti ed attrezzati molto male. Dal loro fianco pendeva quella che noi a Trieste dicevamo la Durlindana, quella baionetta lunga che in Austria, nell’estate del 1915, avevano dovuto levare dai vecchi depositi.
Per qualche tempo camminai dietro di loro inquieto d’essere presto a casa. Poi mi seccò un certo odore di selvatico frollo che emanava da loro e rallentai il passo. La mia inquietudine e la mia fretta erano sciocche. Era pure sciocco d’inquietarsi per aver assistito all’inquietudine di un contadino. Oramai vedevo da lontano la mia villa ed il plotone non c’era più sulla strada. Accelerai il passo per arrivare finalmente al mio caffelatte.
Fu qui che cominciò la mia avventura. Ad uno svolto di via, mi trovai arrestato da una sentinella che urlò:
– Zurück! – mettendosi addirittura in posizione di sparare. Volli parlargli in tedesco giacché in tedesco aveva urlato, ma egli del tedesco non conosceva che quella sola parola che ripeté sempre più minacciosamente.
Bisognava andare zurück ed io guardandomi sempre dietro nel timore che l’altro, per farsi intendere meglio, sparasse, mi ritirai con una certa premura che non m’abbandonò neppure quando il soldato non vidi più.
Ma ancora non avevo rinunciato di arrivare subito alla mia villa. Pensai che varcando la collina alla mia destra, sarei arrivato molto dietro la sentinella minacciosa.
L’ascesa non fu difficile specie perché l’alta erba era stata curvata da molta gente che doveva essere passata per di là prima di me. Certamente doveva esservi stata costretta dalla proibizione di passare per la strada. Camminando riacquistai la mia sicurezza e pensai che al mio arrivo a Lucinico mi sarei subito recato a protestare dal capovilla per il trattamento che avevo dovuto subire. Se permetteva che i villeggianti fossero trattati così, presto a Lucinico non ci sarebbe venuto nessuno!
Ma arrivato alla cima della collina, ebbi la brutta sorpresa di trovarla occupata da quel plotone di soldati dall’odore di selvatico. Molti soldati riposavano all’ombra di una casetta di contadini che io conoscevo da molto tempo e che a quell’ora era del tutto vuota; tre di essi parevano messi a guardia, ma non verso il versante da cui io ero venuto, e alcuni altri stavano in un semi circolo dinanzi ad un ufficiale che dava loro delle istruzioni che illustrava con una carta topografica ch’egli teneva in mano.
Io non possedevo neppure un cappello che potesse servirmi per salutare. Inchinandomi varie volte e col mio più bel sorriso, m’appressai all’ufficiale il quale, vedendomi, cessò di parlare coi suoi soldati e si mise a guardarmi. Anche i cinque mammelucchi che lo circondavano mi regalavano tutta la loro attenzione. Sotto tutti quegli sguardi e sul terreno non piano era difficilissimo di moversi.
L’ufficiale urlò:
– Was will der dumme Kerl hier? – (Che cosa vuole quello scimunito?).
Stupito che senz’alcuna provocazione mi si offendesse così, volli dimostrarmi offeso virilmente ma tuttavia con la discrezione del caso, deviai di strada e tentai di arrivare al versante che m’avrebbe portato a Lucinico. L’ufficiale si mise ad urlare che, se facevo un solo passo di più, m’avrebbe fatto tirare adosso. Ridivenni subito molto cortese e da quel giorno a tutt’oggi che scrivo, rimasi sempre molto cortese. Era una barbarie d’essere costretto di trattare con un tomo simile, ma intanto si aveva il vantaggio ch’egli parlava correntemente il tedesco. Era un tale vantaggio che, ricordandolo, riusciva più facile di parlargli con dolcezza. Guai se bestia come era non avesse neppur compreso il tedesco. Sarei stato perduto.
Peccato che io non parlavo abbastanza correntemente quella lingua perché altrimenti mi sarebbe stato facile di far ridere quell’arcigno signore. Gli raccontai che a Lucinico m’aspettava il mio caffelatte da cui ero diviso soltanto dal suo plotone.
Egli rise, in fede mia rise. Rise sempre bestemmiando e non ebbe la pazienza di lasciarmi finire. Dichiarò che il caffelatte di Lucinico sarebbe stato bevuto da altri e quando sentì che oltre al caffè c’era anche mia moglie che m’aspettava, urlò:
– Auch Ihre Frau wird von anderen gegessen werden. – (Anche vostra moglie sarà mangiata da altri).
Egli era oramai di miglior umore di me. Pare poi gli fosse spiaciuto di avermi dette delle parole che, sottolineate dal riso clamoroso dei cinque mammalucchi, potevano apparire offensive; si fece serio e mi spiegò che non dovevo sperare di rivedere per qualche giorno Lucinico ed anzi in amicizia mi consigliava di non domandarlo più perché bastava quella domanda per compromettermi!
– Haben Sie verstanden? – (Avete capito?)
Io avevo capito, ma non era mica facile di adattarsi di rinunziare al caffelatte da cui distavo non più di mezzo chilometro. Solo perciò esitavo di andarmene perché era evidente che quando fossi disceso da quella collina, alla mia villa, per quel giorno, non sarei giunto più. E, per guadagnar tempo, mitemente domandai all’ufficiale:
– Ma a chi dovrei rivolgermi per poter ritornare a Lucinico a prendere almeno la mia giubba e il mio cappello?
Avrei dovuto accorgermi che all’ufficiale tardava di esser lasciato solo con la sua carta e i suoi uomini, ma non m’aspettavo di provocare tanta sua ira.
Urlò, in modo da intronarmi l’orecchie, che m’aveva già detto che non dovevo più domandarlo. Poi m’impose di andare dove il diavolo vorrà portarmi (wo der Teufel Sie tragen will). L’idea di farmi portare non mi spiaceva molto perché ero molto stanco, ma esitavo ancora. Intanto però l’ufficiale a forza d’urlare s’accese sempre più e con accento di grande minaccia chiamò a sé uno dei cinque uomini che l’attorniavano e appellandolo signor caporale gli diede l’ordine di condurmi già della collina e di sorvegliarmi finché non fossi sparito sulla via che conduce a Gorizia, tirandomi addosso se avessi esitato ad ubbidire.
Perciò scesi da quella cima piuttosto volontieri:
– Danke schön, – dissi anche senz’alcun’intenzione d’ironia.
Il caporale era uno slavo che parlava discretamente l’italiano. Gli parve di dover essere brutale in presenza dell’ufficiale e, per indurmi a precederlo nella discesa, mi gridò:
– Marsch! – Ma quando fummo un po’ più lontani si fece dolce e familiare. Mi domandò se avevo delle notizie sulla guerra e se era vero ch’era imminente l’intervento italiano. Mi guardava ansioso in attesa della risposta.
Dunque neppure loro che la facevano sapevano se la guerra ci fosse o no! Volli renderlo più felice che fosse possibile e gli diedi le notizie che avevo propinate anche al padre di Teresina. Poi mi pesarono sulla coscienza. Nell’orrendo temporale che scoppiò, probabilmente tutte le persone ch’io rassicurai perirono. Chissà quale sorpresa ci sarà stata sulla loro faccia cristallizzata dalla morte. Era un ottimismo incoercibile il mio. Non avevo sentita la guerra nelle parole dell’ufficiale e meglio ancora nel loro suono?
Il caporale si rallegrò molto e, per compensarmi, mi diede anche lui il consiglio di non tentare più di arrivare a Lucinico. Date le notizie mie, egli riteneva che le disposizioni che m’impedivano di rincasare sarebbero state levate il giorno appresso. Ma intanto mi consigliava di andare a Trieste al Platzkommando dal quale forse avrei potuto ottenere un permesso speciale.
– Fino a Trieste? – domandai io spaventato. – A Trieste, senza giubba, senza cappello e senza caffelatte?
A quanto ne sapeva il caporale, mentre parlavamo, un fitto cordone di fanteria chiudeva il transito per l’Italia, creando una nuova ed insuperabile frontiera. Con un sorriso di persona superiore mi dichiarò che, secondo lui, la via più breve per Lucinico era quella che conduceva oltre Trieste.
A forza di sentirmelo dire, io mi rassegnai e m’avviai verso Gorizia pensando di prendere il treno del mezzodì per recarmi a Trieste. Ero agitato, ma devo dire che mi sentivo molto bene. Avevo fumato poco e non mangiato affatto. Mi sentivo di una leggerezza che da lungo tempo m’era mancata. Non mi dispiaceva affatto di dover ancora camminare. Mi dolevano un poco le gambe, ma mi pareva che avrei potuto reggere fino a Gorizia, tanto era libero e profondo il mio respiro. Scaldatemi le gambe con un buon passo, il camminare infatti non mi pesò. E nel benessere, battendomi il tempo, allegro perché insolitamente celere, ritornai al mio ottimismo. Minacciavano di qua, minacciavano di là, ma alla guerra non sarebbero giunti. Ed è così che, quando giunsi a Gorizia, esitai se non avessi dovuto stabilire una stanza all’albergo nella quale passare la notte e ritornare il giorno appresso a Lucinico per presentare le mie rimostranze al capovilla.
Corsi intanto all’ufficio postale per telefonare ad Augusta. Ma dalla mia villa non si rispose.
L’impiegato, un omino dalla barbetta rada che pareva nella sua piccolezza e rigidezza qualche cosa di ridicolo e d’ostinato – la sola cosa che di lui ricordi – sentendomi bestemmiare furibondo al telefono muto, mi si avvicinò e mi disse:
– È già la quarta volta oggi che Lucinico non risponde.
Quando mi rivolsi a lui, nel suo occhio brillò una grande lieta malizia (sbagliavo! anche quella ricordo ancora!) e quel suo occhio brillante cercò il mio per vedere se proprio ero tanto sorpreso e arrabbiato. Ci vollero un dieci buoni minuti perché comprendessi. Allora non ci furono dubbii per me. Lucinico si trovava o fra pochi istanti si troverebbe sulla linea del fuoco. Quando intesi perfettamente quell’occhiata eloquente ero avviato al caffè per prendere in aspettativa della colazione la tazza di caffè che m’era dovuta dalla mattina. Deviai subito e andai alla stazione. Volevo trovarmi più vicino ai miei e – seguendo le indicazioni del mio amico caporale – mi recavo a Trieste.
Fu durante quel mio breve viaggio che la guerra scoppiò.
Pensando di arrivare tanto presto a Trieste, alla stazione di Gorizia e per quanto ne avessi avuto il tempo, non presi neppure la tazza di caffè cui anelavo da tanto tempo. Salii nella mia vettura e, lasciato solo, rivolsi il mio pensiero ai miei cari da cui ero stato staccato in un modo tanto strano. Il treno camminò bene fino oltre Monfalcone.
Pareva che la guerra non fosse giunta ancora fin là. Io mi conquistai la tranquillità pensando che probabilmente a Lucinico le cose si sarebbero svolte come al di qua della frontiera. A quell’ora Augusta e i miei figli si sarebbero trovati in viaggio verso l’interno dell’Italia. Questa tranquillità associatasi a quella enorme, sorprendente, della mia fame, mi procurò un lungo sonno.
Fu probabilmente la stessa fame che mi destò. Il mio treno s’era fermato in mezzo alla cosidetta Sassonia di Trieste. Il mare non si vedeva, per quanto dovesse essere vicinissimo, perché una leggera foschia impediva di guardare lontano. Il Carso ha una grande dolcezza nel Maggio, ma la può intendere solo chi non è viziato dalle primavere esuberanti di colore e di vita di altre campagne. Qui la pietra che sporge dappertutto è circondata da un mite verde che non è umile perché presto diventa la nota predominante del paesaggio.
In altre condizioni io mi sarei adirato enormemente di non poter mangiare avendo tanta fame. Invece quel giorno la grandezza dell’avvenimento storico cui avevo assistito, m’imponeva e m’induceva alla rassegnazione. Il conduttore cui regalai delle sigarette non seppe procurarmi neppure un tozzo di pane. Non raccontai a nessuno delle mie esperienze della mattina. Ne avrei parlato a Trieste a qualche intimo. Dalla frontiera verso la quale tendevo il mio orecchio non veniva alcun suono di combattimento. Noi eravamo fermi a quel posto per lasciar passare un otto o nove treni che scendevano turbinando verso l’Italia. La piaga cancrenosa (come in Austria si appellò subito la fronte italiana) s’era aperta e abbisognava di materiale per nutrire la sua purulenza. E i poveri uomini vi andavano sghignazzando e cantando. Da tutti quei treni uscivano i medesimi suoni di gioia o di ebbrezza.
Quando arrivai a Trieste la notte era già scesa sulla città.
La notte era illuminata dal bagliore di molti incendi e un amico che mi vide andare verso casa mia in maniche di camicia mi gridò:
– Hai preso parte ai saccheggi?
Finalmente arrivai a mangiare qualche cosa e subito mi coricai.
Una vera, grande stanchezza mi spingeva a letto. Io credo fosse prodotta dalle speranze e dai dubbii che tenzonavano nella mia mente. Stavo sempre molto bene e nel periodo breve che precedette il sogno di cui con la psico-analisi m’ero esercitato a ritenere le immagini, ricordo che conclusi la mia giornata con un’ultima infantile idea ottimistica: alla frontiera non era morto ancora nessuno e perciò la pace si poteva rifare.
Adesso che so che la mia famiglia è sana e salva, la vita che faccio non mi spiace. Non ho molto da fare ma non si può dire che io sia inerte. Non si deve né comperare né vendere. Il commercio rinascerà quando ci sarà la pace. L’Olivi dalla Svizzera mi fece pervenire dei consigli. Se sapesse come i suoi consigli stonano in quest’ambiente ch’è mutato del tutto! Io, intanto, per il momento, non faccio nulla.
24 Marzo 1916
Dal Maggio dell’anno scorso non avevo più toccato questo libercolo. Ecco che dalla Svizzera il dr. S. mi scrive pregandomi di mandargli quanto avessi ancora annotato. È una domanda curiosa, ma non ho nulla in contrario di mandargli anche questo libercolo dal quale chiaramente vedrà come io la pensi di lui e della sua cura. Giacché possiede tutte le mie confessioni, si tenga anche queste poche pagine e ancora qualcuna che volentieri aggiungo a sua edificazione. Ho poco tempo perché il mio commercio occupa la mia giornata. Ma al signor dottor S. voglio pur dire il fatto suo. Ci pensai tanto che oramai ho le idee ben chiare.
Intanto egli crede di ricevere altre confessioni di malattia e debolezza e invece riceverà la descrizione di una salute solida, perfetta quanto la mia età abbastanza innoltrata può permettere. Io sono guarito! Non solo non voglio fare la psico-analisi, ma non ne ho neppur di bisogno. E la mia salute non proviene solo dal fatto che mi sento un privilegiato in mezzo a tanti martiri. Non è per il confronto ch’io mi senta sano. Io sono sano, assolutamente. Da lungo tempo io sapevo che la mia salute non poteva essere altro che la mia convinzione e ch’era una sciocchezza degna di un sognatore ipnagogico di volerla curare anziché persuadere. Io soffro bensì di certi dolori, ma mancano d’importanza nella mia grande salute. Posso mettere un impiastro qui o là, ma il resto ha da moversi e battersi e mai indugiarsi nell’immobilità come gl’incancreniti. Dolore e amore, poi, la vita insomma, non può essere considerata quale una malattia perché duole.
Ammetto che per avere la persuasione della salute il mio destino dovette mutare e scaldare il mio organismo con la lotta e sopratutto col trionfo. Fu il mio commercio che mi guarì e voglio che il dottor S. lo sappia.
Attonito e inerte, stetti a guardare il mondo sconvolto, fino al principio dell’Agosto dell’anno scorso. Allora io cominciai a comperare. Sottolineo questo verbo perché ha un significato più alto di prima della guerra. In bocca di un commerciante, allora, significava ch’egli era disposto a comperare un dato articolo. Ma quando io lo dissi, volli significare ch’io ero compratore di qualunque merce che mi sarebbe stata offerta. Come tutte le persone forti, io ebbi nella mia testa una sola idea e di quella vissi e fu la mia fortuna. L’Olivi non era a Trieste, ma è certo ch’egli non avrebbe permesso un rischio simile e lo avrebbe riservato agli altri. Invece per me non era un rischio. Io ne sapevo il risultato felice con piena certezza. Dapprima m’ero messo, secondo l’antico costume in epoca di guerra, a convertire tutto il patrimonio in oro, ma v’era una certa difficoltà di comperare e vendere dell’oro. L’oro per così dire liquido, perché più mobile, era la merce e ne feci incetta. Io effettuo di tempo in tempo anche delle vendite ma sempre in misura inferiore agli acquisti. Perché cominciai nel giusto momento i miei acquisti e le mie vendite furono tanto felici che queste mi davano i grandi mezzi di cui abbisognavo per quelli.
Con grande orgoglio ricordo che il mio primo acquisto fu addirittura apparentemente una sciocchezza e inteso unicamente a realizzare subito la mia nuova idea: una partita non grande d’incenso. Il venditore mi vantava la possibilità d’impiegare l’incenso quale un surrogato della resina che già cominciava a mancare, ma io quale chimico sapevo con piena certezza che l’incenso mai più avrebbe potuto sostituire la resina di cui era differente toto genere. Secondo la mia idea il mondo sarebbe arrivato ad una miseria tale da dover accettare l’incenso quale un surrogato della resina. E comperai! Pochi giorni or sono ne vendetti una piccola parte e ne ricavai l’importo che m’era occorso per appropriarmi della partita intera. Nel momento in cui incassai quei denari mi si allargò il petto al sentimento della mia forza e della mia salute.
Il dottore, quando avrà ricevuta quest’ultima parte del mio manoscritto, dovrebbe restituirmelo tutto. Lo rifarei con chiarezza vera perché come potevo intendere la mia vita quando non ne conoscevo quest’ultimo periodo? Forse io vissi tanti anni solo per prepararmi ad esso!
Naturalmente io non sono un ingenuo e scuso il dottore di vedere nella vita stessa una manifestazione di malattia. La vita somiglia un poco alla malattia come procede per crisi e lisi ed ha i giornalieri miglioramenti e peggioramenti. A differenza delle altre malattie la vita è sempre mortale. Non sopporta cure. Sarebbe come voler turare i buchi che abbiamo nel corpo credendoli delle ferite. Morremmo strangolati non appena curati.
La vita attuale è inquinata alle radici. L’uomo s’è messo al posto degli alberi e delle bestie ed ha inquinata l’aria, ha impedito il libero spazio. Può avvenire di peggio. Il triste e attivo animale potrebbe scoprire e mettere al proprio servizio delle altre forze. V’è una minaccia di questo genere in aria. Ne seguirà una grande ricchezza… nel numero degli uomini. Ogni metro quadrato sarà occupato da un uomo. Chi ci guarirà dalla mancanza di aria e di spazio? Solamente al pensarci soffoco!
Ma non è questo, non è questo soltanto.
Qualunque sforzo di darci la salute è vano. Questa non può appartenere che alla bestia che conosce un solo progresso, quello del proprio organismo. Allorché la rondinella comprese che per essa non c’era altra possibile vita fuori dell’emigrazione, essa ingrossò il muscolo che muove le sue ali e che divenne la parte più considerevole del suo organismo. La talpa s’interrò e tutto il suo corpo si conformò al suo bisogno. Il cavallo s’ingrandì e trasformò il suo piede. Di alcuni animali non sappiamo il progresso, ma ci sarà stato e non avrà mai leso la loro salute.
Ma l’occhialuto uomo, invece, inventa gli ordigni fuori del suo corpo e se c’è stata salute e nobiltà in chi li inventò, quasi sempre manca in chi li usa. Gli ordigni si comperano, si vendono e si rubano e l’uomo diventa sempre più furbo e più debole. Anzi si capisce che la sua furbizia cresce in proporzione della sua debolezza. I primi suoi ordigni parevano prolungazioni del suo braccio e non potevano essere efficaci che per la forza dello stesso, ma, oramai, l’ordigno non ha più alcuna relazione con l’arto. Ed è l’ordigno che crea la malattia con l’abbandono della legge che fu su tutta la terra la creatrice. La legge del più forte sparì e perdemmo la selezione salutare. Altro che psico-analisi ci vorrebbe: sotto la legge del possessore del maggior numero di ordigni prospereranno malattie e ammalati.
Forse traverso una catastrofe inaudita prodotta dagli ordigni ritorneremo alla salute. Quando i gas velenosi non basteranno più, un uomo fatto come tutti gli altri, nel segreto di una stanza di questo mondo, inventerà un esplosivo incomparabile, in confronto al quale gli esplosivi attualmente esistenti saranno considerati quali innocui giocattoli. Ed un altro uomo fatto anche lui come tutti gli altri, ma degli altri un po’ più ammalato, ruberà tale esplosivo e s’arrampicherà al centro della terra per porlo nel punto ove il suo effetto potrà essere il massimo. Ci sarà un’esplosione enorme che nessuno udrà e la terra ritornata alla forma di nebulosa errerà nei cieli priva di parassiti e di malattie.
FINE