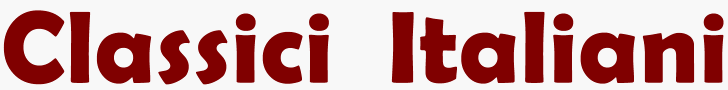La coscienza di Zeno. Capitolo 5. La storia del mio matrimonio
Prima pubblicazione: 1º maggio 1923, Premiato Stabilimento tipografico Licinio Cappelli in Rocca di San Casciano (FC).
Note
Diritti d’autore: no
Edizione di riferimento: Italo Svevo, Romanzi, Einaudi-Gallimard, Torino 1993 .
Capitolo 5. La storia del mio matrimonio
Nella mente di un giovine di famiglia borghese il concetto di vita umana s’associa a quello della carriera e nella prima gioventù la carriera è quella di Napoleone I. Senza che perciò si sogni di diventare imperatore perché si può somigliare a Napoleone restando molto ma molto più in basso. La vita più intensa è raccontata in sintesi dal suono più rudimentale, quello dell’onda del mare, che, dacché si forma, muta ad ogni istante finché non muore! M’aspettavo perciò anch’io di divenire e disfarmi come Napoleone e l’onda.
La mia vita non sapeva fornire che una nota sola senz’alcuna variazione, abbastanza alta e che taluni m’invidiano, ma orribilmente tediosa. I miei amici mi conservarono durante tutta la mia vita la stessa stima e credo che neppur io, dacché son giunto all’età della ragione, abbia mutato di molto il concetto che feci di me stesso.
Può perciò essere che l’idea di sposarmi mi sia venuta per la stanchezza di emettere e sentire quell’unica nota. Chi non l’ha ancora sperimentato crede il matrimonio più importante di quanto non sia. La compagna che si sceglie rinnoverà, peggiorando o migliorando, la propria razza nei figli, ma madre natura che questo vuole e che per via diretta non saprebbe dirigerci, perché in allora ai figli non pensiamo affatto, ci dà a credere che dalla moglie risulterà anche un rinnovamento nostro, ciò ch’è un’illusione curiosa non autorizzata da alcun testo. Infatti si vive poi uno accanto all’altro, immutati, salvo che per una nuova antipatia per chi è tanto dissimile da noi o per un’invidia per chi a noi è superiore.
Il bello si è che la mia avventura matrimoniale esordì con la conoscenza del mio futuro suocero e con l’amicizia e l’ammirazione che gli dedicai prima che avessi saputo ch’egli era il padre di ragazze da marito. Perciò è evidente che non fu una risoluzione quella che mi fece procedere verso la mèta ch’io ignoravo. Trascurai una fanciulla che per un momento avrei creduto facesse al caso mio e restai attaccato al mio futuro suocero. Mi verrebbe voglia di credere anche nel destino.
Il desiderio di novità che c’era nel mio animo veniva soddisfatto da Giovanni Malfenti ch’era tanto differente da me e da tutte le persone di cui io fino ad allora avevo ricercato la compagnia e l’amicizia. Io ero abbastanza cólto essendo passato attraverso due facoltà universitarie eppoi per la mia lunga inerzia, ch’io credo molto istruttiva. Lui, invece, era un grande negoziante, ignorante ed attivo. Ma dalla sua ignoranza gli risultava forza e serenità ed io m’incantavo a guardarlo, invidiandolo.
Il Malfenti aveva allora circa cinquant’anni, una salute ferrea, un corpo enorme alto e grosso del peso di un quintale e più. Le poche idee che gli si movevano nella grossa testa erano svolte da lui con tanta chiarezza, sviscerate con tale assiduità, applicate evolvendole ai tanti nuovi affari di ogni giorno, da divenire sue parti, sue membra, suo carattere. Di tali idee io ero ben povero e m’attaccai a lui per arricchire.
Ero venuto al Tergesteo per consiglio dell’Olivi che mi diceva sarebbe stato un buon esordio alla mia attività commerciale frequentare la Borsa e che da quel luogo avrei anche potuto procurargli delle utili notizie. M’assisi a quel tavolo al quale troneggiava il mio futuro suocero e di là non mi mossi più, sembrandomi di essere arrivato ad una vera cattedra commerciale, quale la cercavo da tanto tempo.
Egli presto s’accorse della mia ammirazione e vi corrispose con un’amicizia che subito mi parve paterna. Che egli avesse saputo subito come le cose sarebbero andate a finire? Quando, entusiasmato dall’esempio della sua grande attività, una sera dichiarai di voler liberarmi dall’Olivi e dirigere io stesso i miei affari, egli me ne sconsigliò e parve persino allarmato dal mio proposito. Potevo dedicarmi al commercio, ma dovevo tenermi sempre solidamente legato all’Olivi ch’egli conosceva.
Era dispostissimo ad istruirmi, ed anzi annotò di propria mano nel mio libretto tre comandamenti ch’egli riteneva bastassero per far prosperare qualunque ditta: 1. Non occorre saper lavorare, ma chi non sa far lavorare gli altri perisce. 2. Non c’è che un solo grande rimorso, quello di non aver saputo fare il proprio interesse. 3. In affari la teoria è utilissima, ma è adoperabile solo quando l’affare è stato liquidato.
Io so questi e tanti altri teoremi a mente, ma a me non giovarono.
Quando io ammiro qualcuno, tento immediatamente di somigliargli. Copiai anche il Malfenti. Volli essere e mi sentii molto astuto. Una volta anzi sognai d’essere più furbo di lui. Mi pareva di aver scoperto un errore nella sua organizzazione commerciale: volli dirglielo subito per conquistarmi la sua stima. Un giorno al tavolo del Tergesteo l’arrestai quando, discutendo di un affare, stava dando della bestia ad un suo interlocutore. L’avvertii ch’io trovavo ch’egli sbagliava di proclamare con tutti la sua furberia. Il vero furbo, in commercio, secondo me, doveva fare in modo di apparire melenso.
Egli mi derise. La fama di furberia era utilissima. Intanto molti venivano a prender consiglio da lui e gli portavano delle notizie fresche mentre lui dava loro dei consigli utilissimi confermati da un’esperienza raccolta dal Medio Evo in poi. Talvolta egli aveva l’opportunità di aver insieme alle notizie anche la possibilità di vendere delle merci. Infine – e qui si mise ad urlare perché gli parve d’aver trovato finalmente l’argomento che doveva convincermi – per vendere o per comperare vantaggiosamente, tutti si rivolgevano al più furbo. Dal melenso non potevano sperare altro fuorché indurlo a sacrificare ogni suo beneficio, ma la sua merce era sempre più cara di quella del furbo, perché egli era stato già truffato al momento dell’acquisto.
Io ero la persona più importante per lui a quel tavolo. Mi confidò suoi segreti commerciali ch’io mai tradii. La sua fiducia era messa benissimo, tant’è vero che poté ingannarmi due volte, quand’ero già divenuto suo genero. La prima volta la sua accortezza mi costò bensì del denaro, ma fu l’Olivi ad esser l’ingannato e perciò io non mi dolsi troppo. L’Olivi m’aveva mandato da lui per averne accortamente delle notizie e le ebbe. Le ebbe tali che non me la perdonò più e quando aprivo la bocca per dargli un’informazione, mi domandava: «Da chi l’avete avuta? Da vostro suocero?». Per difendermi dovetti difendere Giovanni e finii col sentirmi piuttosto l’imbroglione che l’imbrogliato. Un sentimento gradevolissimo.
Ma un’altra volta feci proprio io la parte dell’imbecille, ma neppure allora seppi nutrire del rancore per mio suocero. Egli provocava ora la mia invidia ed ora la mia ilarità. Vedevo nella mia disgrazia l’esatta applicazione dei suoi principii ch’egli giammai m’aveva spiegati tanto bene. Trovò anche il modo di riderne con me, mai confessando di avermi ingannato e asserendo di dover ridere dell’aspetto comico della mia disdetta. Una sola volta egli confessò di avermi giocato quel tiro e ciò fu alle nozze di sua figlia Ada (non con me) dopo di aver bevuto dello sciampagna che turbò quel grosso corpo abbeverato di solito da acqua pura.
Allora egli raccontò il fatto, urlando per vincere l’ilarità che gl’impediva la parola:
– Capita dunque quel decreto! Abbattuto sto facendo il calcolo di quanto mi costi. In quel momento entra mio genero. Mi dichiara che vuol dedicarsi al commercio. «Ecco una bella occasione», gli dico. Egli si precipita sul documento per firmare temendo che l’Olivi potesse arrivare in tempo per impedirglielo e l’affare è fatto. – Poi mi faceva delle grandi lodi: – Conosce i classici a mente. Sa chi ha detto questo e chi ha detto quello. Non sa però leggere un giornale!
Era vero! Se avessi visto quel decreto apparso in luogo poco vistoso dei cinque giornali ch’io giornalmente leggo, non sarei caduto in trappola. Avrei dovuto anche subito intendere quel decreto e vederne le conseguenze ciò che non era tanto facile perché con esso si riduceva il tasso di un dazio per cui la merce di cui si trattava veniva deprezzata.
Il giorno dopo mio suocero smentì le sue confessioni. L’affare in bocca sua riacquistava la fisonomia che aveva avuta prima di quella cena. – Il vino inventa, – diceva egli serenamente e restava acquisito che il decreto in questione era stato pubblicato due giorni dopo la conclusione di quell’affare. Mai egli emise la supposizione che se avessi visto quel decreto avrei potuto fraintenderlo. Io ne fui lusingato, ma non era per gentilezza, ch’egli mi risparmiasse, ma perché pensava che tutti leggendo i giornali ricordino i proprii interessi. Invece io, quando leggo un giornale, mi sento trasformato in opinione pubblica e vedendo la riduzione di un dazio ricordo Cobden e il liberismo. È un pensiero tanto importante che non resta altro posto per ricordare la mia merce.
Una volta però m’avvenne di conquistare la sua ammirazione e proprio per me, come sono e giaccio, ed anzi proprio per le mie qualità peggiori. Possedevamo io e lui da vario tempo delle azioni di una fabbrica di zucchero dalla quale si attendevano miracoli. Invece le azioni ribassavano, tenuemente, ma ogni giorno, e Giovanni, che non intendeva di nuotare contro corrente, si disfece delle sue e mi convinse di vendere le mie. Perfettamente d’accordo, mi proposi di dare quell’ordine di vendita al mio agente e intanto ne presi nota in un libretto che in quel torno di tempo avevo di nuovo istituito. Ma si sa che la tasca non si vede durante il giorno e così per varie sere ebbi la sorpresa di ritrovare nella mia quell’annotazione al momento di coricarmi e troppo tardi perché mi servisse. Una volta gridai dal dispiacere e, per non dover dare troppe spiegazioni a mia moglie le dissi che m’ero morsa la lingua. Un’altra volta, stupito di tanta sbadataggine, mi morsi le mani. «Occhio ai piedi, ora!» disse mia moglie ridendo. Poi non vi furono altri malanni perché vi ero abituato. Guardavo istupidito quel maledetto libretto troppo sottile per farsi percepire durante il giorno con la sua pressione e non ci pensavo più sino alla sera appresso.
Un giorno un improvviso acquazzone mi costrinse di rifugiarmi al Tergesteo. Colà trovai per caso il mio agente il quale mi raccontò che negli ultimi otto giorni il prezzo di quelle azioni s’era quasi raddoppiato.
– Ed io ora vendo! – esclamai trionfalmente.
Corsi da mio suocero il quale già sapeva dell’aumento di prezzo di quelle azioni e si doleva di aver vendute le sue e un po’ meno di avermi indotto a vendere le mie.
– Abbi pazienza! – disse ridendo. – È la prima volta che perdi per aver seguito un mio consiglio.
L’altro affare non era risultato da un suo consiglio ma da una sua proposta ciò che, secondo lui, era molto differente.
Io mi misi a ridere di gusto.
– Ma io non ho mica seguito quel consiglio! – Non mi bastava la fortuna e tentai di farmene un merito. Gli raccontai che le azioni sarebbero state vendute solo la dimane e, assumendo un’aria d’importanza, volli fargli credere che io avessi avuto delle notizie che avevo dimenticato di dargli e che m’avevano indotto a non tener conto del suo consiglio.
Torvo e offeso mi parlò senza guardarmi in faccia. – Quando si ha una mente come la tua non ci si occupa di affari. E quando capita di aver commessa una tale malvagità, non la si confessa. Hai da imparare ancora parecchie cose, tu.
Mi spiacque d’irritarlo. Era tanto più divertente quand’egli danneggiava me. Gli raccontai sinceramente com’erano andate le cose.
– Come vedi è proprio con una mente come la mia che bisogna dedicarsi agli affari.
Subito rabbonito, rise con me:
– Non è un utile quello che ricavi da tale affare; è un indenizzo. Quella tua testa ti costò già tanto, ch’è giusto ti rimborsi di una parte della tua perdita!
Non so perché mi fermai tanto a raccontare dei dissidi ch’ebbi con lui e che sono tanto pochi. Io gli volli veramente bene, tant’è vero che ricercai la sua compagnia ad onta che avesse l’abitudine di urlare per pensare più chiaramente. Il mio timpano sapeva sopportare le sue urla. Se le avesse gridate meno, quelle sue teorie immorali sarebbero state più offensive e, se egli fosse stato educato meglio, la sua forza sarebbe sembrata meno importante. E ad onta ch’io fossi tanto differente da lui, credo ch’egli abbia corrisposto al mio con un affetto simile. Lo saprei con maggiore sicurezza se egli non fosse morto tanto presto. Continuò a darmi assiduamente delle lezioni dopo il mio matrimonio e le condì spesso di urla ed insolenze che io accettavo convinto di meritarle.
Sposai sua figlia. Madre natura misteriosa mi diresse e si vedrà con quale violenza imperativa. Adesso io talvolta scruto le faccie dei miei figliuoli e indago se accanto al mento sottile mio, indizio di debolezza, accanto agli occhi di sogno miei, ch’io loro tramandai, non vi sia in loro almeno qualche tratto della forza brutale del nonno ch’io loro elessi.
E alla tomba di mio suocero io piansi ad onta che anche l’ultimo addio che mi diede non sia stato troppo affettuoso. Dal suo letto di morte mi disse che ammirava la mia sfacciata fortuna che mi permetteva di movermi liberamente mentre lui era crocifisso su quel letto. Io, stupito, gli domandai che cosa gli avessi fatto per fargli desiderare di vedermi malato. Ed egli mi rispose proprio così:
– Se dando a te la mia malattia io potessi liberarmene, te la darei subito, magari raddoppiata! Non ho mica le ubbie umanitarie che hai tu!
Non v’era niente di offensivo: egli avrebbe voluto ripetere quell’altro affare col quale gli era riuscito di caricarmi di una merce deprezzata. Poi anche qui c’era stata la carezza perché a me non spiaceva di veder spiegata la mia debolezza con le ubbie umanitarie ch’egli mi attribuiva.
Alla sua tomba come a tutte quelle su cui piansi, il mio dolore fu dedicato anche a quella parte di me stesso che vi era sepolta. Quale diminuzione per me venir privato di quel mio secondo padre, ordinario, ignorante, feroce lottatore che dava risalto alla mia debolezza, la mia cultura, la mia timidezza. Questa è la verità: io sono un timido! Non l’avrei scoperto se non avessi qui studiato Giovanni. Chissà come mi sarei conosciuto meglio se egli avesse continuato a starmi accanto!
Presto m’accorsi che al tavolo del Tergesteo, dove si divertiva a rivelarsi quale era e anche un poco peggiore, Giovanni s’imponeva una riserva: non parlava mai di casa sua o soltanto quando vi era costretto, compostamente e con voce un poco più dolce del solito. Portava un grande rispetto alla sua casa e forse non tutti coloro che sedevano a quel tavolo gli sembravano degni di saperne qualche cosa. Colà appresi soltanto che le sue quattro figliuole avevano tutti i nomi dall’iniziale in a, una cosa praticissima, secondo lui, perché le cose su cui era impressa quell’iniziale potevano passare dall’una all’altra, senz’aver da subire dei mutamenti. Si chiamavano (seppi subito a mente quei nomi): Ada, Augusta, Alberta e Anna. A quel tavolo si disse anche che tutt’e quattro erano belle. Quell’iniziale mi colpì molto più di quanto meritasse. Sognai di quelle quattro fanciulle legate tanto bene insieme dal loro nome. Pareva fossero da consegnarsi in fascio. L’iniziale diceva anche qualche cosa d’altro. Io mi chiamo Zeno ed avevo perciò il sentimento che stessi per prendere moglie lontano dal mio paese.
Fu forse un caso che prima di presentarmi in casa Malfenti io mi fossi liberato da un legame abbastanza antico con una donna che forse avrebbe meritato un trattamento migliore. Ma un caso che dà da pensare. La decisione a tale distacco fu presa per ragione ben lieve. Alla poverina era parso un bel sistema di legarmi meglio a lei, quello di rendermi geloso. Il sospetto invece bastò per indurmi ad abbandonarla definitivamente. Essa non poteva sapere che io allora ero invaso dall’idea del matrimonio e che credevo di non poter contrarlo con lei, solo perché con lei la novità non mi sarebbe sembrata abbastanza grande. Il sospetto ch’essa aveva fatto nascere in me ad arte era una dimostrazione della superiorità del matrimonio nel quale tali sospetti non devono sorgere. Quando quel sospetto di cui sentii presto l’inconsistenza dileguò, ricordai anche ch’essa spendeva troppo. Oggidì, dopo ventiquattr’anni di onesto matrimonio, non sono più di quel parere.
Per essa fu una vera fortuna perché, pochi mesi dopo, fu sposata da persona molto abbiente ed ottenne l’ambito mutamento prima di me. Non appena sposato, me la trovai in casa perché il marito era un amico di mio suocero. C’incontrammo spesso, ma, per molti anni, finché fummo giovani, fra noi regnò il massimo riserbo e mai si fece allusione al passato. L’altro giorno ella mi domandò a bruciapelo, con la sua faccia incorniciata da capelli grigi giovanilmente arrossata:
– Perché mi abbandonaste?
Io fui sincero perché non ebbi il tempo necessario per confezionare una bugia:
– Non lo so più, ma ignoro anche tante altre cose della mia vita.
– A me dispiace, – ella disse e già m’inchinavo al complimento che così mi prometteva. – Nella vecchiaia mi sembrate un uomo molto divertente. – Mi rizzai con uno sforzo. Non era il caso di ringraziare.
Un giorno appresi che la famiglia Malfenti era ritornata in città da un viaggio di piacere abbastanza prolungato seguito al soggiorno estivo in campagna. Non arrivai a fare alcun passo per essere introdotto in quella casa perché Giovanni mi prevenne.
Mi fece vedere la lettera di un suo amico intimo che domandava mie nuove: Era stato mio compagno di studii costui e gli avevo voluto molto bene finché l’avevo creduto destinato a divenire un grande chimico. Ora, invece, di lui non m’importava proprio niente perché s’era trasformato in un grande commerciante in concimi ed io come tale non lo conoscevo affatto. Giovanni m’invitò a casa sua proprio perché ero l’amico di quel suo amico e, – si capisce, – io non protestai affatto.
Quella prima visita io la ricordo come se l’avessi fatta ieri. Era un pomeriggio fosco e freddo d’autunno; e ricordo persino il sollievo che mi derivò dal liberarmi del soprabito nel tepore di quella casa. Stavo proprio per arrivare in porto. Ancora adesso sto ammirando tanta cecità che allora mi pareva chiaroveggenza. Correvo dietro alla salute, alla legittimità. Sta bene che in quell’iniziale a erano racchiuse quattro fanciulle, ma tre di loro sarebbero state eliminate subito e in quanto alla quarta anch’essa avrebbe subito un esame severo. Giudice severissimo sarei stato. Ma intanto non avrei saputo dire le qualità che avrei domandate da lei e quelle che avrei abbominate.
Nel salotto elegante e vasto fornito di mobili in due stili differenti, di cui uno Luigi XIV e l’altro veneziano ricco di oro impresso anche sui cuoi, diviso dai mobili in due parti, come allora si usava, trovai la sola Augusta che leggeva accanto ad una finestra. Mi diede la mano, sapeva il mio nome e arrivò a dirmi ch’ero atteso perché il suo babbo aveva preavvisata la mia visita. Poi corse via a chiamare la madre.
Ecco che delle quattro fanciulle dalla stessa iniziale una ne moriva in quanto mi riguardava. Come avevano fatto a dirla bella? La prima cosa che in lei si osservava era lo strabismo tanto forte che, ripensando a lei dopo di non averla vista per qualche tempo, la personificava tutta. Aveva poi dei capelli non molto abbondanti, biondi, ma di un colore fosco privo di luce e la figura intera non disgraziata, pure un po’ grossa per quell’età. Nei pochi istanti in cui restai solo pensai: «Se le altre tre somigliano a questa!…»
Poco dopo il gruppo delle fanciulle si ridusse a due. Una di esse, ch’entrò con la mamma, non aveva che otto anni. Carina quella bambina dai capelli inanellati, luminosi, lunghi e sciolti sulle spalle! Per la sua faccia pienotta e dolce pareva un’angioletta pensierosa (finché stava zitta) di quel pensiero come se lo figurava Raffaello Sanzio.
Mia suocera… Ecco! Anch’io provo un certo ritegno a parlarne con troppa libertà! Da molti anni io le voglio bene perché è mia madre, ma sto raccontando una vecchia storia nella quale essa non figurò quale mia amica e intendo di non rivolgerle neppure in questo fascicolo, ch’essa mai vedrà, delle parole meno che rispettose. Del resto il suo intervento fu tanto breve che avrei potuto anche dimenticarlo: Un colpetto al momento giusto, non più forte di quanto occorse per farmi perdere il mio equilibrio labile. Forse l’avrei perduto anche senza il suo intervento, eppoi chissà se essa volle proprio quello che avvenne? È tanto bene educata che non può capitarle come al marito di bere troppo per rivelarmi i miei affari. Infatti mai le accadde nulla di simile e perciò io sto raccontando una storia che non conosco bene; non so cioè se sia dovuta alla sua furberia o alla mia bestialità ch’io abbia sposata quella delle sue figliuole ch’io non volevo.
Intanto posso dire che all’epoca di quella mia prima visita mia suocera era tuttavia una bella donna. Era elegante anche per il suo modo di vestire di un lusso poco appariscente. Tutto in lei era mite e intonato.
Avevo così nei miei stessi suoceri un esempio d’integrazione fra marito e moglie quale io la sognavo. Erano stati felicissimi insieme, lui sempre vociando e lei sorridendo di un sorriso che nello stesso tempo voleva dire consenso e compatimento. Essa amava il suo grosso uomo ed egli deve averla conquistata e conservata a furia di buoni affari. Non l’interesse, ma una vera ammirazione la legava a lui, un’ammirazione cui io partecipavo e che perciò facilmente intendevo. Tanta vivacità messa da lui in un ambito tanto ristretto, una gabbia in cui non v’era altro che una merce e due nemici (i due contraenti) ove nascevano e si scoprivano sempre delle nuove combinazioni e relazioni, animava meravigliosamente la vita. Egli le raccontava tutti i suoi affari e lei era tanto bene educata da non dare mai dei consigli perché avrebbe temuto di fuorviarlo. Egli sentiva il bisogno di tale muta assistenza e talvolta correva a casa a monologare nella convinzione di andar a prendere consiglio dalla moglie.
Non fu una sorpresa per me quando appresi ch’egli la tradiva, ch’essa lo sapeva e che non gliene serbava rancore. Io ero sposato da un anno allorché un giorno Giovanni, turbatissimo, mi raccontò che aveva smarrita una lettera di cui molto gl’importava e volle rivedere delle carte che m’aveva consegnate sperando di ritrovarla fra quelle. Invece, pochi giorni appresso, tutto lieto, mi raccontò che l’aveva ritrovata nel proprio portafogli. «Era di una donna?» domandai io, e lui accennò di sì con la testa, vantandosi della sua buona fortuna. Poi io, per difendermi, un giorno in cui m’accusavano di aver perdute delle carte, dissi a mia moglie e a mia suocera che non potevo avere la fortuna del babbo cui le carte ritornavano da sole al portafogli. Mia suocera si mise a ridere tanto di gusto ch’io non dubitai che quella carta non fosse stata rimessa a posto proprio da lei. Evidentemente nella loro relazione ciò non aveva importanza. Ognuno fa all’amore come sa e il loro, secondo me, non ne era il modo più stupido.
La signora m’accolse con grande gentilezza. Si scusò di dover tenere con sé la piccola Anna che aveva il suo quarto d’ora in cui non si poteva lasciarla con altri. La bambina mi guardava studiandomi con gli occhi serii. Quando Augusta ritornò e s’assise su un piccolo sofà posto dirimpetto a quello su cui eravamo io e la signora Malfenti, la piccina andò a coricarsi in grembo alla sorella donde m’osservò per tutto il tempo con una perseveranza che mi divertì finché non seppi quali pensieri si movessero in quella piccola testa.
La conversazione non fu subito molto divertente. La signora, come tutte le persone bene educate, era abbastanza noiosa ad un primo incontro. Mi domandava anche troppe notizie dell’amico che si fingeva m’avesse introdotto in quella casa e di cui io non ricordavo neppure il nome di battesimo.
Entrarono finalmente Ada e Alberta. Respirai: erano belle ambedue e portavano in quel salotto la luce che fino ad allora vi aveva mancato. Ambedue brune e alte e slanciate, ma molto differenti l’una dall’altra. Non era una scelta difficile quella che avevo da fare. Alberta aveva allora non più di diciasett’anni. Come la madre essa aveva – benché bruna – la pelle rosea e trasparente, ciò che aumentava l’infantilità del suo aspetto. Ada, invece, era già una donna con i suoi occhi serii in una faccia che per essere meglio nivea era un poco azzurra e la sua capigliatura ricca, ricciuta, ma accomodata con grazia e severità.
È difficile di scoprire le origini miti di un sentimento divenuto poi tanto violento, ma io sono certo che da me mancò il cosidetto coup de foudre per Ada. Quel colpo di fulmine, però, fu sostituito dalla convinzione ch’ebbi immediatamente che quella donna fosse quella di cui abbisognavo e che doveva addurmi alla salute morale e fisica per la santa monogamia. Quando vi ripenso resto sorpreso che sia mancato quel colpo di fulmine e che vi sia stata invece quella convinzione. È noto che noi uomini non cerchiamo nella moglie le qualità che adoriamo e disprezziamo nell’amante. Sembra dunque ch’io non abbia subito vista tutta la grazia e tutta la bellezza di Ada e che mi sia invece incantato ad ammirare altre qualità ch’io le attribuii di serietà e anche di energia, insomma, un po’ mitigate, le qualità ch’io amavo nel padre suo. Visto che poi credetti (come credo ancora) di non essermi sbagliato e che tali qualità Ada da fanciulla avesse possedute, posso ritenermi un buon osservatore ma un buon osservatore alquanto cieco. Quella prima volta io guardai Ada con un solo desiderio: quello di innamorarmene perché bisognava passare per di là per sposarla. Mi vi accinsi con quell’energia ch’io sempre dedico alle mie pratiche igieniche. Non so dire quando vi riuscii; forse già nel tempo relativamente piccolo di quella prima visita.
Giovanni doveva aver parlato molto di me alle figliuole sue. Esse sapevano, fra altro, ch’ero passato nei miei studii dalla facoltà di legge a quella di chimica per ritornare – pur troppo! – alla prima. Cercai di spiegare: era certo che quando ci si rinchiudeva in una facoltà, la parte maggiore dello scibile restava coperta dall’ignoranza. E dicevo:
– Se ora su di me non incombesse la serietà della vita, – e non dissi che tale serietà io la sentivo da poco tempo, dacché avevo risolto di sposarmi – io sarei passato ancora di facoltà in facoltà.
Poi, per far ridere, dissi ch’era curioso ch’io abbandonassi una facoltà proprio al momento di dare gli esami.
– Era un caso – dicevo col sorriso di chi vuol far credere che stia dicendo una bugia. E invece era vero ch’io avevo cambiato di studii nelle più varie stagioni.
Partii così alla conquista di Ada e continuai sempre nello sforzo di farla ridere di me e alle spalle mie dimenticando ch’io l’avevo prescelta per la sua serietà. Io sono un po’ bizzarro, ma a lei dovetti apparire veramente squilibrato. Non tutta la colpa è mia e lo si vede dal fatto che Augusta e Alberta, ch’io non avevo prescelte, mi giudicarono altrimenti. Ma Ada, che proprio allora era tanto seria da girare intorno i begli occhi alla ricerca dell’uomo ch’essa avrebbe ammesso nel suo nido, era incapace di amare la persona che la faceva ridere. Rideva, rideva a lungo, troppo a lungo e il suo riso copriva di un aspetto ridicolo la persona che l’aveva provocato. La sua era una vera inferiorità e doveva finire col danneggiarla, ma danneggiò prima me. Se avessi saputo tacere a tempo forse le cose sarebbero andate altrimenti. Intanto le avrei lasciato il tempo perché parlasse lei, mi si rivelasse e potessi guardarmene.
Le quattro fanciulle erano sedute sul piccolo sofà sul quale stavano a stento ad onta che Anna sedesse sulle ginocchia di Augusta. Erano belle così insieme. Lo constatai con un’intima soddisfazione vedendo ch’ero avviato magnificamente all’ammirazione e all’amore. Veramente belle! Il colore sbiadito di Augusta serviva a dare rilievo al color bruno delle capigliature delle altre.
Io avevo parlato dell’Università e Alberta, che stava facendo il penultimo anno del ginnasio, raccontò dei suoi studii. Si lamentò che il latino le riusciva molto difficile. Dissi di non meravigliarmene perché era una lingua che non faceva per le donne, tanto ch’io pensavo che già dagli antichi romani le donne avessero parlato l’italiano. Invece per me – asserii – il latino aveva rappresentata la materia prediletta. Poco dopo però commisi la leggerezza di fare una citazione latina che Alberta dovette correggermi. Un vero infortunio! Io non vi diedi importanza e avvertii Alberta che quando essa avesse avuto dietro di sé una diecina di semestri d’Università, anche lei avrebbe dovuto guardarsi dal fare citazioni latine.
Ada che recentemente era stata col padre per qualche mese in Inghilterra, raccontò che in quel paese molte fanciulle sapevano il latino. Poi sempre con la sua voce seria, aliena da ogni musicalità, un po’ più bassa di quella che si sarebbe aspettata dalla sua gentile personcina, raccontò che le donne in Inghilterra erano tutt’altra cosa che da noi. S’associavano per scopi di beneficenza, religiosi o anche economici. Ada veniva spinta a parlare dalle sorelle che volevano riudire quelle cose che apparivano meravigliose a fanciulle della nostra città in quell’epoca. E, per compiacerle, Ada raccontò di quelle donne presidentesse, giornaliste, segretarie e propagandiste politiche che salivano il pulpito per parlare a centinaia di persone senz’arrossire e senza confondersi quando venivano interrotte o vedevano confutati i loro argomenti. Diceva semplicemente, con poco colore, senz’alcuna intenzione di far meravigliare o ridere.
Io amavo la sua parola semplice, io, che come aprivo la bocca svisavo cose o persone perché altrimenti mi sarebbe sembrato inutile di parlare. Senz’essere un oratore, avevo la malattia della parola. La parola doveva essere un avvenimento a sé per me e perciò non poteva essere imprigionata da nessun altro avvenimento.
Ma io avevo uno speciale odio per la perfida Albione e lo manifestai senza temere di offendere Ada che del resto non aveva manifestato né odio né amore per l’Inghilterra. Io vi avevo trascorso alcuni mesi, ma non vi avevo conosciuto alcun inglese di buona società visto che avevo smarrite in viaggio alcune lettere di presentazione ottenute da amici d’affari di mio padre. A Londra perciò avevo praticato solo alcune famiglie francesi ed italiane e finito col pensare che tutte le persone dabbene in quella città provenissero dal continente. La mia conoscenza dell’inglese era molto limitata. Con l’aiuto degli amici potei tuttavia intendere qualche cosa della vita di quegl’isolani e sopra tutto fui informato della loro antipatia per tutti i non inglesi.
Descrissi alle fanciulle il sentimento poco gradevole che mi veniva dal soggiorno in mezzo a nemici. Avrei però resistito e sopportata l’Inghilterra per quei sei mesi che mio padre e l’Olivi volevano infliggermi acciocché studiassi il commercio inglese (in cui intanto non m’imbattei mai perché pare si faccia in luoghi reconditi) se non mi fosse toccata un’avventura sgradevole. Ero andato da un libraio a cercare un vocabolario. In quel negozio, sul banco, riposava sdraiato un grosso, magnifico gatto àngora che proprio attirava le carezze sul soffice pelo. Ebbene! Solo perché dolcemente l’accarezzai, esso proditoriamente m’assaltò e mi graffiò malamente le mani. Da quel momento non seppi più sopportare l’Inghilterra e il giorno appresso mi trovavo a Parigi.
Augusta, Alberta e anche la signora Malfenti risero di cuore. Ada invece era stupita e credeva di avere frainteso. Era stato almeno il libraio stesso che m’aveva offeso e graffiato? Dovetti ripetermi, ciò ch’è noioso perché si ripete male.
Alberta, la dotta, volle aiutarmi:
– Anche gli antichi si lasciavano dirigere nelle loro decisioni dai movimenti degli animali.
Non accettai l’aiuto. Il gatto inglese non s’era mica atteggiato ad oracolo; aveva agito da fato!
Ada, coi grandi occhi spalancati, volle delle altre spiegazioni:
– E il gatto rappresentò per voi l’intero popolo inglese?
Com’ero sfortunato! Per quanto vera, quell’avventura a me era parsa istruttiva e interessante come se a scopi precisi fosse stata inventata. Per intenderla non bastava ricordare che in Italia dove conosco ed amo tanta gente, l’azione di quel gatto non avrebbe potuto assurgere a tale importanza? Ma io non dissi questo e dissi invece:
– È certo che nessun gatto italiano sarebbe capace di una tale azione.
Ada rise a lungo, molto a lungo. Mi parve persino troppo grande il mio successo perché m’immiserii e immiserii la mia avventura con ulteriori spiegazioni:
– Lo stesso libraio fu stupito del contegno del gatto che con tutti gli altri si comportava bene. L’avventura toccò a me perché ero io o forse perché ero italiano. It was really disgusting e dovetti fuggire.
Qui avvenne qualche cosa che pur avrebbe dovuto avvisarmi e salvarmi. La piccola Anna che fino ad allora era rimasta immota ad osservarmi, a gran voce si diede ad esprimere il sentimento di Ada. Gridò:
– È vero ch’è pazzo, pazzo del tutto?
La signora Malfenti la minacciò:
– Vuoi stare zitta? Non ti vergogni d’ingerirti nei discorsi dei grandi?
La minaccia fece peggio. Anna gridò:
– È pazzo! Parla coi gatti! Bisognerebbe procurarsi subito delle corde per legarlo!
Augusta, rossa dal dispiacere, si alzò e la portò via ammonendola e domandandomi nello stesso tempo scusa. Ma ancora alla porta la piccola vipera poté fissarmi negli occhi, farmi una brutta smorfia e gridarmi.
– Vedrai che ti legheranno!
Ero stato assaltato tanto impensatamente che non subito seppi trovare il modo di difendermi. Mi sentii però sollevato all’accorgermi che anche Ada era dispiacente di veder dare espressione a quel modo al suo proprio sentimento. L’impertinenza della piccina ci riavvicinava.
Raccontai ridendo di cuore ch’io a casa possedevo un certificato regolarmente bollato che attestava in tutte le forme la mia sanità di mente. Così appresero del tiro che avevo giocato al mio vecchio padre. Proposi di produrre quel certificato alla piccola Annuccia.
Quando accennai di andarmene non me lo permisero. Volevano che prima dimenticassi i graffi inflittimi da quell’altro gatto. Mi trattennero con loro, offrendomi una tazza di tè.
È certo ch’io oscuramente sentii subito che per esser gradito da Ada avrei dovuto essere un po’ differente di quanto ero; pensai che mi sarebbe stato facile di divenire quale essa mi voleva. Si continuò a parlare della morte di mio padre e a me parve che rivelando il grande dolore che tuttavia mi pesava, la seria Ada avrebbe potuto sentirlo con me. Ma subito, nello sforzo di somigliarle, perdetti la mia naturalezza e perciò da lei – come si vide subito – m’allontanai. Dissi che il dolore per una simile perdita era tale che se io avessi avuto dei figliuoli avrei cercato di fare in modo che m’amassero meno per risparmiare loro più tardi di soffrire tanto per la mia dipartita. Fui un poco imbarazzato quando mi domandarono in qual modo mi sarei comportato per raggiungere tale scopo. Maltrattarli e picchiarli? Alberta, ridendo, disse:
– Il mezzo più sicuro sarebbe di ucciderli.
Vedevo che Ada era animata dal desiderio di non spiacermi. Perciò esitava; ma ogni suo sforzo non poteva condurla oltre l’esitazione. Poi disse che vedeva ch’era per bontà ch’io pensavo di organizzare così la vita dei miei figliuoli, ma che non le pareva giusto di vivere per prepararsi alla morte. M’ostinai e asserii che la morte era la vera organizzatrice della vita. Io sempre alla morte pensavo e perciò non avevo che un solo dolore: La certezza di dover morire. Tutte le altre cose divenivano tanto poco importanti che per esse non avevo che un lieto sorriso o un riso altrettanto lieto. M’ero lasciato trascinare a dire delle cose ch’erano meno vere, specie trovandomi con lei, una parte della mia vita già tanto importante. In verità io credo di averle parlato così per il desiderio di farle sapere ch’io ero un uomo tanto lieto. Spesso la lietezza m’aveva favorito con le donne.
Pensierosa ed esitante, essa mi confessò che non amava uno stato d’animo simile. Diminuendo il valore della vita, si rendeva questa anche più pericolante di quanto madre natura avesse voluto. Veramente ella m’aveva detto che non facevo per lei, ma ero tuttavia riuscito a renderla esitante e pensierosa e mi parve un successo.
Alberta citò un filosofo antico che doveva somigliarmi nell’interpretazione della vita e Augusta disse che il riso era una gran bella cosa. Anche suo padre ne era ricco.
– Perché gli piacciono i buoni affari – disse la signora Malfenti ridendo.
Interruppi finalmente quella visita memoranda.
Non v’è niente di più difficile a questo mondo che di fare un matrimonio proprio come si vuole. Lo si vede dal caso mio ove la decisione di sposarmi aveva preceduto di tanto la scelta della fidanzata. Perché non andai a vedere tante e tante ragazze prima di sceglierne una? No! Pareva proprio mi fosse spiaciuto di vedere troppe donne e non volli faticare. Scelta la fanciulla, avrei anche potuto esaminarla un po’ meglio e accertarmi almeno ch’essa sarebbe stata disposta di venirmi incontro a mezza strada come si usa nei romanzi d’amore a conclusione felice. Io, invece, elessi la fanciulla dalla voce tanto grave e dalla capigliatura un po’ ribelle, ma assettata severamente e pensai che, tanto seria, non avrebbe rifiutato un uomo intelligente, non brutto, ricco e di buona famiglia come ero io. Già alle prime parole che scambiammo sentii qualche stonatura, ma la stonatura è la via all’unisono. Devo anzi confessare che pensai: «Ella deve rimanere quale è, poiché così mi piace e sarò io che mi cambierò se essa lo vorrà». In complesso ero ben modesto perché è certamente più facile di mutare sé stesso che non di rieducare altri.
Dopo brevissimo tempo la famiglia Malfenti divenne il centro della mia vita. Ogni sera la passavo con Giovanni che, dopo che m’aveva introdotto in casa sua, s’era fatto con me anche più affabile e intimo. Fu tale affabilità che mi rese invadente. Dapprima feci visita alle sue signore una volta alla settimana, poi più volte e finii coll’andare in casa sua ogni giorno a passarci varie ore del pomeriggio. Per insediarmi in quella casa non mancarono pretesti ed io credo di non sbagliare asserendo che mi fossero anche offerti. Portai talvolta con me il mio violino e passai qualche poco di musica con Augusta, la sola che in quella casa sonasse il piano. Era male che Ada non sonasse, poi era male che io sonassi tanto male il violino e malissimo che Augusta non fosse una grande musicista. Di ogni sonata io ero obbligato di eliminare qualche periodo perché troppo difficile, col pretesto non vero di non aver toccato il violino da troppo tempo. Il pianista è quasi sempre superiore al dilettante violinista e Augusta aveva una tecnica discreta, ma io, che sonavo tanto peggio di lei, non sapevo dirmene contento e pensavo: «Se sapessi sonare come lei, come sonerei meglio!» Intanto ch’io giudicavo Augusta, gli altri giudicavano me e, come appresi più tardi, non favorevolmente. Poi Augusta avrebbe volentieri ripetute le nostre sonate, ma io m’accorsi che Ada vi si annoiava e perciò finsi più volte di aver dimenticato il violino a casa. Augusta allora non ne parlò più.
Purtroppo io non vivevo solo con Ada le ore che passavo in quella casa. Essa ben presto m’accompagnò il giorno intero. Era la donna da me prescelta, era perciò già mia ed io l’adornai di tutti i sogni perché il premio della vita m’apparisse più bello. L’adornai, le prestai tutte le tante qualità di cui sentivo il bisogno e che a me mancavano, perché essa doveva divenire oltre che la mia compagna anche la mia seconda madre che m’avrebbe addotto a una vita intera, virile, di lotta, e di vittoria.
Nei miei sogni anche fisicamente l’abellii prima di consegnarla ad altri. In realtà io nella mia vita corsi dietro a molte donne e molte di esse si lasciarono anche raggiungere. Nel sogno le raggiunsi tutte. Naturalmente non le abbellisco alterandone i tratti, ma faccio come un mio amico, pittore delicatissimo, che quando ritratta delle donne belle, pensa intensamente anche a qualche altra bella cosa per esempio a della porcellana finissima. Un sogno pericoloso perché può conferire nuovo potere alle donne di cui si sognò e che rivedendo alla luce reale conservano qualche cosa delle frutta, dei fiori e della porcellana da cui furono vestite.
M’è difficile di raccontare della mia corte ad Ada. Vi fu poi una lunga epoca della mia vita in cui io mi sforzai di dimenticare la stupida avventura che proprio mi faceva vergognare di quella vergogna che fa gridare e protestare. «Non sono io che fui tanto bestia!». E chi allora? Ma la protesta conferisce pure un po’ di sollievo ed io vi insistetti. Meno male se avessi agito a quel modo un dieci anni prima, a vent’anni! Ma esser stato punito di tanta bestialità solo perché avevo deciso di sposarmi, mi pare proprio ingiusto. Io che già ero passato per ogni specie di avventure condotte sempre con uno spirito intraprendente che arrivava alla sfacciataggine, ecco ch’ero ridivenuto il ragazzetto timido che tenta di toccar la mano dell’amata magari senza ch’essa se ne avveda, eppoi adora quella parte del proprio corpo ch’ebbe l’onore di simile contatto. Questa ch’è stata la più pura avventura della mia vita, anche oggi che son vecchio io la ricordo quale la più turpe. Era fuori di posto, fuori di tempo quella roba, come se un ragazzo di dieci anni si fosse attaccato al petto della balia. Che schifo!
Come spiegare poi la mia lunga esitazione di parlare chiaro e dire alla fanciulla: Risolviti! Mi vuoi o non mi vuoi? Io andavo a quella casa arrivandovi dai miei sogni; contavo gli scalini che mi conducevano a quel primo piano dicendomi che se erano dispari ciò avrebbe provato ch’essa m’amava ed erano sempre dispari essendovene quarantatré. Arrivavo a lei accompagnato da tanta sicurezza e finivo col parlare di tutt’altra cosa. Ada non aveva ancora trovata l’occasione di significarmi il suo disdegno ed io tacevo! Anch’io al posto di Ada avrei accolto quel giovinetto di trent’anni a calci nel sedere!
Devo dire che in certo rapporto io non somigliavo esattamente al ventenne innamorato il quale tace aspettando che l’amata gli si getti al collo. Non m’aspettavo niente di simile. Io avrei parlato, ma più tardi. Se non procedevo, ciò era dovuto ai dubbii su me stesso. Io m’aspettavo di divenire più nobile, più forte, più degno della mia divina fanciulla. Ciò poteva avvenire da un giorno all’altro. Perché non aspettare?
Mi vergogno anche di non essermi accorto a tempo ch’ero avviato ad un fiasco simile. Avevo da fare con una fanciulla delle più semplici e fu a forza di sognarne ch’essa m’apparì quale una civetta delle più consumate. Ingiusto quell’enorme mio rancore quand’essa riuscì a farmi vedere ch’essa di me non ne voleva sapere. Ma io avevo mescolato tanto intimamente la realtà ai sogni che non riuscivo a convincermi ch’essa mai m’avesse baciato.
È proprio un indizio di scarsa virilità quello di fraintendere le donne. Prima non avevo sbagliato mai e devo credere di essermi ingannato sul conto di Ada per avere da bel principio falsati i miei rapporti con lei. A lei m’ero avvicinato non per conquistarla ma per sposarla ciò ch’è una via insolita dell’amore, una via ben larga, una via ben comoda, ma che conduce non alla mèta per quanto ben vicino ad essa. All’amore cui così si giunge manca la caratteristica principale: l’assoggettamento della femmina. Così il maschio si prepara alla sua parte in una grande inerzia che può estendersi a tutti i suoi sensi, anche a quelli della vista e dell’udito.
Io portai giornalmente dei fiori a tutt’e tre le fanciulle e a tutt’e tre regalai le mie bizzarrie e, sopra tutto, con una leggerezza incredibile, giornalmente feci loro la mia autobiografia.
A tutti avviene di ricordarsi con più fervore del passato quando il presente acquista un’importanza maggiore. Dicesi anzi che i moribondi, nell’ultima febbre, rivedano tutta la loro vita. Il mio passato m’afferrava ora con la violenza dell’ultimo addio perché io avevo il sentimento di allontanarmene di molto. E parlai sempre di questo passato alle tre fanciulle, incoraggiato dall’attenzione intensa di Augusta e di Alberta che, forse, copriva la disattenzione di Ada di cui non sono sicuro. Augusta, con la sua indole dolce, facilmente si commoveva e Alberta stava a sentire le mie descrizioni di scapigliatura studentesca con le guancie arrossate dal desiderio di poter in avvenire passare anch’essa per avventure simili.
Molto tempo dopo appresi da Augusta che nessuna delle tre fanciulle aveva creduto che le mie storielle fossero vere. Ad Augusta apparvero perciò più preziose perché, inventate da me, le sembrava fossero più mie che se il destino me le avesse inflitte. Ad Alberta quella parte in cui non credette fu tuttavia gradevole perché vi scorse degli ottimi suggerimenti. La sola che si fosse indignata delle mie bugie fu la seria Ada. Coi miei sforzi a me toccava come a quel tiratore cui era riuscito di colpire il centro del bersaglio, però di quello posto accanto al suo.
Eppure in gran parte quelle storielle erano vere. Non so più dire in quanta parte perché avendole raccontate a tante altre donne prima che alle figlie del Malfenti, esse, senza ch’io lo volessi, si alterarono per divenire più espressive. Erano vere dal momento che io non avrei più saputo raccontarle altrimenti. Oggidì non m’importa di provarne la verità. Non vorrei disingannare Augusta che ama crederle di mia invenzione. In quanto ad Ada io credo che ormai ella abbia cambiato di parere e le ritenga vere.
Il mio totale insuccesso con Ada si manifestò proprio nel momento in cui giudicavo di dover finalmente parlar chiaro. Ne accolsi l’evidenza con sorpresa e dapprima con incredulità. Non era stata detta da lei una sola parola che avesse manifestata la sua avversione per me ed io intanto chiusi gli occhi per non vedere quei piccoli atti che non mi significavano una grande simpatia. Eppoi io stesso non avevo detta la parola necessaria e potevo persino figurarmi che Ada non sapesse ch’io ero là pronto per sposarla e potesse credere che io – lo studente bizzarro e poco virtuoso – volessi tutt’altra cosa.
Il malinteso si prolungava sempre a causa di quelle mie intenzioni troppo decisamente matrimoniali. Vero è che oramai desideravo tutta Ada cui avevo continuato a levigare assiduamente le guancie, a impicciolire le mani e i piedi e ad isveltire e affinare la taglia. La desideravo quale moglie e quale amante. Ma è decisivo il modo con cui si avvicina per la prima volta una donna.
Ora avvenne che per ben tre volte consecutive, in quella casa fossi ricevuto dalle altre due fanciulle. L’assenza di Ada fu scusata la prima volta con una visita doverosa, la seconda con un malessere e la terza non mi si disse alcuna scusa finché io, allarmato, non lo domandai. Allora Augusta, a cui per caso m’ero rivolto, non rispose. Rispose per lei Alberta ch’essa aveva guardata come per invocarne l’assistenza: Ada era andata da una zia.
A me mancò il fiato. Era evidente che Ada mi evitava. Il giorno prima ancora io avevo sopportata la sua assenza ed avevo anzi prolungata la mia visita sperando ch’essa pur avrebbe finito coll’apparire. Quel giorno, invece, restai ancora per qualche istante, incapace di aprir bocca, eppoi protestando un improvviso male di testa m’alzai per andarmene. Curioso che quella prima volta il più forte sentimento che sentissi allo scontrarmi nella resistenza di Ada fosse di collera e sdegno! Pensai anche di appellarmi a Giovanni per mettere la fanciulla all’ordine. Un uomo che vuole sposarsi è anche capace di azioni simili, ripetizioni di quelle dei suoi antenati.
Quella terza assenza di Ada doveva divenire anche più significativa. Il caso volle ch’io scoprissi ch’essa si trovava in casa, ma rinchiusa nella sua stanza.
Devo prima di tutto dire che in quella casa v’era un’altra persona ch’io non ero riuscito a conquistare: la piccola Anna. Dinanzi agli altri essa non m’aggrediva più, perché l’avevano redarguita duramente. Anzi qualche volta anch’essa s’era accompagnata alle sorelle ed era stata a sentire le mie storielle. Quando però me ne andavo, essa mi raggiungeva alla soglia, gentilmente mi pregava di chinarmi a lei, si rizzava sulle punte dei piedini e quando arrivava a far addirittura aderire la boccuccia al mio orecchio, mi diceva abbassando la voce in modo da non poter essere udita che da me:
– Ma tu sei pazzo, veramente pazzo!
Il bello si è che dinanzi agli altri la sorniona mi dava del lei. Se c’era presente la signora Malfenti, essa subito si rifugiava nelle sue braccia, e la madre l’accarezzava dicendo:
– Come la mia piccola Anna s’è fatta gentile! Nevvero?
Non protestavo e la gentile Anna mi diede ancora spesso allo stesso modo del pazzo. Io accoglievo la sua dichiarazione con un sorriso vile che avrebbe potuto sembrare di ringraziamento. Speravo che la bambina non avesse il coraggio di raccontare delle sue aggressioni agli adulti e mi dispiaceva di far sapere ad Ada quale giudizio facesse di me la sua sorellina. Quella bambina finì realmente coll’imbarazzarmi. Se, quando parlavo con gli altri, il mio occhio s’incontrava nel suo, subito dovevo trovare il modo di guardare altrove ed era difficile di farlo con naturalezza. Certo arrossivo. Mi pareva che quell’innocente col suo giudizio potesse danneggiarmi. Le portai dei doni, ma non valsero ad ammansarla. Essa dovette accorgersi del suo potere e della mia debolezza e, in presenza degli altri, mi guardava indagatrice, insolente. Credo che tutti abbiamo nella nostra coscienza come nel nostro corpo dei punti delicati e coperti cui non volentieri si pensa. Non si sa neppure che cosa sieno, ma si sa che vi sono. Io stornavo il mio occhio da quello infantile che voleva frugarmi.
Ma quel giorno in cui solo e abbattuto uscivo da quella casa e ch’essa mi raggiunse per farmi chinare a sentire il solito complimento, mi piegai a lei con tale faccia stravolta di vero pazzo e tesi verso di lei con tanta minaccia le mani contratte ad artigli, ch’essa corse via piangendo ed urlando.
Così arrivai a vedere Ada anche quel giorno perché fu lei che accorse a quei gridi. La piccina raccontò singhiozzando ch’io l’avevo minacciata duramente perché essa m’aveva dato del pazzo:
– Perché egli è un pazzo ed io voglio dirglielo. Cosa c’è di male?
Non stetti a sentire la bambina, stupito di vedere che Ada si trovava in casa. Le sue sorelle avevano dunque mentito, anzi la sola Alberta cui Augusta ne aveva passato l’incarico esimendosene essa stessa! Per un istante fui esattamente nel giusto indovinando tutto. Dissi ad Ada:
– Ho piacere di vederla. Credevo si trovasse da tre giorni da sua zia.
Ella non mi rispose perché dapprima si piegò sulla bambina piangente. Quell’indugio di ottenere le spiegazioni cui credevo di aver diritto mi fece salire veemente il sangue alla testa. Non trovavo parole. Feci un altro passo per avvicinarmi alla porta d’uscita e se Ada non avesse parlato, io me ne sarei andato e non sarei ritornato mai più. Nell’ira mi pareva cosa facilissima quella rinunzia ad un sogno che aveva oramai durato tanto a lungo.
Ma intanto essa, rossa, si volse a me e disse ch’era rientrata da pochi istanti non avendo trovata la zia in casa.
Bastò per calmarmi. Com’era cara, così maternamente piegata sulla bambina che continuava ad urlare! Il suo corpo era tanto flessibile che pareva divenuto più piccolo per accostarsi meglio alla piccina. Mi indugiai ad ammirarla considerandola di nuovo mia.
Mi sentii tanto sereno che volli far dimenticare il risentimento che poco prima avevo manifestato e fui gentilissimo con Ada ed anche con Anna. Dissi ridendo di cuore:
– Mi dà tanto spesso del pazzo che volli farle vedere la vera faccia e l’atteggiamento del pazzo. Voglia scusarmi! Anche tu, povera Annuccia, non aver paura perché io sono un pazzo buono.
Anche Ada fu molto, ma molto gentile. Redarguì la piccina che continuava a singhiozzare e mi domandò scusa per essa. Se avessi avuta la fortuna che Anna nell’ira fosse corsa via, io avrei parlato. Avrei detta una frase che forse si trova anche in qualche grammatica di lingue straniere, bell’e fatta per facilitare la vita a chi non conosca la lingua del paese ove soggiorna: «Posso domandare la sua mano a suo padre?». Era la prima volta ch’io volevo sposarmi e mi trovavo perciò in un paese del tutto sconosciuto. Fino ad allora avevo trattato altrimenti con le donne con cui avevo avuto a fare. Le avevo assaltate mettendo loro prima di tutto addosso le mani.
Ma non arrivai a dire neppure quelle poche parole. Dovevano pur stendersi su un certo spazio di tempo! Dovevano esser accompagnate da un’espressione supplice della faccia, difficile a foggiarsi immediatamente dopo la mia lotta con Anna ed anche con Ada, e dal fondo del corridoio s’avanzava già la signora Malfenti richiamata dalle strida della bambina.
Stesi la mano ad Ada, che mi porse subito cordialmente la sua e le dissi:
– Arrivederci domani. Mi scusi con la signora.
Esitai però di lasciar andare quella mano che riposava fiduciosa nella mia. Sentivo che, andandomene allora, rinunziavo ad un’occasione unica con quella fanciulla tutt’intenta ad usarmi delle cortesie per indennizzarmi delle villanie della sorella. Seguii l’ispirazione del momento, mi chinai sulla sua mano e la sfiorai con le mie labbra. Indi apersi la porta e uscii lesto lesto dopo di aver visto che Ada, che fino ad allora m’aveva abbandonata la destra mentre con la sinistra sosteneva Anna che s’aggrappava alla sua gonna, stupita si guardava la manina che aveva subito il contatto delle mie labbra, quasi avesse voluto vedere se ci fosse stato scritto qualche cosa. Non credo che la signora Malfenti avesse scorto il mio atto.
Mi arrestai per un istante sulle scale, stupito io stesso del mio atto assolutamente non premeditato. V’era ancora la possibilità di ritornare a quella porta che avevo chiusa dietro di me, suonare il campanello e domandar di poter dire ad Ada quelle parole ch’essa sulla propria mano aveva cercato invano? Non mi parve! Avrei mancato di dignità dimostrando troppa impazienza. Eppoi avendola prevenuta che sarei ritornato le avevo preannunziate le mie spiegazioni. Non dipendeva ora che da lei di averle, procurandomi l’opportunità di dargliele. Ecco che avevo finalmente cessato di raccontare delle storie a tre fanciulle e avevo invece baciata la mano ad una sola di esse.
Ma il resto della giornata fu piuttosto sgradevole. Ero inquieto e ansioso. Io andavo dicendomi che la mia inquietudine provenisse solo dall’impazienza di veder chiarita quell’avventura. Mi figuravo che se Ada m’avesse rifiutato, io avrei potuto con tutta calma correre in cerca di altre donne. Tutto il mio attaccamento per lei proveniva da una mia libera risoluzione che ora avrebbe potuto essere annullata da un’altra che la cancellasse! Non compresi allora che per il momento a questo mondo non v’erano altre donne per me e che abbisognavo proprio di Ada.
Anche la notte che seguì mi sembrò lunghissima; la passai quasi del tutto insonne. Dopo la morte di mio padre, io avevo abbandonate le mie abitudini di nottambulo e ora, dacché avevo risolto di sposarmi, sarebbe stato strano di ritornarvi. M’ero perciò coricato di buon’ora col desiderio del sonno che fa passare tanto presto il tempo.
Di giorno io avevo accolte con la più cieca fiducia le spiegazioni di Ada su quelle sue tre assenze dal suo salotto nelle ore in cui io vi era, fiducia dovuta alla mia salda convinzione che la donna seria ch’io avevo scelta non sapesse mentire. Ma nella notte tale fiducia diminuì. Dubitavo che non fossi stato io ad informarla che Alberta – quando Augusta aveva rifiutato di parlare – aveva addotta a sua scusa quella visita alla zia. Non ricordavo bene le parole che le avevo dirette con la testa in fiamme, ma credevo di esser certo di averle riferita quella scusa. Peccato! Se non l’avessi fatto, forse lei, per scusarsi, avrebbe inventato qualche cosa di diverso e io, avendola còlta in bugia, avrei già avuto il chiarimento che anelavo.
Qui avrei pur potuto accorgermi dell’importanza che Ada aveva oramai per me, perché per quietarmi io andavo dicendomi che se essa non m’avesse voluto, avrei rinunziato per sempre al matrimonio. Il suo rifiuto avrebbe dunque mutata la mia vita. E continuavo a sognare confortandomi nel pensiero che forse quel rifiuto sarebbe stato una fortuna per me. Ricordavo quel filosofo greco che prevedeva il pentimento tanto per chi si sposava quanto per chi restava celibe. Insomma non avevo ancora perduta la capacità di ridere della mia avventura; la sola capacità che mi mancasse era quella di dormire.
Presi sonno che già albeggiava. Quando mi destai era tanto tardi che poche ore ancora mi dividevano da quella in cui la visita in casa Malfenti m’era permessa. Perciò non vi sarebbe stato più bisogno di fantasticare e raccogliere degli altri indizii che mi chiarissero l’animo di Ada. Ma è difficile di trattenere il proprio pensiero dall’occuparsi di un argomento che troppo c’importa. L’uomo sarebbe un animale più fortunato se sapesse farlo. In mezzo alle cure della mia persona che quel giorno esagerai, io non pensai ad altro: Avevo fatto bene baciando la mano di Ada o avevo fatto male di non baciarla anche sulle labbra?
Proprio quella mattina ebbi un’idea che credo m’abbia fortemente danneggiato privandomi di quel poco d’iniziativa virile che quel mio curioso stato d’adolescenza m’avrebbe concesso. Un dubbio doloroso: e se Ada m’avesse sposato solo perché indottavi dai genitori, senz’amarmi ed anzi avendo una vera avversione per me? Perché certamente tutti in quella famiglia, cioè Giovanni, la signora Malfenti, Augusta e Alberta mi volevano bene; potevo dubitare della sola Ada. Sull’orizzonte si delineava proprio il solito romanzo popolare della giovinetta costretta dalla famiglia ad un matrimonio odioso. Ma io non l’avrei permesso. Ecco la nuova ragione per cui dovevo parlare con Ada, anzi con la sola Ada. Non sarebbe bastato di dirigerle la frase fatta che avevo preparata. Guardandola negli occhi le avrei domandato: «Mi ami tu?» E se essa m’avesse detto di sì, io l’avrei serrata fra le mie braccia per sentirne vibrare la sincerità.
Così mi parve d’essermi preparato a tutto. Invece dovetti accorgermi d’esser arrivato a quella specie d’esame dimenticando di rivedere proprio quelle pagine di testo di cui mi sarebbe stato imposto di parlare.
Fui ricevuto dalla sola signora Malfenti che mi fece accomodare in un angolo del grande salotto e si mise subito a chiacchierare vivacemente impedendomi persino di domandare delle notizie delle fanciulle. Ero perciò alquanto distratto e mi ripetevo la lezione per non dimenticarla al momento buono. Tutt’ad un tratto fui richiamato all’attenzione come da uno squillo di tromba. La signora stava elaborando un preambolo. M’assicurava dell’amicizia sua e del marito e dell’affetto di tutta la famiglia loro, compresavi la piccola Anna. Ci conoscevamo da tanto tempo. Ci eravamo visti giornalmente da quattro mesi.
– Cinque! – corressi io che ne avevo fatto il calcolo nella notte, ricordando che la mia prima visita era stata fatta d’autunno e che ora ci trovavamo in piena primavera.
– Sì! Cinque! – disse la signora pensandoci su come se avesse voluto rivedere il mio calcolo. Poi, con aria di rimprovero: – A me sembra che voi compromettiate Augusta.
– Augusta? – domandai io credendo di aver sentito male.
– Sì! – confermò la signora. – Voi la lusingate e la compromettete.
Ingenuamente rivelai il mio sentimento.
– Ma io l’Augusta non la vedo mai.
Essa ebbe un gesto di sorpresa e (o mi parve?) di sorpresa dolorosa.
Io intanto tentavo di pensare intensamente per arrivare presto a spiegare quello che mi sembrava un equivoco di cui però subito intesi l’importanza. Mi rivedevo in pensiero, visita per visita, durante quei cinque mesi, intento a spiare Ada. Avevo suonato con Augusta e, infatti, talvolta avevo parlato più con lei, che mi stava a sentire, che non con Ada, ma solo perché essa spiegasse ad Ada le mie storie accompagnate dalla sua approvazione. Dovevo parlare chiaramente con la signora e dirle delle mie mire su Ada? Ma poco prima io avevo risolto di parlare con la sola Ada e d’indagarne l’animo. Forse se avessi parlato chiaramente con la signora Malfenti, le cose sarebbero andate altrimenti e cioè non potendo sposare Ada non avrei sposata neppure Augusta. Lasciandomi dirigere dalla risoluzione presa prima ch’io avessi veduta la signora Malfenti e, sentite le cose sorprendenti ch’essa m’aveva dette, tacqui.
Pensavo intensamente, ma perciò con un po’ di confusione. Volevo intendere, volevo indovinare e presto. Si vedono meno bene le cose quando si spalancano troppo gli occhi. Intravvidi la possibilità che volessero buttarmi fuori di casa. Mi parve di poter escluderla. Io ero innocente, visto che non facevo la corte ad Augusta ch’essi volevano proteggere. Ma forse m’attribuivano delle intenzioni su Augusta per non compromettere Ada. E perché proteggere a quel modo Ada, che non era più una fanciullina? Io ero certo di non averla afferrata per le chiome che in sogno. In realtà non avevo che sfiorata la sua mano con le mie labbra. Non volevo mi si interdicesse l’accesso a quella casa, perché prima di abbandonarla volevo parlare con Ada. Perciò con voce tremante domandai:
– Mi dica Lei, signora, quello che debbo fare per non spiacere a nessuno.
Essa esitò. Io avrei preferito di aver da fare con Giovanni che pensava urlando. Poi, risoluta, ma con uno sforzo di apparire cortese che si manifestava evidente nel suono della voce, disse:
– Dovrebbe per qualche tempo venir meno frequentemente da noi; dunque non ogni giorno, ma due o tre volte alla settimana.
È certo che se mi avesse detto rudemente di andarmene e di non ritornare più, io, sempre diretto dal mio proposito, avrei supplicato che mi si tollerasse in quella casa, almeno per uno o due giorni ancora, per chiarire i miei rapporti con Ada. Invece le sue parole, più miti di quanto avessi temuto, mi diedero il coraggio di manifestare il mio risentimento:
– Ma se lei lo desidera, io in questa casa non riporrò più piede!
Venne quello che avevo sperato. Essa protestò, riparlò della stima di tutti loro e mi supplicò di non essere adirato con lei. Ed io mi dimostrai magnanimo, le promisi tutto quello ch’essa volle e cioè di astenermi dal venire in quella casa per un quattro o cinque giorni, di ritornarvi poi con una certa regolarità ogni settimana due o tre volte e, sopra tutto, di non tenerle rancore.
Fatte tali promesse, volli dar segno di tenerle e mi levai per allontanarmi. La signora protestò ridendo:
– Con me non c’è poi compromissione di sorta e può rimanere.
E poiché io pregavo di lasciarmi andare per un impegno di cui solo allora m’ero ricordato, mentre era vero che non vedevo l’ora di essere solo per riflettere meglio alla straordinaria avventura che mi toccava, la signora mi pregò addirittura di rimanere dicendo che così le avrei data la prova di non essere adirato con lei. Perciò rimasi, sottoposto continuamente alla tortura di ascoltare il vuoto cicaleccio cui la signora ora s’abbandonava sulle mode femminili ch’essa non voleva seguire, sul teatro e anche sul tempo tanto secco con cui la primavera s’annunziava.
Poco dopo fui contento d’essere rimasto perché m’avvidi che avevo bisogno di un ulteriore chiarimento. Senz’alcun riguardo interruppi la signora, di cui non sentivo più le parole, per domandarle:
– E tutti in famiglia sapranno che lei m’ha invitato a tenermi lontano da questa casa?
Parve dapprima ch’essa neppure avesse ricordato il nostro patto. Poi protestò:
– Lontano da questa casa? Ma solo per qualche giorno, intendiamoci. Io non ne dirò a nessuno, neppure a mio marito ed anzi le sarei grata se anche lei volesse usare la stessa discrezione.
Anche questo promisi, promisi anche che se mi fosse stata chiesta una spiegazione perché non mi si vedesse più tanto di spesso, avrei addotti dei pretesti varii. Per il momento prestai fede alle parole della signora e mi figurai che Ada potesse essere stupita e addolorata dalla mia improvvisa assenza. Un’immagine gradevolissima!
Poi rimasi ancora, sempre aspettando che qualche altra ispirazione venisse a dirigermi ulteriormente, mentre la signora parlava dei prezzi dei commestibili nell’ultimo tempo divenuti onerosissimi.
Invece di altre ispirazioni, capitò la zia Rosina, una sorella di Giovanni, più vecchia di lui, ma di lui molto meno intelligente. Aveva però qualche tratto della sua fisonomia morale bastevole a caratterizzarla quale sua sorella. Prima di tutto la stessa coscienza dei proprii diritti e dei doveri altrui alquanto comica, perché priva di qualsiasi arma per imporsi, eppoi anche il vizio di alzare presto la voce. Essa credeva di aver tanti diritti nella casa del fratello che – come appresi poi – per lungo tempo considerò la signora Malfenti quale un’intrusa. Era nubile e viveva con un’unica serva di cui parlava sempre come della sua più grande nemica. Quando morì raccomandò a mia moglie di sorvegliare la casa finché la serva che l’aveva assistita non se ne fosse andata. Tutti in casa di Giovanni la sopportavano temendo la sua aggressività.
Ancora non me ne andai. Zia Rosina prediligeva Ada fra le nipoti. Mi venne il desiderio di conquistarmene l’amicizia anch’io e cercai una frase amabile a indirizzarle. Mi ricordai oscuramente che l’ultima volta in cui l’avevo vista (cioè intravvista, perché allora non avevo sentito il bisogno di guardarla) le nipoti, non appena essa se ne era andata, avevano osservato che non aveva una buona cera. Anzi una di esse aveva detto:
– Si sarà guastato il sangue per qualche rabbia con la serva!
Trovai quello che cercavo. Guardando affettuosamente il faccione grinzoso della vecchia signora, le dissi:
– La trovo molto rimessa, signora.
Non avessi mai detta quella frase. Mi guardò stupita e protestò:
– Io sono sempre uguale. Da quando mi sarei rimessa?
Voleva sapere quando l’avessi vista l’ultima volta. Non ricordavo esattamente quella data e dovetti ricordarle che avevamo passato un intero pomeriggio insieme, seduti in quello stesso salotto con le tre signorine, ma non dalla parte dove eravamo allora, dall’altra. Io m’ero proposto di dimostrarle dell’interessamento, ma le spiegazioni ch’essa esigeva lo facevano durare troppo a lungo. La mia falsità mi pesava producendomi un vero dolore.
La signora Malfenti intervenne sorridendo:
– Ma lei non voleva mica dire che zia Rosina è ingrassata?
Diavolo! Là stava la ragione del risentimento di zia Rosina ch’era molto grossa come il fratello e sperava tuttavia di dimagrire.
– Ingrassata! Mai più! Io volevo parlare solo della cera migliore della signora.
Tentavo di conservare un aspetto affettuoso e dovevo invece trattenermi per non dirle un’insolenza.
Zia Rosina non parve soddisfatta neppur allora. Essa non era mai stata male nell’ultimo tempo e non capiva perché avesse dovuto apparire malata. E la signora Malfenti le diede ragione:
– Anzi, è una sua caratteristica di non mutare di cera – disse rivolta a me. – Non le pare?
A me pareva. Era anzi evidente. Me ne andai subito. Porsi con grande cordialità la mano a zia Rosina sperando di rabbonirla, ma essa mi concedette la sua guardando altrove.
Non appena ebbi varcata la soglia di quella casa il mio stato d’animo mutò. Che liberazione! Non avevo più da studiare le intenzioni della signora Malfenti né di forzarmi di piacere alla zia Rosina. Credo in verità che se non ci fosse stato il rude intervento di zia Rosina, quella politicona della signora Malfenti avrebbe raggiunto perfettamente il suo scopo ed io mi sarei allontanato da quella casa tutto contento di essere stato trattato bene. Corsi saltellando giù per le scale. Zia Rosina era stata quasi un commento della signora Malfenti. La signora Malfenti m’aveva proposto di restar lontano dalla sua casa per qualche giorno. Troppo buona la cara signora! Io l’avrei compiaciuta al di là delle sue aspettative e non m’avrebbe rivisto mai più! M’avevano torturato, lei, la zia ed anche Ada! Con quale diritto? Perché avevo voluto sposarmi? Ma io non ci pensavo più! Com’era bella la libertà!
Per un buon quarto d’ora corsi per le vie accompagnato da tanto sentimento. Poi sentii il bisogno di una libertà ancora maggiore. Dovevo trovare il modo di segnare in modo definitivo la mia volontà di non rimettere più il piede in quella casa. Scartai l’idea di scrivere una lettera con la quale mi sarei congedato. L’abbandono diveniva più sdegnoso ancora se non ne comunicavo l’intenzione. Avrei semplicemente dimenticato di vedere Giovanni e tutta la sua famiglia.
Trovai l’atto discreto e gentile e perciò un po’ ironico col quale avrei segnata la mia volontà. Corsi da un fioraio e scelsi un magnifico mazzo di fiori che indirizzai alla signora Malfenti accompagnato dal mio biglietto da visita sul quale non scrissi altro che la data. Non occorreva altro. Era una data che non avrei dimenticata più e non l’avrebbero dimenticata forse neppure Ada e sua madre: 5 Maggio, anniversario della morte di Napoleone.
Provvidi in fretta a quell’invio. Era importantissimo che giungesse il giorno stesso.
Ma poi? Tutto era fatto, tutto, perché non c’era più nulla da fare! Ada restava segregata da me con tutta la sua famiglia ed io dovevo vivere senza fare più nulla, in attesa che qualcuno di loro fosse venuto a cercarmi e darmi l’occasione di fare o dire qualche cosa d’altro.
Corsi al mio studio per riflettere e per rinchiudermi. Se avessi ceduto alla mia dolorosa impazienza, subito sarei ritornato di corsa a quella casa a rischio di arrivarvi prima del mio mazzo di fiori. I pretesti non potevano mancare. Potevo anche averci dimenticato il mio ombrello!
Non volli fare una cosa simile. Con l’invio di quel mazzo di fiori io avevo assunta una bellissima attitudine che bisognava conservare. Dovevo ora stare fermo, perché la prossima mossa toccava a loro.
Il raccoglimento ch’io mi procurai nel mio studiolo e da cui m’aspettavo un sollievo, chiarì solo le ragioni della mia disperazione che s’esasperò fino alle lagrime. Io amavo Ada! Non sapevo ancora se quel verbo fosse proprio e continuai l’analisi. Io la volevo non solo mia, ma anche mia moglie. Lei, con quella sua faccia marmorea sul corpo acerbo, eppoi ancora lei con la sua serietà, tale da non intendere il mio spirito che non le avrei insegnato, ma cui avrei rinunziato per sempre, lei che m’avrebbe insegnata una vita d’intelligenza e di lavoro. Io la volevo tutta e tutto volevo da lei. Finii col conchiudere che il verbo fosse proprio quello: Io amavo Ada.
Mi parve di aver pensata una cosa molto importante che poteva guidarmi. Via le esitazioni! Non importava più di sapere se ella mi amasse. Bisognava tentare di ottenerla e non occorreva più parlare con lei se Giovanni poteva disporne. Prontamente bisognava chiarire tutto per arrivare subito alla felicità o altrimenti dimenticare tutto e guarire. Perché avevo da soffrire tanto nell’attesa? Quando avessi saputo – e potevo saperlo solo da Giovanni – che io definitivamente avevo perduta Ada, almeno non avrei più dovuto lottare col tempo che sarebbe continuato a trascorrere lentamente senza ch’io sentissi il bisogno di sospingerlo. Una cosa definitiva è sempre calma perché staccata dal tempo.
Corsi subito in cerca di Giovanni. Furono due le corse. Una verso il suo ufficio situato in quella via che noi continuiamo a dire delle Case Nuove, perché così facevano i nostri antenati. Alte vecchie case che offuscano una via tanto vicina alla riva del mare poco frequentata all’ora del tramonto, e dove potei procedere rapido. Non pensai, camminando, che a preparare più brevemente che fosse possibile la frase che dovevo dirigergli. Bastava dirgli la mia determinazione di sposare sua figlia. Non avevo né da conquiderlo né da convincerlo. Quell’uomo d’affari avrebbe saputa la risposta da darmi non appena intesa la mia domanda. Mi preoccupava tuttavia la quistione se in un’occasione simile avrei dovuto parlare in lingua o in dialetto.
Ma Giovanni aveva già abbandonato l’ufficio e s’era recato al Tergesteo. Mi vi avviai. Più lentamente perché sapevo che alla Borsa dovevo attendere più tempo per potergli parlare da solo a solo. Poi, giunto in via Cavana, dovetti rallentare per la folla che ostruiva la stretta via. E fu proprio battendomi per passare traverso a quella folla, che ebbi finalmente come in una visione la chiarezza che da tante ore cercavo. I Malfenti volevano ch’io sposassi Augusta e non volevano ch’io sposassi Ada e ciò per la semplice ragione che Augusta era innamorata di me e Ada niente affatto. Niente affatto perché altrimenti non sarebbero intervenuti a dividerci. M’avevano detto ch’io compromettevo Augusta, ma era invece lei che si comprometteva amandomi. Compresi tutto in quel momento, con viva chiarezza, come se qualcuno della famiglia me l’avesse detto. E indovinai anche che Ada era d’accordo ch’io fossi allontanato da quella casa. Essa non m’amava e non m’avrebbe amato almeno finché la sorella sua m’avesse amato. Nell’affollata via Cavana avevo dunque pensato più dirittamente che nel mio studio solitario.
Oggidì, quando ritorno al ricordo di quei cinque giorni memorandi che mi condussero al matrimonio, mi stupisce il fatto che il mio animo non si sia mitigato all’apprendere che la povera Augusta mi amava. Io, ormai scacciato da casa Malfenti, amavo Ada irosamente. Perché non mi diede alcuna soddisfazione la visione chiara che la signora Malfenti m’aveva allontanato invano, perché io in quella casa rimanevo, e vicinissimo ad Ada, cioè nel cuore di Augusta? A me pareva invece una nuova offesa l’invito della signora Malfenti di non compromettere Augusta e cioè di sposarla. Per la brutta fanciulla che m’amava, avevo tutto il disdegno che non ammettevo avesse per me la sua bella sorella, che io amavo.
Accelerai ancora il passo, ma deviai e mi diressi verso casa mia. Non avevo più bisogno di parlare con Giovanni perché sapevo ormai chiaramente come condurmi; con un’evidenza tanto disperante che forse finalmente m’avrebbe data la pace staccandomi dal tempo troppo lento. Era anche pericoloso parlarne con quel maleducato di Giovanni. La signora Malfenti aveva parlato in modo ch’io non l’avevo intesa che là in via Cavana. Il marito era capace di comportarsi altrimenti. Forse m’avrebbe detto addirittura: «Perché vuoi sposare Ada? Vediamo! Non faresti meglio di sposare Augusta?». Perché egli aveva un assioma che ricordavo e che avrebbe potuto guidarlo in questo caso: «Devi sempre spiegare chiaramente l’affare al tuo avversario perché allora appena sarai sicuro d’intenderlo meglio di lui!». E allora? Ne sarebbe conseguita un’aperta rottura. Solo allora il tempo avrebbe potuto camminare come voleva, perché io non avrei più avuta alcuna ragione d’ingerirmene: sarei arrivato al punto fermo!
Ricordai anche un altro assioma di Giovanni e mi vi attaccai perché mi procurava una grande speranza. Seppi restarvi attaccato per cinque giorni, per quei cinque giorni che convertirono la mia passione in malattia. Giovanni soleva dire che non bisogna aver fretta di arrivare alla liquidazione di un affare quando da questa liquidazione non si può attendersi un vantaggio: ogni affare arriva prima o poi da sé alla liquidazione, come lo prova il fatto che la storia del mondo è tanto lunga e che tanto pochi affari sono rimasti in sospeso. Finché non si è proceduti alla sua liquidazione, ogni affare può ancora evolversi vantaggiosamente.
Non ricordai che v’erano altri assiomi di Giovanni che dicevano il contrario e m’attaccai a quello. Già a qualche cosa dovevo pur attaccarmi. Feci il proposito ferreo di non movermi finché non avessi appreso che qualche cosa di nuovo avesse fatto evolvere il mio affare in mio favore. E ne ebbi tale danno che forse per questo, in seguito, nessun mio proposito m’accompagnò per tanto tempo.
Non appena fatto il proposito, ricevetti un biglietto dalla signora Malfenti. Ne riconobbi la scrittura sulla busta e, prima di aprirlo, mi lusingai fosse bastato quel mio proposito ferreo, perché essa si pentisse di avermi maltrattato e mi corresse dietro. Quando trovai che non conteneva che le lettere p. r. che significavano il ringraziamento per i fiori che le avevo inviati, mi disperai, mi gettai sul mio letto e ficcai i denti nel guanciale quasi per inchiodarmivi e impedirmi di correr via a rompere il mio proposito. Quanta ironica serenità risultava da quelle iniziali! Ben maggiore di quella espressa dalla data ch’io avevo apposta al mio biglietto e che significava già un proposito e forse anche un rimprovero. Remember aveva detto Carlo I. prima che gli tagliassero il collo e doveva aver pensata la data di quel giorno! Anch’io avevo esortata la mia avversaria a ricordare e temere!
Furono cinque giorni e cinque notti terribili ed io ne sorvegliai le albe e i tramonti che significavano fine e principio e avvicinavano l’ora della mia libertà, la libertà di battermi di nuovo per il mio amore.
Mi preparavo a quella lotta. Oramai sapevo come la mia fanciulla voleva io fossi fatto. M’è facile di ricordarmi dei propositi che feci allora, prima di tutto perché ne feci d’identici in epoca più recente, eppoi perché li annotai su un foglio di carta che conservo tuttora. Mi proponevo di diventare più serio. Ciò significava allora di non raccontare quelle barzellette che facevano ridere e mi diffamavano, facendomi anche amare dalla brutta Augusta e disprezzare dalla mia Ada. Poi v’era il proponimento di essere ogni mattina alle otto nel mio ufficio che non vedevo da tanto tempo, non per discutere sui miei diritti con l’Olivi, ma per lavorare con lui e poter assumere a suo tempo la direzione dei miei affari. Ciò doveva essere attuato in un’epoca più tranquilla di quella, come dovevo anche cessar di fumare più tardi, cioè quando avessi riavuta la mia libertà, perché non bisognava peggiorare quell’orribile intervallo. Ad Ada spettava un marito perfetto. Perciò v’erano anche varii proponimenti di dedicarmi a letture serie, eppoi di passare ogni giorno una mezz’oretta sulla pedana e di cavalcare un paio di volte alla settimana. Le ventiquattr’ore della giornata non erano troppe.
Durante quei giorni di segregazione la gelosia più amara fu la mia compagna di tutte le ore. Era un proposito eroico quello di voler correggersi di ogni difetto per prepararsi a conquistare Ada dopo qualche settimana. Ma intanto? Intanto ch’io m’assoggettavo alla più dura constrizione, si sarebbero tenuti tranquilli gli altri maschi della città e non avrebbero cercato di portarmi via la mia donna? Fra di loro v’era certamente qualcuno che non aveva bisogno di tanto esercizio per essere gradito. Io sapevo, io credevo di sapere che quando Ada avesse trovato chi faceva al caso suo, avrebbe subito consentito senza attendere di innamorarsi. Quando in quei giorni io m’imbattevo in un maschio ben vestito, sano e sereno, l’odiavo, perché mi pareva facesse al caso di Ada. Di quei giorni, la cosa che meglio ricordo è la gelosia che s’era abbassata come una nebbia sulla mia vita.
Dell’atroce dubbio di vedermi portar via Ada in quei giorni non si può ridere, ormai che si sa come le cose andarono a finire. Quando ripenso a quei giorni di passione sento un’ammirazione grande per la profetica anima mia.
Varie volte, di notte, passai sotto alle finestre di quella casa. Lassù apparentemente continuavano a divertirsi come quando c’ero stato anch’io. Alla mezzanotte o poco prima, nel salotto si spegnevano i lumi. Scappavo pel timore di essere scorto da qualche visitatore che allora doveva lasciare la casa.
Ma ogni ora di quei giorni fu affannosa anche per l’impazienza. Perché nessuno domandava di me? Perché non si moveva Giovanni? Non doveva egli meravigliarsi di non vedermi né a casa sua né al Tergesteo? Dunque era d’accordo anche lui ch’io fossi stato allontanato? Interrompevo spesso le mie passeggiate di giorno e di notte per correre a casa ad accertarmi che nessuno fosse venuto a domandare di me. Non sapevo andare a letto nel dubbio, e destavo per interrogarla la povera Maria. Restavo per ore ad aspettare in casa, nel luogo ove ero più facilmente raggiungibile. Ma nessuno domandò di me ed è certo che se non mi fossi risolto a movermi io, sarei tuttavia celibe.
Una sera andai a giocare al club. Era da molti anni che non mi vi facevo vedere per rispetto ad una promessa fatta a mio padre. Mi pareva che la promessa non potesse più valere poiché mio padre non poteva aver previste tali mie dolorose circostanze e l’urgente mia necessità di procurarmi uno svago. Dapprima guadagnai con una fortuna che mi dolse perché mi parve un indennizzo della mia sfortuna in amore. Poi perdetti e mi dolse ancora perché mi parve di soggiacere al giuoco com’ero soggiaciuto all’amore. Ebbi presto disgusto del giuoco: non era degno di me e neppure di Ada. Tanto puro mi rendeva quell’amore!
Di quei giorni so anche che i sogni d’amore erano stati annientati da quella realtà tanto rude. Il sogno era oramai tutt’altra cosa. Sognavo la vittoria invece che l’amore. Il mio sonno fu una volta abbellito da una visita di Ada. Era vestita di sposa e veniva con me all’altare, ma quando fummo lasciati soli non facemmo all’amore, neppure allora. Ero suo marito e avevo acquistato il diritto di domandarle: «Come hai potuto permettere ch’io fossi trattato così?» Di altro diritto non mi premeva.
Trovo in un mio cassetto degli abbozzi di lettere ad Ada, a Giovanni e alla signora Malfenti. Sono di quei giorni. Alla signora Malfenti scrivevo una lettera semplice con la quale prendevo congedo prima d’intraprendere un lungo viaggio. Non ricordo però di aver avuto una tale intenzione: non potevo lasciare la città quando non ero ancora certo che nessuno sarebbe venuto a cercarmi. Quale sventura se fossero venuti e non m’avessero trovato! Nessuna di quelle lettere è stata inviata. Credo anzi le avessi scritte solo per mettere in carta i miei pensieri.
Da molti anni io mi consideravo malato, ma di una malattia che faceva soffrire piuttosto gli altri che me stesso. Fu allora che conobbi la malattia «dolente», una quantità di sensazioni fisiche sgradevoli che mi resero tanto infelice.
S’iniziarono così. Alla una di notte circa, incapace di prendere sonno, mi levai e camminai nella mite notte finché non giunsi ad un caffè di sobborgo nel quale non ero mai stato e dove perciò non avrei trovato alcun conoscente, ciò che mi era molto gradito perché volevo continuarvi una discussione con la signora Malfenti, cominciata a letto e nella quale non volevo che nessuno si frammettesse. La signora Malfenti m’aveva fatti dei rimproveri nuovi. Diceva ch’io avevo tentato di «giocar di pedina» con le sue figliuole. Intanto se avevo tentato una cosa simile l’avevo certamente fatto con la sola Ada. Mi venivano i sudori freddi al pensare che forse in casa Malfenti oramai mi si movessero dei rimproveri simili. L’assente ha sempre torto e potevano aver approfittato della mia lontananza per associarsi ai miei danni. Nella viva luce del caffè mi difendevo meglio. Certo talvolta io avrei voluto toccare col mio piede quello di Ada ed una volta anzi m’era parso di averlo raggiunto, lei consenziente. Poi però risultò che avevo premuto il piede di legno del tavolo e quello non poteva aver parlato.
Fingevo di pigliar interesse al gioco del biliardo. Un signore, appoggiato ad una gruccia, s’avvicinò e venne a sedere proprio accanto a me. Ordinò una spremuta e poiché il cameriere aspettava anche i miei ordini, per distrazione ordinai una spremuta anche per me ad onta ch’io non possa soffrire il sapore del limone. Intanto la gruccia appoggiata al sofà su cui sedevamo, scivolò a terra ed io mi chinai a raccoglierla con un movimento quasi istintivo.
– Oh, Zeno! – fece il povero zoppo riconoscendomi nel momento in cui voleva ringraziarmi.
– Tullio! – esclamai io sorpreso e tendendogli la mano. Eravamo stati compagni di scuola e non ci eravamo visti da molti anni. Sapevo di lui che, finite le scuole medie, era entrato in una banca, dove occupava un buon posto.
Ero tuttavia tanto distratto che bruscamente gli domandai come fosse avvenuto ch’egli aveva la gamba destra troppo corta così da aver bisogno della gruccia.
Di buonissimo umore, egli mi raccontò che sei mesi prima s’era ammalato di reumatismi che avevano finito col danneggiargli la gamba.
M’affrettai di suggerirgli molte cure. È il vero modo per poter simulare senza grande sforzo una viva partecipazione Egli le aveva fatte tutte. Allora suggerii ancora:
– E perché a quest’ora non sei ancora a letto? A me non pare che ti possa far bene di esporti all’aria notturna.
Egli scherzò bonariamente: riteneva che neppure a me l’aria notturna potesse giovare e riteneva che chi non soffriva di reumatismi, finché aveva vita, poteva ancora procurarseli. Il diritto di andare a letto alle ore piccole era ammesso persino dalla costituzione austriaca. Del resto, contrariamente all’opinione generale, il caldo e il freddo non avevano a che fare coi reumatismi. Egli aveva studiata la sua malattia ed anzi non faceva altro a questo mondo che studiarne le cause e i rimedi. Più che per la cura aveva avuto bisogno di un lungo permesso dalla banca per poter approfondirsi in quello studio. Poi mi raccontò che stava facendo una cura strana. Mangiava ogni giorno una quantità enorme di limoni. Quel giorno ne aveva ingoiati una trentina, ma sperava con l’esercizio di arrivare a sopportarne anche di più. Mi confidò che i limoni secondo lui erano buoni anche per molte altre malattie. Dacché li prendeva sentiva meno fastidio per il fumare esagerato, al quale anche lui era condannato.
Io ebbi un brivido alla visione di tanto acido, ma, subito dopo, una visione un po’ più lieta della vita: i limoni non mi piacevano, ma se mi avessero data la libertà di fare quello che dovevo o volevo senz’averne danno e liberandomi da ogni altra costrizione, ne avrei ingoiati altrettanti anch’io. È libertà completa quella di poter fare ciò che si vuole a patto di fare anche qualche cosa che piaccia meno. La vera schiavitù è la condanna all’astensione: Tantalo e non Ercole.
Poi Tullio finse anche lui di essere ansioso di mie notizie. Io ero ben deciso di non raccontargli del mio amore infelice, ma abbisognavo di uno sfogo. Parlai con tale esagerazione dei miei mali (così li registrai e sono sicuro ch’erano lievi) che finii con l’avere le lagrime agli occhi, mentre Tullio andava sentendosi sempre meglio credendomi più malato di lui.
Mi domandò se lavoravo. Tutti in città dicevano ch’io non facevo niente ed io temevo egli avesse da invidiarmi mentre in quell’istante avevo l’assoluto bisogno di essere commiserato. Mentii! Gli raccontai che lavoravo nel mio ufficio, non molto, ma giornalmente almeno per sei ore e che poi gli affari molto imbrogliati ereditati da mio padre e da mia madre mi davano da fare per altre sei ore.
– Dodici ore! – commentò Tullio, e con un sorriso soddisfatto, mi concedette quello che ambivo, la sua commiserazione: – Non sei mica da invidiare, tu!
La conclusione era esatta ed io ne fui tanto commosso che dovetti lottare per non lasciar trapelare le lagrime. Mi sentii più infelice che mai e, in quel morbido stato di compassione di me stesso, si capisce io sia stato esposto a delle lesioni.
Tullio s’era rimesso a parlare della sua malattia ch’era anche la sua principale distrazione. Aveva studiato l’anatomia della gamba e del piede. Mi raccontò ridendo che quando si cammina con passo rapido, il tempo in cui si svolge un passo non supera il mezzo secondo e che in quel mezzo secondo si movevano nientemeno che cinquantaquattro muscoli. Trasecolai e subito corsi col pensiero alle mie gambe a cercarvi la macchina mostruosa. Io credo di avercela trovata. Naturalmente non riscontrai i cinquantaquattro ordigni, ma una complicazione enorme che perdette il suo ordine dacché io vi ficcai la mia attenzione.
Uscii da quel caffè zoppicando e per alcuni giorni zoppicai sempre. Il camminare era per me divenuto un lavoro pesante, e anche lievemente doloroso. A quel groviglio di congegni pareva mancasse ormai l’olio e che, movendosi, si ledessero a vicenda. Pochi giorni appresso, fui colto da un male più grave di cui dirò e che diminuì il primo. Ma ancora oggidì, che ne scrivo, se qualcuno mi guarda quando mi movo, i cinquantaquattro movimenti s’imbarazzano ed io sono in procinto di cadere.
Anche questa lesione io la devo ad Ada. Molti animali diventano preda dei cacciatori o di altri animali quando sono in amore. Io fui allora preda della malattia e sono certo che se avessi appreso della macchina mostruosa in altro momento, non ne avrei avuto alcun danno.
Qualche segno su un foglio di carta che conservai, mi ricorda un’altra strana avventura di quei giorni. Oltre all’annotazione di un’ultima sigaretta accompagnata dall’espressione della fiducia di poter guarire della malattia dei cinquantaquattro movimenti, v’è un tentativo di poesia… su una mosca. Se non sapessi altrimenti, crederei che quei versi provengano da una signorina dabbene che dà del tu agl’insetti di cui canta, ma visto che sono stati stesi da me, devo credere che poiché io sono passato per di là, tutti possano capitare dappertutto.
Ecco come quei versi nacquero. A tarda notte ero ritornato a casa e invece che coricarmi m’ero recato nel mio studiolo ove avevo acceso il gas. Alla luce una mosca si mise a tormentarmi. Riuscii a darle un colpo, lieve però per non insudiciarmi. La dimenticai, ma poi la rividi in mezzo al tavolo come lentamente si rimetteva. Era ferma, eretta e pareva più alta di prima perché una delle sue zampine era stata anchilosata e non poteva flettersi. Con le due zampine posteriori si lisciava assiduamente le ali. Tentò di moversi, ma si ribaltò sulla schiena. Si rizzò e ritornò ostinata al suo assiduo lavoro.
Scrissi allora quei versi, stupito di aver scoperto che quel piccolo organismo pervaso da tanto dolore, fosse diretto nel suo sforzo immane da due errori: prima di tutto lisciando con tanta ostinazione le ali che non erano lese, l’insetto rivelava di non sapere da quale organo venisse il suo dolore; poi l’assiduità del suo sforzo dimostrava che c’era nella sua minuscola mente la fede fondamentale che la salute spetti a tutti e che debba certamente ritornare quando ci ha lasciato. Erano errori che si possono facilmente scusare in un insetto che non vive che la vita di una sola stagione, e non ha tempo di far dell’esperienza.
Ma venne la domenica. Scadeva il quinto giorno dalla mia ultima visita in casa Malfenti. Io, che lavoro tanto poco, conservai sempre un grande rispetto per il giorno festivo che divide la vita in periodi brevi che la rendono più sopportabile. Quel giorno festivo chiudeva anche una mia settimana faticosa e me ne competeva la gioia. Io non cambiai per nulla i miei piani ma per quel giorno non dovevano valere ed io avrei rivista Ada. Non avrei compromessi quei piani con alcuna parola, ma dovevo rivederla perché c’era anche la possibilità che l’affare si fosse già cambiato in mio favore ed allora sarebbe stato un bel danno di continuar a soffrire senza scopo.
Perciò, a mezzodì, con la fretta che le mie povere gambe mi concedevano, corsi in città e sulla via che sapevo la signora Malfenti e le figliuole dovevano percorrere al ritorno dalla messa. Era una festa piena di sole e, camminando, pensai che forse in città m’aspettava la novità attesa, l’amore di Ada!
Non fu così, ma per un altro istante n’ebbi l’illusione. La fortuna mi favorì in modo incredibile. M’imbattei faccia a faccia in Ada, nella sola Ada. Mi mancò il passo e il fiato. Che fare? Il mio proponimento avrebbe voluto che mi tirassi in disparte e la lasciassi passare con un saluto misurato. Ma nella mia mente ci fu un po’ di confusione perché prima c’erano stati altri proponimenti tra cui uno che ricordavo secondo il quale avrei dovuto parlarle chiaro e apprendere dalla sua bocca il mio destino. Non mi trassi in disparte e quand’ella mi salutò come se ci fossimo lasciati cinque minuti prima, io m’accompagnai a lei.
Ella mi aveva detto:
– Buon giorno, signor Cosini! Ho un po’ fretta.
Ed io:
– Mi permette di accompagnarla per un tratto?
Ella accettò sorridendo. Ma dunque avrei dovuto parlarle? Ella aggiunse che andava direttamente a casa sua, perciò compresi che non avevo a disposizione che cinque minuti per parlare ed anche di quel tempo ne perdetti una parte a calcolare se sarebbe bastato per le cose importanti che dovevo dirle. Meglio non dirle che non dirle interamente. Mi confondeva anche il fatto che allora nella nostra città, per una fanciulla, era già un’azione compromettente quella di lasciarsi accompagnare sulla via da un giovanotto. Ella me lo permetteva. Non potevo già accontentarmi? Intanto la guardavo, tentando di sentir di nuovo intero il mio amore annebbiatosi nell’ira e nel dubbio. Riavrei almeno i miei sogni? Ella m’appariva piccola e grande nello stesso tempo, nell’armonia delle sue linee. I sogni ritornavano in folla anche accanto a lei, reale. Era il mio modo di desiderare e vi ritornai con gioia intensa. Spariva dal mio animo qualunque traccia d’ira o di rancore.
Ma dietro di noi si sentì un’invocazione esitante:
– Se permette, signorina!
Mi volsi indignato. Chi osava interrompere le spiegazioni che non avevo ancora iniziate? Un signorino imberbe, bruno e pallido, la guardava con occhi ansiosi. A mia volta guardai Ada nella folle speranza ch’essa invocasse il mio aiuto. Sarebbe bastato un suo segno ed io mi sarei gettato su quell’individuo a domandargli ragione della sua audacia. E magari avesse insistito. I miei mali sarebbero stati guariti subito se mi fosse stato concesso d’abbandonarmi ad un atto brutale di forza.
Ma Ada non fece quel segno. Con un sorriso spontaneo perché mutava lievemente il disegno delle guancie e della bocca ma anche la luce dell’occhio, ella gli stese la mano:
– Il signor Guido!
Quel prenome mi fece male. Ella, poco prima, mi aveva chiamato col nome mio di famiglia.
Guardai meglio quel signor Guido. Era vestito con un’eleganza ricercata e teneva nella destra inguantata un bastone dal manico d’avorio lunghissimo, che io non avrei portato neppure se m’avessero pagato perciò una somma per ogni chilometro. Non mi rimproverai di aver potuto vedere in una simile persona una minaccia per Ada. Vi sono dei loschi figuri che vestono elegantemente e portano anche di tali bastoni.
Il sorriso di Ada mi ricacciò nei più comuni rapporti mondani. Ada fece la presentazione. E sorrisi anch’io! Il sorriso di Ada ricordava un poco l’increspatura di un’acqua limpida sfiorata da una lieve brezza. Anche il mio ricordava un simile movimento, ma prodotto da un sasso che fosse stato gettato nell’acqua.
Si chiamava Guido Speier. Il mio sorriso si fece più spontaneo perché subito mi si presentava l’occasione di dirgli qualche cosa di sgradevole:
– Lei è tedesco?
Cortesemente egli mi disse che riconosceva che al nome tutti potevano crederlo tale. Invece i documenti della sua famiglia provavano ch’essa era italiana da varii secoli. Egli parlava il toscano con grande naturalezza mentre io e Ada eravamo condannati al nostro dialettaccio.
Lo guardavo per sentire meglio quello ch’egli diceva. Era un bellissimo giovine: le labbra naturalmente socchiuse lasciavano vedere una bocca di denti bianchi e perfetti. L’occhio suo era vivace ed espressivo e, quando s’era scoperto il capo, avevo potuto vedere che i suoi capelli bruni e un po’ ricciuti, coprivano tutto lo spazio che madre natura aveva loro destinato, mentre molta parte della mia testa era stata invasa dalla fronte.
Io l’avrei odiato anche se Ada non fosse stata presente, ma soffrivo di quell’odio e cercai di attenuarlo. Pensai: – È troppo giovine per Ada. – E pensai poi che la confidenza e la gentilezza ch’essa gli usava fossero dovute ad un ordine del padre. Forse era un uomo importante per gli affari del Malfenti e a me era parso che in simili casi tutta la famiglia fosse obbligata alla collaborazione. Gli domandai:
– Ella si stabilisce a Trieste?
Mi rispose che vi si trovava da un mese e che vi fondava una casa commerciale. Respirai! Potevo aver indovinato.
Camminavo zoppicando, ma abbastanza disinvolto, vedendo che nessuno se ne accorgeva. Guardavo Ada e tentavo di dimenticare tutto il resto compreso l’altro che ci accompagnava. In fondo io sono l’uomo del presente e non penso al futuro quando esso non offuschi il presente con ombre evidenti. Ada camminava fra noi due e aveva sulla faccia, stereotipata, un’espressione vaga di lietezza che arrivava quasi al sorriso. Quella lietezza mi pareva nuova. Per chi era quel sorriso? Non per me ch’essa non vedeva da tanto tempo?
Prestai orecchio a quello che si dicevano. Parlavano di spiritismo e appresi subito che Guido aveva introdotto in casa Malfenti il tavolo parlante.
Ardevo dal desiderio di assicurarmi che il dolce sorriso che vagava sulle labbra di Ada fosse mio e saltai nell’argomento di cui parlavano, improvvisando una storia di spiriti. Nessun poeta avrebbe potuto improvvisare a rime obbligate meglio di me. Quando ancora non sapevo dove sarei andato a finire, esordii dichiarando che ormai credevo anch’io negli spiriti per una storia capitatami il giorno innanzi su quella stessa via… anzi no!… sulla via parallela a quella e che noi scorgevamo. Poi dissi che anche Ada aveva conosciuto il professor Bertini ch’era morto poco tempo prima a Firenze ove s’era stabilito dopo il suo pensionamento. Seppimo della sua morte da una breve notizia su un giornale locale che io avevo dimenticata, tant’è vero che, quando pensavo al professore Bertini, io lo vedevo passeggiare per le Cascine nel suo meritato riposo. Ora, il giorno innanzi, su un punto che precisai della via parallela a quella che stavamo percorrendo, fui accostato da un signore che mi conosceva e che io sapevo di conoscere. Aveva un’andatura curiosa di donnetta che si dimeni per facilitarsi il passo…
– Certo! Poteva essere il Bertini! – disse Ada ridendo.
Il riso era mio ed incorato continuai:
– Sapevo di conoscerlo, ma non sapevo ricordarlo. Si parlò di politica. Era il Bertini perché disse tante di quelle bestialità, con quella sua voce da pecora…
– Anche la sua voce! – ancora Ada rise guardandomi ansiosamente per sentire la chiusa.
– Sì! Avrebbe dovuto essere il Bertini, – dissi io fingendo spavento da quel grande attore che in me è andato perduto. – Mi strinse la mano per congedarsi e se ne andò ballonzolando. Lo seguii per qualche passo cercando di raccapezzarmi. Scopersi di aver parlato col Bertini solo quando l’ebbi perduto di vista. Col Bertini ch’era morto da un anno!
Poco dopo essa si fermò dinanzi al portone di casa sua. Stringendogli la mano, disse a Guido che lo aspettava quella sera. Poi, salutando anche me, mi disse che se non temevo di annoiarmi andassi quella sera da loro a far ballare il tavolino.
Non risposi né ringraziai. Dovevo analizzare quell’invito prima di accettarlo. Mi pareva avesse suonato come un atto di cortesia obbligata. Ecco: forse per me il giorno festivo si sarebbe chiuso con quell’incontro. Ma volli apparire cortese per lasciarmi aperte tutte le vie, anche quella di accettare quell’invito. Le domandai di Giovanni col quale avevo da parlare. Ella mi rispose che l’avrei trovato nel suo ufficio ove s’era recato per un affare urgente.
Guido ed io ci fermammo per qualche istante a guardar dietro all’elegante figurina che spariva nell’oscurità dell’atrio della casa. Non so quello che Guido abbia pensato in quel momento. In quanto a me, mi sentivo infelicissimo; perché ella non aveva fatto quell’invito prima a me e poi a Guido?
Ritornammo insieme sui nostri passi, quasi fino al punto ove ci eravamo imbattuti con Ada. Guido, cortese e disinvolto (era proprio la disinvoltura quella ch’io più di tutto invidiavo agli altri) parlò ancora di quella storia ch’io avevo improvvisata e ch’egli prendeva sul serio. Di vero, invece, in quella storia non c’era che questo: a Trieste, anche dopo morto il Bertini, viveva una persona che diceva delle bestialità, camminava in modo che pareva si movesse sulle punte dei piedi ed aveva anche una voce strana. Ne avevo fatta la conoscenza in quei giorni e, per un momento, m’aveva ricordato il Bertini. Non mi dispiaceva che Guido si rompesse la testa a studiare quella mia invenzione. Era stabilito ch’io non dovevo odiarlo perché egli per i Malfenti non era altro che un commerciante importante; ma m’era antipatico per la sua eleganza ricercata e il suo bastone. M’era anzi tanto antipatico che non vedevo l’ora di liberarmene. Sentii ch’egli concludeva:
– È possibile anche che la persona con cui ella parlò, fosse ben più giovane del Bertini, camminasse come un granatiere e avesse la voce virile e che la sua somiglianza con lui fosse limitata al dire bestialità. Ciò sarebbe bastato per fissare il suo pensiero sul Bertini. Ma per ammettere questo, bisognerebbe anche credere ch’ella sia una persona molto distratta.
Non seppi aiutarlo nei suoi sforzi:
– Distratto io? Che idea! Sono un uomo d’affari. Dove finirei se fossi distratto?
Poi pensai che perdevo il mio tempo. Volevo veder Giovanni. Giacché avevo vista la figlia, avrei potuto vedere anche il padre ch’era tanto meno importante. Dovevo far presto se volevo ancora trovarlo nel suo ufficio.
Guido continuava ad almanaccare quanta parte di un miracolo si potesse attribuire alla disattenzione di chi lo fa o di chi vi assiste. Io volli congedarmi e apparire almeno altrettanto disinvolto di lui. Da ciò provenne una fretta nell’interromperlo e nel lasciarlo molto simile ad una brutalità:
– Per me i miracoli esistono e non esistono. Non bisogna complicarli con troppe storie. Bisogna crederci o non crederci ed in ambedue i casi le cose sono molto semplici.
Io non volevo dimostrargli dell’antipatia tant’è vero che con le mie parole mi pareva di fargli una concessione, visto ch’io sono un positivista convinto ed ai miracoli non ci credo. Ma era una concessione fatta con grande malumore.
M’allontanai zoppicando più che mai e sperai che Guido non sentisse il bisogno di guardarmi dietro.
Era proprio necessario ch’io parlassi con Giovanni. Intanto m’avrebbe istruito come avrei dovuto comportarmi quella sera. Ero stato invitato da Ada, e dal comportamento di Giovanni avrei potuto comprendere se dovevo seguire quell’invito o non piuttosto ricordarmi che quell’invito contravveniva all’espresso volere della signora Malfenti. Chiarezza ci voleva nei miei rapporti con quella gente, e se a darmela non fosse bastata la domenica, vi avrei dedicato anche il lunedì. Continuavo a contravvenire ai miei proponimenti e non me ne accorgevo. Anzi mi pareva di eseguire una risoluzione presa dopo cinque giorni di meditazione. È così ch’io designavo la mia attività di quei giorni.
Giovanni m’accolse con un bel saluto gridato, che mi fece bene, e m’invitò di prender posto su una poltrona addossata alla parete di faccia al suo tavolo.
– Cinque minuti! Sono subito con lei! – E subito dopo: – Ma lei zoppica?
Arrossii! Ero però in vena d’improvvisazione. Gli dissi ch’ero scivolato mentre uscivo dal caffè, e designai proprio il caffè ove m’era capitato quell’accidente. Temetti ch’egli potesse attribuire la mia tombola ad annebbiamento della mente per alcool, e ridendo aggiunsi il particolare che quando caddi mi trovavo in compagnia di una persona afflitta da reumatismi e che zoppicava.
Un impiegato e due facchini si trovavano in piedi accanto al tavolo di Giovanni. Doveva essersi verificato qualche disordine in una consegna di merci e Giovanni aveva uno di quei suoi interventi ruvidi nel funzionamento del suo magazzino del quale egli raramente si occupava volendo avere la mente libera per fare – come diceva lui – solo quello che nessun altro avrebbe potuto fare in vece sua. Urlava più del consueto come se avesse voluto incidere nelle orecchie dei suoi dipendenti le sue disposizioni. Credo si trattasse di stabilire la forma in cui dovevano svolgersi i rapporti fra l’ufficio e il magazzino.
– Questa carta – urlava Giovanni passando dalla mano destra alla sinistra una carta ch’egli aveva strappata da un libro, – sarà firmata da te e l’impiegato che la riceverà te ne darà una identica firmata da lui.
Fissava in faccia i suoi interlocutori ora traverso gli occhiali ed ora al disopra di essi e concluse con un altro urlo:
– Avete capito?
Voleva riprendere le sue spiegazioni da capo, ma a me sembrava di perdere troppo tempo. Avevo il sentimento curioso che affrettandomi avrei potuto meglio battermi per Ada, mentre poi m’accorsi con grande sorpresa che nessuno m’aspettava e che io nessuno aspettavo, e che non c’era niente da fare per me. Andai a Giovanni con la mano tesa:
– Vengo da lei questa sera.
Egli fu subito da me, mentre gli altri si tiravano in disparte.
– Perché non la vediamo da tanto tempo? – domandò con semplicità.
Io fui colto da una meraviglia che mi confuse. Era proprio questa la domanda che Ada non m’aveva fatta e cui avrei avuto diritto. Se non ci fossero stati quegli altri, io avrei parlato sinceramente con Giovanni che quella domanda m’aveva fatta e m’aveva provata la sua innocenza in quella ch’io oramai sentivo quale una congiura ai miei danni. Lui solo era innocente e meritava la mia fiducia.
Forse subito allora non pensai con tanta chiarezza e ne è prova il fatto che non ebbi la pazienza di aspettare che l’impiegato ed i facchini si fossero allontanati. Eppoi volevo studiare se forse ad Ada non fosse stata impedita quella domanda dall’arrivo inopinato di Guido.
Ma anche Giovanni m’impedì di parlare, manifestando una grande fretta di ritornare al suo lavoro.
– Ci vediamo allora questa sera. Sentirà un violinista quale non ha sentito mai. Si presenta quale un dilettante del violino solo perché ha tanti di quei denari che non si degna di farne la sua professione. Intende di dedicarsi al commercio. – Si strinse nelle spalle in atto di dispregio. – Io, che pur amo il commercio, al posto suo non venderei che delle note. Non so se lei lo conosce. È un certo Guido Speier.
– Davvero? Davvero? – dissi simulando compiacenza, scotendo la testa e aprendo la bocca, movendo insomma tutto quello che potevo raggiungere per mio volere. Quel bel giovinotto sapeva anche sonare il violino? – Davvero? Tanto bene? – Speravo che Giovanni avesse scherzato e con l’esagerazione delle sue lodi avesse voluto significare che Guido non fosse altro che un tartassatore del violino. Ma egli scoteva la testa sempre con grande ammirazione.
Gli strinsi la mano:
– Arrivederci!
M’avviai zoppicando alla porta. Fui fermato da un dubbio. Forse avrei fatto meglio di non accettare quell’invito nel quale caso avrei dovuto prevenirne Giovanni. Mi volsi per ritornare a lui, ma allora m’accorsi ch’egli mi guardava con grande attenzione proteso per innanzi per vedermi più da vicino. Questo non seppi sopportare e me ne andai!
Un violinista! Se era vero ch’egli sonava tanto bene, io semplicemente ero un uomo distrutto. Almeno non avessi sonato io quell’istrumento o non mi fossi lasciato indurre di sonarlo in casa Malfenti. Avevo portato il violino in quella casa non per conquistare col mio suono il cuore della gente, ma quale un pretesto per prolungarvi le mie visite. Ero stato una bestia! Avrei potuto usare di tanti altri pretesti meno compromettenti!
Nessuno potrà dire ch’io m’abbandoni ad illusioni sul conto mio. So di avere un alto sentimento musicale e non è per affettazione ch’io ricerco la musica più complessa; però il mio stesso alto sentimento musicale m’avverte e m’avvertì da anni, ch’io mai arriverò a sonare in modo da dar piacere a chi m’ascolta. Se tuttavia continuo a sonare, lo faccio per la stessa ragione per cui continuo a curarmi. Io potrei sonare bene se non fossi malato, e corro dietro alla salute anche quando studio l’equilibrio sulle quattro corde. C’è una lieve paralisi nel mio organismo, e sul violino si rivela intera e perciò più facilmente guaribile. Anche l’essere più basso quando sa che cosa sieno le terzine, le quartine o le sestine, sa passare dalle une alle altre con esattezza ritmica come il suo occhio sa passare da un colore all’altro. Da me, invece, una di quelle figure, quando l’ho fatta, mi si appiccica e non me ne libero più, così ch’essa s’intrufola nella figura seguente e la sforma. Per mettere al posto giusto le note, io devo battermi il tempo coi piedi e con la testa, ma addio disinvoltura, addio serenità, addio musica. La musica che proviene da un organismo equilibrato è lei stessa il tempo ch’essa crea ed esaurisce. Quando la farò così sarò guarito.
Per la prima volta pensai di abbandonare il campo, lasciare Trieste e andare altrove in cerca di svago. Non c’era più nulla da sperare. Ada era perduta per me. Ne ero certo! Non sapevo io forse, ch’essa avrebbe sposato un uomo dopo di averlo vagliato e pesato come se si fosse trattato di concedergli un’onorificenza accademica? Mi pareva ridicolo perché veramente il violino fra esseri umani non avrebbe potuto contare nella scelta di un marito, ma ciò non mi salvava. Io sentivo l’importanza di quel suono. Era decisiva come dagli uccelli canori.
Mi rintanai nel mio studio e il giorno festivo per gli altri non era ancora finito! Trassi il violino dalla busta, indeciso se mandarlo a pezzi o suonarlo. Poi lo provai come se avessi voluto dargli l’ultimo addio e infine mi misi a studiare l’eterno Kreutzer. In quello stesso posto avevo fatto percorrere tanti di quei chilometri al mio arco, che nel mio disorientamento mi rimisi a percorrerne macchinalmente degli altri.
Tutti coloro che si dedicarono a quelle maledette quattro corde sanno come, finché si viva isolati, si creda che ogni piccolo sforzo apporti un corrispondente progresso. Se così non fosse, chi accetterebbe di sottoporsi a quei lavori forzati senza termine, come se si avesse avuta la disgrazia di ammazzare qualcuno? Dopo un po’ di tempo mi parve che la mia lotta con Guido non fosse definitivamente perduta. Chissà che forse non mi fosse concesso d’intervenire fra Guido e Ada con un violino vittorioso?
Non era presunzione questa, ma il mio solito ottimismo da cui mai seppi liberarmi. Ogni minaccia di sventura m’atterrisce dapprima, ma subito dopo è dimenticata nella fiducia più sicura di saper evitarla. Lì, poi, non occorreva che rendere più benevolo il mio giudizio sulle mie capacità di violinista. Nelle arti in genere si sa che il giudizio sicuro risulta dal confronto, che qui mancava. Eppoi il proprio violino echeggia tanto vicino all’orecchio che ha breve la via al cuore. Quando, stanco, smisi di suonare, mi dissi:
– Bravo Zeno, hai guadagnato il tuo pane.
Senz’alcuna esitazione mi recai dai Malfenti. Avevo accettato l’invito ed oramai non potevo mancare. Mi parve di buon augurio che la cameriera m’accogliesse con un sorriso gentile e la domanda se fossi stato male per non esser venuto per tanto tempo. Le diedi una mancia. Per bocca sua tutta la famiglia di cui essa era la rappresentante, mi faceva quella domanda.
Essa mi condusse al salotto ch’era immerso nell’oscurità più profonda. Arrivatovi dalla piena luce dell’anticamera, per un momento non vidi nulla e non osai movermi. Poi scorsi varie figure disposte intorno ad un tavolino, in fondo al salotto, abbastanza lontano da me.
Fui salutato dalla voce di Ada che nell’oscurità mi parve sensuale. Sorridente, una carezza:
– S’accomodi, da quella parte e non turbi gli spiriti! – Se continuava così io non li avrei certamente turbati.
Da un altro punto della periferia del tavolino echeggiò un’altra voce, di Alberta o forse di Augusta:
– Se vuole prendere parte all’evocazione, c’è qui ancora un posticino libero.
Io ero ben risoluto di non lasciarmi mettere in disparte e avanzai risoluto verso il punto donde m’era provenuto il saluto di Ada. Urtai col ginocchio contro lo spigolo di quel tavolino veneziano ch’era tutto spigoli. Ne ebbi un dolore intenso, ma non mi lasciai arrestare e andai a cadere su un sedile offertomi non sapevo da chi, fra due fanciulle di cui una, quella alla mia destra, pensai fosse Ada e l’altra Augusta. Subito, per evitare ogni contatto con questa, mi spinsi verso l’altra. Ebbi però il dubbio che mi sbagliassi e alla vicina di destra domandai per sentirne la voce:
– Aveste già qualche comunicazione dagli spiriti?
Guido, che mi parve sedesse a me di faccia, m’interruppe. Imperiosamente gridò:
– Silenzio!
Poi, più mitemente:
– Raccoglietevi e pensate intensamente al morto che desiderate di evocare.
Io non ho alcun’avversione per i tentativi di qualunque genere di spiare il mondo di là. Ero anzi seccato di non aver introdotto io in casa di Giovanni quel tavolino, giacché vi otteneva tale successo. Ma non mi sentivo di obbedire agli ordini di Guido e perciò non mi raccolsi affatto. Poi m’ero fatti tanti di quei rimproveri per aver permesso che le cose arrivassero a quel punto senz’aver detta una parola chiara ad Ada, che giacché avevo la fanciulla accanto, in quell’oscurità tanto favorevole, avrei chiarito tutto. Fui trattenuto solo dalla dolcezza di averla tanto vicina a me dopo di aver temuto di averla perduta per sempre. Intuivo la dolcezza delle stoffe tiepide che sfioravano i miei vestiti e pensavo anche che così stretti l’uno all’altra, il mio toccasse il suo piedino che di sera sapevo vestito di uno stivaletto laccato. Era addirittura troppo dopo un martirio tanto lungo.
Parlò di nuovo Guido:
– Ve ne prego, raccoglietevi. Supplicate ora lo spirito che invocaste di manifestarsi movendo il tavolino.
Mi piaceva ch’egli continuasse ad occuparsi del tavolino. Oramai era evidente che Ada si rassegnava di portare quasi tutto il mio peso! Se non m’avesse amato non m’avrebbe sopportato. Era venuta l’ora della chiarezza. Tolsi la mia destra dal tavolino e pian pianino le posi il braccio alla taglia:
– Io vi amo, Ada! – dissi a bassa voce e avvicinando la mia faccia alla sua per farmi sentire meglio.
La fanciulla non rispose subito. Poi, con un soffio di voce, però quella di Augusta, mi disse:
– Perché non veniste per tanto tempo?
La sorpresa e il dispiacere quasi mi facevano crollare dal mio sedile. Subito sentii che se io dovevo finalmente eliminare quella seccante fanciulla dal mio destino, pure dovevo usarle il riguardo che un buon cavaliere quale son io, deve tributare alla donna che lo ama e sia dessa la più brutta che mai sia stata creata. Come m’amava! Nel mio dolore sentii il suo amore. Non poteva essere altro che l’amore che le aveva suggerito di non dirmi ch’essa non era Ada, ma di farmi la domanda che da Ada avevo attesa invano e che lei invece certo s’era preparata di farmi subito quando m’avesse rivisto.
Seguii un mio istinto e non risposi alla sua domanda, ma, dopo una breve esitazione, le dissi:
– Ho tuttavia piacere di essermi confidato a voi, Augusta, che io credo tanto buona!
Mi rimisi subito in equilibrio sul mio treppiede. Non potevo avere la chiarezza con Ada, ma intanto l’avevo completa con Augusta. Qui non potevano esserci altri malintesi.
Guido ammonì di nuovo:
– Se non volete star zitti, non c’è alcuno scopo di passare qui il nostro tempo all’oscuro!
Egli non lo sapeva, ma io avevo tuttavia bisogno di un po’ di oscurità che m’isolasse e mi permettesse di raccogliermi. Avevo scoperto il mio errore e il solo equilibrio che avessi riconquistato era quello sul mio sedile.
Avrei parlato con Ada, ma alla chiara luce. Ebbi il sospetto che alla mia sinistra non ci fosse lei, ma Alberta. Come accertarmene? Il dubbio mi fece quasi cadere a sinistra e, per riconquistare l’equilibrio, mi poggiai sul tavolino. Tutti si misero ad urlare: – Si muove, si muove! – Il mio atto involontario avrebbe potuto condurmi alla chiarezza. Donde veniva la voce di Ada? Ma Guido coprendo con la sua la voce di tutti, impose quel silenzio che io, tanto volentieri, avrei imposto a lui. Poi con voce mutata, supplice (imbecille!) parlò con lo spirito ch’egli credeva presente:
– Te ne prego, di’ il tuo nome designandone le lettere in base all’alfabeto nostro!
Egli prevedeva tutto: aveva paura che lo spirito ricordasse l’alfabeto greco.
Io continuai la commedia sempre spiando l’oscurità alla ricerca di Ada. Dopo una lieve esitazione feci alzare il tavolino per sette volte così che la lettera G era acquisita. L’idea mi parve buona e per quanto la U che seguiva costasse innumerevoli movimenti, dettai netto netto il nome di Guido. Non dubito che dettando il suo nome, io non fossi diretto dal desiderio di relegarlo fra gli spiriti.
Quando il nome di Guido fu perfetto, Ada finalmente parlò:
– Qualche vostro antenato? – suggerì. Sedeva proprio accanto a lui. Avrei voluto muovere il tavolino in modo da cacciarlo fra loro due e dividerli.
– Può essere! – disse Guido. Egli credeva di avere degli antenati, ma non mi faceva paura. La sua voce era alterata da una reale emozione che mi diede la gioia che prova uno schermidore quando s’accorge che l’avversario è meno temibile di quanto egli credesse. Non era mica a sangue freddo ch’egli faceva quegli esperimenti. Era un vero imbecille! Tutte le debolezze trovavano facilmente il mio compatimento, ma non la sua.
Poi egli si rivolse allo spirito:
– Se ti chiami Speier fa un movimento solo. Altrimenti movi il tavolino per due volte. – Giacché egli voleva avere degli antenati, lo compiacqui movendo il tavolino per due volte.
– Mio nonno! – mormorò Guido.
Poi la conversazione con lo spirito camminò più rapida. Allo spirito fu domandato se volesse dare delle notizie. Rispose di sì. D’affari od altre? D’affari! Questa risposta fu preferita solo perché per darla bastava movere il tavolo per una volta sola. Guido domandò poi se si trattava di buone o di cattive notizie. Le cattive dovevano essere designate con due movimenti ed io, – questa volta senz’alcun’esitazione, – volli movere il tavolo per due volte. Ma il secondo movimento mi fu contrastato e doveva esserci qualcuno nella compagnia che avrebbe desiderato che le nuove fossero buone. Ada, forse? Per produrre quel secondo movimento mi gettai addirittura sul tavolino e vinsi facilmente! Le notizie erano cattive!
Causa la lotta, il secondo movimento risultò eccessivo e spostò addirittura tutta la compagnia.
– Strano! – mormorò Guido. Poi, deciso, urlò:
– Basta! Basta! Qui qualcuno si diverte alle nostre spalle!
Fu un comando cui molti nello stesso tempo ubbidirono e il salotto fu subito inondato dalla luce accesa in più punti. Guido mi parve pallido! Ada s’ingannava sul conto di quell’individuo ed io le avrei aperti gli occhi.
Nel salotto, oltre alle tre fanciulle, v’erano la signora Malfenti ed un’altra signora la cui vista m’ispirò imbarazzo e malessere perché credetti fosse la zia Rosina. Per ragioni differenti le due signore ebbero da me un saluto compassato.
Il bello si è ch’ero rimasto al tavolino, solo accanto ad Augusta. Era una nuova compromissione, ma non sapevo rassegnarmi d’accompagnarmi a tutti gli altri che attorniavano Guido, il quale con qualche veemenza spiegava come avesse capito che il tavolo veniva mosso non da uno spirito ma da un malizioso in carne ed ossa. Non Ada, lui stesso aveva tentato di frenare il tavolino fattosi troppo chiacchierino. Diceva:
– Io trattenni il tavolino con tutte le mie forze per impedire che si movesse la seconda volta. Qualcuno dovette addirittura gettarsi su di esso per vincere la mia resistenza.
Bello quel suo spiritismo: Uno sforzo potente non poteva provenire da uno spirito!
Guardai la povera Augusta per vedere quale aspetto avesse dopo di aver avuta la mia dichiarazione d’amore per sua sorella. Era molto rossa, ma mi guardava con un sorriso benevolo. Solo allora si decise di confermare d’aver sentita quella dichiarazione:
– Non lo dirò a nessuno! – mi disse a bassa voce.
Ciò mi piacque molto.
– Grazie, – mormorai stringendole la mano non piccola, ma modellata perfettamente. Io ero disposto di diventare un buon amico di Augusta mentre prima di allora ciò non sarebbe stato possibile perché io non so essere l’amico delle persone brutte. Ma sentivo una certa simpatia per la sua taglia che avevo stretta e che avevo trovata più sottile di quanto l’avessi creduta. Anche la sua faccia era discreta, e pareva deforme solo causa quell’occhio che batteva una strada non sua. Avevo certamente esagerata quella deformità ritenendola estesa fino alla coscia.
Avevano fatto portare della limonata per Guido. Mi avvicinai al gruppo che tuttavia l’attorniava e m’imbattei nella signora Malfenti che se ne staccava. Ridendo di gusto le domandai.
– Abbisogna di un cordiale? – Ella ebbe un lieve movimento di disprezzo con le labbra:
– Non sembrerebbe un uomo! – disse chiaramente.
Io mi lusingai che la mia vittoria potesse avere un’importanza decisiva. Ada non poteva pensare altrimenti della madre. La vittoria ebbe subito l’effetto che non poteva mancare in un uomo fatto come son io. Mi sparì ogni rancore e non volli che Guido soffrisse ulteriormente. Certo il mondo sarebbe meno aspro se molti mi somigliassero.
Sedetti a lui da canto e, senza guardare gli altri, gli dissi:
– Dovete scusarmi, signor Guido. Mi sono permesso uno scherzo di cattivo genere. Sono stato io che ho fatto dichiarare al tavolino di essere mosso da uno spirito portante il vostro stesso nome. Non l’avrei fatto se avessi saputo che anche vostro nonno aveva quel nome.
Guido tradì nella sua cera, che si schiarì, come la mia comunicazione fosse importante per lui. Non volle però ammetterlo e mi disse:
– Queste signore sono troppo buone! Io non ho mica bisogno di conforto. La cosa non ha alcun’importanza. Vi ringrazio per la vostra sincerità, ma io avevo già indovinato che qualcuno aveva indossata la parrucca di mio nonno.
Rise, soddisfatto, dicendomi:
– Siete molto robusto, voi! Avrei dovuto indovinare che il tavolo veniva mosso dal solo altro uomo della compagnia.
M’ero dimostrato più forte di lui, infatti, ma presto dovetti sentirmi di lui più debole. Ada mi guardava con occhio poco amico e m’aggredì, le belle guancie infiammate:
– Mi dispiace per voi che abbiate potuto credervi autorizzato ad uno scherzo simile.
Mi mancò il fiato e, balbettando, dissi:
– Volevo ridere! Credevo che nessuno di noi avrebbe presa sul serio quella storia del tavolino.
Era un po’ tardi per attaccare Guido ed anzi, se avessi avuto un orecchio sensibile, avrei sentito che, mai più, in una lotta con lui, la vittoria avrebbe potuto essere mia. L’ira che Ada mi dimostrava era ben significativa. Come non intesi ch’essa era già tutta sua? Ma io m’ostinavo nel pensiero ch’egli non la meritava perché non era l’uomo ch’essa cercava col suo occhio serio. Non l’aveva sentito persino la signora Malfenti?
Tutti mi protessero e aggravarono la mia situazione. La signora Malfenti disse ridendo:
– Non fu che uno scherzo riuscito benissimo. – La zia Rosina aveva tuttavia il grosso corpo vibrante dal ridere e diceva ammirando:
– Magnifica!
Mi spiacque che Guido fosse tanto amichevole. Già, a lui non importava altro che di essere sicuro che le cattive notizie che il tavolino gli aveva date, non fossero state portate da uno spirito. Mi disse:
– Scommetto che dapprima non avete mosso il tavolo di proposito. L’avrete mosso la prima volta senza volerlo, eppoi appena avrete deciso di moverlo con malizia. Così la cosa conserverebbe una certa importanza, cioè soltanto fino al momento in cui non decideste di sabotare la vostra ispirazione.
Ada si volse e mi guardò con curiosità. Essa stava per manifestare a Guido una devozione eccessiva perdonandomi perché Guido m’aveva concesso il suo perdono. Glielo impedii:
– Ma no! – dissi deciso. – Io ero stanco d’aspettare quegli spiriti che non volevano venire e li sostituii per divertirmi.
Ada mi volse le spalle arcuandole in modo ch’ebbi tutto il sentimento d’essere stato schiaffeggiato. Persino i riccioli alla sua nuca mi parve significassero disdegno.
Come sempre, invece che guardare e ascoltare, ero tutt’occupato dal mio proprio pensiero. M’opprimeva il fatto che Ada si comprometteva orribilmente. Ne provavo un forte dolore come dinanzi alla rivelazione che la donna mia mi tradisse. Ad onta di quelle sue manifestazioni d’affetto per Guido, essa tuttavia poteva ancora essere mia, ma sentivo che non le avrei mai perdonato il suo contegno. È il mio pensiero troppo lento per saper seguire gli avvenimenti che si svolgono senz’attendere che nel mio cervello si sieno cancellate le impressioni lasciatevi dagli avvenimenti precedenti? Io dovevo tuttavia movermi sulla via segnatami dal mio proposito. Una vera, una cieca ostinazione. Volli anzi rendere il mio proposito più forte registrandolo un’altra volta. Andai ad Augusta che mi guardava ansiosamente con un sincero sorriso incoraggiante sulla faccia e le dissi serio e accorato:
– È forse l’ultima volta ch’io vengo in casa vostra perché io, questa sera stessa, dichiarerò il mio amore ad Ada.
– Non dovete farlo, – mi disse essa supplice. – Non v’accorgete di quello che qui succede? Mi dispiacerebbe se aveste a soffrirne.
Essa continuava a frapporsi fra me e Ada. Le dissi proprio per farle dispetto:
– Parlerò con Ada perché lo debbo. M’è poi del tutto indifferente quello ch’essa risponderà.
Zoppicai di nuovo verso Guido. Giunto accanto a lui, guardandomi in uno specchio, accesi una sigaretta. Nello specchio mi vidi molto pallido ciò che per me è una ragione per impallidire di più. Lottai per sentirmi meglio ed apparire disinvolto. Nel duplice sforzo la mia mano distratta afferrò il bicchiere di Guido. Una volta afferratolo non seppi far di meglio che vuotarlo.
Guido si mise a ridere:
– Così saprete tutti i miei pensieri perché poco fa ho bevuto anch’io da quel bicchiere.
Il sapore del limone m’è sempre sgradito. Quello dovette apparirmi velenoso addirittura perché, prima di tutto, per aver bevuto dal suo bicchiere a me parve d’aver subito un contatto odioso con Guido eppoi perché fui colpito nello stesso tempo dall’espressione d’impazienza iraconda che si stampò sulla faccia di Ada. Chiamò subito la cameriera per ordinarle un altro bicchiere di limonata e insistette nel suo ordine ad onta che Guido dichiarasse di non aver più sete.
Allora fui veramente compassionevole. Essa si comprometteva sempre più.
– Scusatemi, Ada, – le dissi sommessamente e guardandola come se mi fossi aspettata qualche spiegazione. – Io non volevo spiacervi.
Poi fui invaso dal timore che i miei occhi si bagnassero di lagrime. Volli salvarmi dal ridicolo. Gridai:
– Mi sono spruzzato del limone nell’occhio.
Mi coprii gli occhi col fazzoletto e perciò non ebbi più bisogno di sorvegliare le mie lagrime e bastò che badassi a non singhiozzare.
Non dimenticherò mai quell’oscurità dietro di quel fazzoletto. Vi celavo le mie lagrime, ma anche un momento di pazzia. Pensavo ch’io le avrei detto tutto, ch’essa m’avrebbe inteso e amato e ch’io non le avrei perdonato mai più.
Allontanai dalla mia faccia il fazzoletto, lasciai che tutti vedessero i miei occhi lagrimosi e feci uno sforzo per ridere e far ridere:
– Scommetto che il signor Giovanni manda a casa dell’acido citrico per fare le spremute.
In quel momento giunse Giovanni che mi salutò con la sua solita grande cordialità. Ne ebbi un piccolo conforto, che non durò a lungo, perché egli dichiarò ch’era venuto prima del solito per il desiderio di sentir suonare Guido. S’interruppe per domandare ragione delle lagrime che mi bagnavano gli occhi. Gli raccontarono dei miei sospetti sulla qualità delle sue spremute, ed egli ne rise.
Io fui tanto vile d’associarmi con calore alle preghiere che Giovanni rivolgeva a Guido perché suonasse. Ricordavo: non ero io venuto quella sera per sentire il violino di Guido? Ed il curioso è che so d’aver sperato di rabbonire Ada con le mie sollecitazioni a Guido. La guardai sperando d’essere finalmente associato a lei per la prima volta in quella sera. Quale stranezza! Non avevo da parlarle e da non perdonarle? Invece non vidi che le sue spalle e i riccioli sdegnosi alla sua nuca. Era corsa a trarre il violino dalla busta.
Guido domandò di essere lasciato in pace ancora per un quarto d’ora. Pareva esitante. Poi nei lunghi anni in cui lo conobbi feci l’esperienza ch’egli sempre esitava prima di fare le cose anche più semplici di cui veniva pregato. Egli non faceva che ciò che gli piaceva e, prima di consentire ad una preghiera, procedeva ad un’indagine nelle proprie cavità per vedere quello che laggiù si desiderava.
Poi in quella memoranda serata ci fu per me il quarto d’ora più felice. La mia chiacchierata capricciosa fece divertire tutti, Ada compresa. Era certamente dovuta alla mia eccitazione, ma anche al mio sforzo supremo di vincere quel violino minaccioso che s’avvicinava, s’avvicinava… E quel piccolo tratto di tempo che gli altri per opera mia sentirono come tanto divertente, io lo ricordo dedicato ad una lotta affannosa.
Giovanni aveva raccontato che nel tram, sul quale era rincasato, aveva assistito ad una scena penosa. Una donna ne era scesa quando il veicolo era ancora in movimento e tanto malamente da cadere e ferirsi. Giovanni descriveva con un poco di esagerazione la sua ansia all’accorgersi che quella donna s’apprestava a fare quel salto e in modo tale che era evidente sarebbe stata atterrata e forse travolta. Era ben doloroso di prevedere e di non essere più in tempo di salvare.
Io ebbi una trovata. Raccontai che per quelle vertigini che in passato m’avevano fatto soffrire, avevo scoperto un rimedio. Quando vedevo un ginnasta fare i suoi esercizi troppo in alto, o quando assistevo alla discesa da un tram in corsa di persona troppo vecchia o poco abile, mi liberavo da ogni ansia augurando loro dei malanni. Arrivavo persino a modulare le parole con cui auguravo loro di precipitare e sfracellarsi. Ciò mi tranquillava enormemente per cui potevo assistere del tutto inerte alla minaccia della disgrazia. Se i miei augurii poi non si compivano, potevo dirmi ancora più contento.
Guido fu incantato della mia idea che gli pareva una scoperta psicologica. L’analizzava come faceva di tutte le inezie, non vedeva l’ora di poter provare il rimedio. Ma faceva una riserva: che i malaugurii non facessero aumentare le disgrazie. Ada s’associò al suo riso ed ebbe per me persino un’occhiata d’ammirazione. Io, baggeo, ne ebbi una grande soddisfazione. Ma scoprii che non era vero ch’io non avrei più saputo perdonarle: anche questo era un grande vantaggio.
Si rise insieme moltissimo, da buoni ragazzi che si vogliono bene. Ad un certo momento ero rimasto da una parte del salotto, solo con zia Rosina. Essa parlava ancora del tavolino. Abbastanza grassa, stava immobile sulla sua sedia e mi parlava senza guardarmi. Io trovai il modo di far capire agli altri che mi seccavo e tutti mi guardavano, senza farsi vedere dalla zia, ridendo discretamente.
Per aumentare l’ilarità mi pensai di dirle senz’alcuna preparazione:
– Ma Lei, signora, è molto rimessa, la trovo ringiovanita.
Ci sarebbe stato da ridere se essa si fosse arrabbiata. Ma la signora invece di arrabbiarsi mi si dimostrò gratissima e mi raccontò che infatti s’era molto rimessa dopo di una recente malattia. Fui tanto stupito da quella risposta che la mia faccia dovette assumere un aspetto molto comico così che l’ilarità che aveva sperata non mancò. Poco dopo l’enigma mi fu spiegato. Seppi, cioè, che non era zia Rosina, ma zia Maria, una sorella della signora Malfenti. Avevo così eliminato da quel salotto una fonte di malessere per me, ma non la maggiore.
A un dato momento Guido domandò il violino. Faceva a meno per quella sera dell’accompagnamento del piano, eseguendo la Chaconne. Ada gli porse il violino con un sorriso di ringraziamento. Egli non la guardò, ma guardò il violino come se avesse voluto segregarsi seco e con l’ispirazione. Poi si mise in mezzo al salotto volgendo la schiena a buona parte della piccola società, toccò lievemente le corde con l’arco per accordarle e fece anche qualche arpeggio. S’interruppe per dire con un sorriso:
– Un bel coraggio il mio, quando si pensi che non ho toccato il violino dall’ultima volta in cui suonai qui!
Ciarlatano! Egli volgeva le spalle anche ad Ada. Io la guardai ansiosamente per vedere se essa ne soffrisse. Non pareva! Aveva poggiato il gomito su un tavolino e il mento sulla mano raccogliendosi per ascoltare.
Poi, contro di me, si mise il grande Bach in persona. Giammai, né prima né poi, arrivai a sentire a quel modo la bellezza di quella musica nata su quelle quattro corde come un angelo di Michelangelo in un blocco di marmo. Solo il mio stato d’animo era nuovo per me e fu desso che m’indusse a guardare estatico in su, come a cosa novissima. Eppure io lottavo per tenere quella musica lontana da me. Mai cessai di pensare: «Bada! Il violino è una sirena e si può far piangere con esso anche senz’avere il cuore di un eroe!». Fui assaltato da quella musica che mi prese. Mi parve dicesse la mia malattia e i miei dolori con indulgenza e mitigandoli con sorrisi e carezze. Ma era Guido che parlava! Ed io cercavo di sottrarmi alla musica dicendomi: «Per saper fare ciò, basta disporre di un organismo ritmico, una mano sicura e una capacità d’imitazione; tutte cose che io non ho, ciò che non è un’inferiorità, ma una sventura».
Io protestavo, ma Bach procedeva sicuro come il destino. Cantava in alto con passione e scendeva a cercare il basso ostinato che sorprendeva per quanto l’orecchio e il cuore l’avessero anticipato: proprio al suo posto! Un attimo più tardi e il canto sarebbe dileguato e non avrebbe potuto essere raggiunto dalla risonanza; un attimo prima e si sarebbe sovrapposto al canto, strozzandolo. Per Guido ciò non avveniva: non gli tremava il braccio neppure affrontando Bach e ciò era una vera inferiorità.
Oggi che scrivo ho tutte le prove di ciò. Non gioisco per aver visto allora tanto esattamente. Allora ero pieno di odio e quella musica, ch’io accettavo come la mia anima stessa, non seppe addolcirlo. Poi venne la vita volgare di ogni giorno e l’annullò senza che da parte mia vi fosse alcuna resistenza. Si capisce! La vita volgare sa fare tante di quelle cose. Guai se i geni se ne accorgessero!
Guido cessò di suonare sapientemente. Nessuno plaudì fuori di Giovanni, e per qualche istante nessuno parlò. Poi, purtroppo, sentii io il bisogno di parlare. Come osai di farlo davanti a gente che il mio violino conosceva? Pareva parlasse il mio violino che invano anelava alla musica e biasimasse l’altro sul quale – non si poteva negarlo – la musica era divenuta vita, luce ed aria.
– Benissimo! – dissi e aveva tutto il suono di una concessione più che di un applauso. – Ma però non capisco perché, verso la chiusa, abbiate voluto scandere quelle note che il Bach segnò legate.
Io conoscevo la Chaconne nota per nota. C’era stata un’epoca in cui avevo creduto che, per progredire, avrei dovuto affrontare di simili imprese e per lunghi mesi passai il tempo a compitare battuta per battuta alcune composizioni del Bach.
Sentii che in tutto il salotto non v’era per me che biasimo e derisione. Eppure parlai ancora lottando contro quell’ostilità.
– Bach – aggiunsi – è tanto modesto nei suoi mezzi che non ammette un arco fatturato a quel modo.
Io avevo probabilmente ragione, ma era anche certo ch’io non avrei neppur saputo fatturare l’arco a quel modo.
Guido fu subito altrettanto spropositato quanto lo ero stato io. Dichiarò:
– Forse Bach non conosceva la possibilità di quell’espressione. Gliela regalo io!
Egli montava sulle spalle di Bach, ma in quell’ambiente nessuno protestò mentre mi si aveva deriso perché io avevo tentato di montare soltanto sulle sue.
Allora avvenne una cosa di minima importanza, ma che fu per me decisiva. Da una stanza abbastanza lontana da noi echeggiarono le urla della piccola Anna. Come si seppe poi, era caduta insanguinandosi le labbra. Fu così ch’io per qualche minuto mi trovai solo con Ada perché tutti uscirono di corsa dal salotto. Guido, prima di seguire gli altri, aveva posto il suo prezioso violino nelle mani di Ada.
– Volete dare a me quel violino? – domandai io ad Ada vedendola esitante se seguire gli altri. Davvero che non m’ero ancora accorto che l’occasione tanto sospirata s’era finalmente presentata.
Ella esitò, ma poi una sua strana diffidenza ebbe il sopravvento. Trasse il violino ancora meglio a sé:
– No – rispose, – non occorre ch’io vada con gli altri. Non credo che Anna si sia fatta tanto male. Essa strilla per nulla.
Sedette col suo violino e a me parve che con quest’atto essa m’avesse invitato di parlare. Del resto, come avrei potuto io andar a casa senz’aver parlato? Che cosa avrei poi fatto in quella lunga notte? Mi vedevo ribaltarmi da destra a sinistra nel mio letto o correre per le vie o le bische in cerca di svago. No! Non dovevo abbandonare quella casa senz’essermi procurata la chiarezza e la calma.
Cercai di essere semplice e breve. Vi ero anche costretto perché mi mancava il fiato. Le dissi:
– Io vi amo, Ada. Perché non mi permettereste di parlarne a vostro padre?
Ella mi guardò stupita e spaventata. Temetti che si mettesse a strillare come la piccina, là fuori. Io sapevo che il suo occhio sereno e la sua faccia dalle linee tanto precise non sapevano l’amore, ma tanto lontana dall’amore come ora, non l’avevo mai vista. Incominciò a parlare e disse qualcosa che doveva essere come un esordio. Ma io volevo la chiarezza: un sì o un no! Forse m’offendeva già quanto mi pareva un’esitazione. Per fare presto e indurla a decidersi, discussi il suo diritto di prendersi tempo:
– Ma come non ve ne sareste accorta? A voi non era possibile di credere ch’io facessi la corte ad Augusta!
Volli mettere dell’enfasi nelle mie parole, ma, nella fretta, la misi fuori di posto e finì che quel povero nome di Augusta fu accompagnato da un accento e da un gesto di disprezzo.
Fu così che levai Ada dall’imbarazzo. Essa non rilevò altro che l’offesa fatta ad Augusta:
– Perché credete di essere superiore ad Augusta? Io non penso mica che Augusta accetterebbe di divenire vostra moglie!
Poi appena ricordò che mi doveva una risposta:
– In quanto a me… mi meraviglia che vi sia capitata una cosa simile in testa.
La frase acre doveva vendicare l’Augusta. Nella mia grande confusione pensai che anche il senso della parola non avesse avuto altro scopo; se mi avesse schiaffeggiato credo che sarei stato esitante a studiarne la ragione. Perciò ancora insistetti:
– Pensateci, Ada. Io non sono un uomo cattivo. Sono ricco… Sono un po’ bizzarro, ma mi sarà facile di correggermi.
Anche Ada fu più dolce, ma parlò di nuovo di Augusta.
– Pensateci anche voi, Zeno: Augusta è una buona fanciulla e farebbe veramente al caso vostro. Io non posso parlare per conto suo, ma credo…
Era una grande dolcezza di sentirmi invocare da Ada per la prima volta col mio prenome. Non era questo un invito a parlare ancora più chiaro? Forse era perduta per me, o almeno non avrebbe accettato subito di sposarmi, ma intanto bisognava evitare che si compromettesse di più con Guido sul conto del quale dovevo aprirle gli occhi. Fui accorto, e prima di tutto le dissi che stimavo e rispettavo Augusta, ma che assolutamente non volevo sposarla. Lo dissi due volte per farmi intendere chiaramente: «io non volevo sposarla». Così potevo sperare di aver rabbonita Ada che prima aveva creduto io volessi offendere Augusta.
– Una buona, una cara, un’amabile ragazza quell’Augusta; ma non fa per me.
Poi appena precipitai le cose, perché c’era del rumore sul corridoio e mi poteva essere tagliata la parola da un momento all’altro.
– Ada! Quell’uomo non fa per voi. È un imbecille! Non v’accorgeste come sofferse per i responsi del tavolino? Avete visto il suo bastone? Suona bene il violino, ma vi sono anche delle scimmie che sanno suonarlo. Ogni sua parola tradisce il bestione…
Essa, dopo d’esser stata ad ascoltarmi con l’aspetto di chi non sa risolversi ad ammettere nel loro senso le parole che gli sono dirette, m’interruppe. Balzò in piedi sempre col violino e l’arco in mano e mi soffiò addosso delle parole offensive. Io feci del mio meglio per dimenticarle e vi riuscii. Ricordo solo che cominciò col domandarmi ad alta voce come avevo potuto parlare così di lui e di lei! Io feci gli occhi grandi dalla sorpresa perché mi pareva di non aver parlato che di lui solo. Dimenticai le tante parole sdegnose ch’essa mi diresse, ma non la sua bella, nobile e sana faccia arrossata dallo sdegno e dalle linee rese più precise, quasi marmoree, dall’indignazione. Quella non dimenticai più e quando penso al mio amore e alla mia giovinezza, rivedo la faccia bella e nobile e sana di Ada nel momento in cui essa m’eliminò definitivamente dal suo destino.
Ritornarono tutti in gruppo intorno alla signora Malfenti che teneva in braccio Anna ancora piangente. Nessuno si occupò di me o di Ada ed io, senza salutare nessuno, uscii dal salotto; nel corridoio presi il mio cappello. Curioso! Nessuno veniva a trattenermi. Allora mi trattenni da solo, ricordando ch’io non dovevo mancare alle regole della buona educazione e che perciò prima di andarmene dovevo salutare compitamente tutti. Vero è che non dubito io non sia stato impedito di abbandonare quella casa dalla convinzione che troppo presto sarebbe cominciata per me la notte ancora peggiore delle cinque notti che l’avevano preceduta. Io che finalmente avevo la chiarezza, sentivo ora un altro bisogno: quello della pace, la pace con tutti. Se avessi saputo eliminare ogni asprezza dai miei rapporti con Ada e con tutti gli altri, mi sarebbe stato più facile di dormire. Perché aveva da sussistere tale asprezza? Se non potevo prendermela neppure con Guido il quale se anche non ne aveva alcun merito, certamente non aveva nessuna colpa di essere stato preferito da Ada!
Essa era la sola che si fosse accorta della mia passeggiata sul corridoio e, quando mi vide ritornare, mi guardò ansiosa. Temeva di una scena? Subito volli rassicurarla. Le passai accanto e mormorai:
– Scusate se vi ho offesa!
Essa prese la mia mano e, rasserenata, la strinse. Fu un grande conforto. Io chiusi per un istante gli occhi per isolarmi con la mia anima e vedere quanta pace gliene fosse derivata.
Il mio destino volle che mentre tutti ancora si occupavano della bimba, io mi trovassi seduto accanto ad Alberta. Non l’avevo vista e di lei non m’accorsi che quando essa mi parlò dicendomi:
– Non s’è fatta nulla. Il grave è la presenza di papà il quale, se la vede piangere, le fa un bel regalo.
Io cessai dall’analizzarmi perché mi vidi intero! Per avere la pace io avrei dovuto fare in modo che quel salotto non mi fosse mai più interdetto. Guardai Alberta! Somigliava ad Ada! Era un po’ di lei più piccola e portava sul suo organismo evidenti dei segni non ancora cancellati dell’infanzia. Facilmente alzava la voce, e il suo riso spesso eccessivo le contraeva la faccina e gliel’arrossava. Curioso! In quel momento ricordai una raccomandazione di mio padre: «Scegli una donna giovine e ti sarà più facile di educarla a modo tuo». Il ricordo fu decisivo. Guardai ancora Alberta. Nel mio pensiero m’industriavo di spogliarla e mi piaceva così dolce e tenerella come supposi fosse.
Le dissi:
– Sentite, Alberta! Ho un’idea: avete mai pensato che siete nell’età di prendere marito?
– Io non penso di sposarmi! – disse essa sorridendo e guardandomi mitemente, senz’imbarazzo o rossore. – Penso invece di continuare i miei studii. Anche mamma lo desidera.
– Potreste continuare gli studii anche dopo sposata.
Mi venne un’idea che mi parve spiritosa e le dissi subito:
– Anch’io penso d’iniziarli dopo essermi sposato.
Essa rise di cuore, ma io m’accorsi che perdevo il mio tempo, perché non era con tali scipitezze che si poteva conquistare una moglie e la pace. Bisognava essere serii. Qui poi era facile perché venivo accolto tutt’altrimenti che da Ada.
Fui veramente serio. La mia futura moglie doveva intanto sapere tutto. Con voce commossa le dissi:
– Io, poco fa, ho indirizzata ad Ada la stessa proposta che ora feci a voi. Essa rifiutò con sdegno. Potete figurarvi in quale stato io mi trovi.
Queste parole accompagnate da un atteggiamento di tristezza non erano altro che la mia ultima dichiarazione d’amore per Ada. Divenivo troppo serio e, sorridendo, aggiunsi:
– Ma credo che se voi accettaste di sposarmi, io sarei felicissimo e dimenticherei per voi tutto e tutti.
Essa si fece molto seria per dirmi:
– Non dovete offendervene, Zeno, perché mi dispiacerebbe. Io faccio una grande stima di voi. So che siete un buon diavolo eppoi, senza saperlo, sapete molte cose, mentre i miei professori sanno esattamente tutto quello che sanno. Io non voglio sposarmi. Forse mi ricrederò, ma per il momento non ho che una mèta: vorrei diventare una scrittrice. Vedete quale fiducia vi dimostro. Non lo dissi mai a nessuno e spero non mi tradirete. Dal canto mio, vi prometto che non ripeterò a nessuno la vostra proposta.
– Ma anzi potete dirlo a tutti! – la interruppi io con stizza. Mi sentivo di nuovo sotto la minaccia di essere espulso da quel salotto e corsi al riparo. C’era poi un solo modo per attenuare in Alberta l’orgoglio di aver potuto respingermi ed io l’adottai non appena lo scopersi. Le dissi:
– Io ora farò la stessa proposta ad Augusta e racconterò a tutti che la sposai perché le sue due sorelle mi rifiutarono!
Ridevo di un buon umore eccessivo che m’aveva colto in seguito alla stranezza del mio procedere. Non era nella parola che mettevo lo spirito di cui ero tanto orgoglioso, ma nelle azioni.
Mi guardai d’intorno per trovare Augusta. Era uscita sul corridoio con un vassoio sul quale non v’era che un bicchiere semivuoto contenente un calmante per Anna. La seguii di corsa chiamandola per nome ed essa s’addossò alla parete per aspettarmi. Mi misi a lei di faccia e subito le dissi:
– Sentite, Augusta, volete che noi due ci sposiamo?
La proposta era veramente rude. Io dovevo sposare lei e lei me, ed io non domandavo quello ch’essa pensasse né pensavo potrebbe toccarmi di essere io costretto di dare delle spiegazioni. Se non facevo altro che quello che tutti volevano!
Essa alzò gli occhi dilatati dalla sorpresa. Così quello sbilenco era anche più differente del solito dall’altro. La sua faccia vellutata e bianca, dapprima impallidì di più, eppoi subito si congestionò. Afferrò con la destra il bicchiere che ballava sul vassoio. Con un filo di voce mi disse:
– Voi scherzate e ciò è male.
Temetti si mettesse a piangere ed ebbi la curiosa idea di consolarla dicendole della mia tristezza.
– Io non scherzo, – dissi serio e triste. – Domandai dapprima la sua mano ad Ada che me la rifiutò con ira, poi domandai ad Alberta di sposarmi ed essa, con belle parole, vi si rifiutò anch’essa. Non serbo rancore né all’una né all’altra. Solo mi sento molto, ma molto infelice.
Dinanzi al mio dolore essa si ricompose e si mise a guardarmi commossa, riflettendo intensamente. Il suo sguardo somigliava ad una carezza che non mi faceva piacere.
– Io devo dunque sapere e ricordare che voi non mi amate? – domandò.
Che cosa significava questa frase sibillina? Preludiava ad un consenso? Voleva ricordare! Ricordare per tutta la vita da trascorrersi con me? Ebbi il sentimento di chi per ammazzarsi si sia messo in una posizione pericolosa ed ora sia costretto a faticare per salvarsi. Non sarebbe stato meglio che anche Augusta m’avesse rifiutato e che mi fosse stato concesso di ritornare sano e salvo nel mio studiolo nel quale neppure quel giorno stesso m’ero sentito troppo male? Le dissi:
– Sì! Io non amo che Ada e sposerei ora voi…
Stavo per dirle che non potevo rassegnarmi di divenire un estraneo per Ada e che perciò mi contentavo di divenirle cognato. Sarebbe stato un eccesso, ed Augusta avrebbe di nuovo potuto credere che volessi dileggiarla. Perciò dissi soltanto:
– Io non so più rassegnarmi di restar solo.
Essa rimaneva tuttavia poggiata alla parete del cui sostegno forse sentiva il bisogno; però pareva più calma ed il vassoio era ora tenuto da una sola mano. Ero salvo e cioè dovevo abbandonare quel salotto, o potevo restarci e dovevo sposarmi? Dissi delle altre parole, solo perché impaziente di aspettare le sue che non volevano venire:
– Io sono un buon diavolo e credo che con me si possa vivere facilmente anche senza che ci sia un grande amore.
Questa era una frase che nei lunghi giorni precedenti avevo preparata per Ada per indurla a dirmi di sì anche senza sentire per me un grande amore.
Augusta ansava leggermente e taceva ancora. Quel silenzio poteva anche significare un rifiuto, il più delicato rifiuto che si potesse immaginare: io quasi sarei scappato in cerca del mio cappello, in tempo per porlo su una testa salva.
Invece Augusta, decisa, con un movimento dignitoso che mai dimenticai, si rizzò e abbandonò il sostegno della parete. Nel corridoio non largo essa si avvicinò così ancora di più a me che le stavo di faccia. Mi disse:
– Voi, Zeno, avete bisogno di una donna che voglia vivere per voi e vi assista. Io voglio essere quella donna.
Mi porse la mano paffutella ch’io quasi istintivamente baciai. Evidentemente non c’era più la possibilità di fare altrimenti. Devo poi confessare che in quel momento fui pervaso da una soddisfazione che m’allargò il petto. Non avevo più da risolvere niente, perché tutto era stato risolto. Questa era la vera chiarezza.
Fu così che mi fidanzai. Fummo subito festeggiatissimi. Il mio somigliava un poco al grande successo del violino di Guido, tanti furono gli applausi di tutti. Giovanni mi baciò e mi diede subito del tu. Con eccessiva espressione di affetto mi disse:
– Mi sentivo tuo padre da molto tempo, dacché cominciai a darti dei consigli per il tuo commercio.
La mia futura suocera mi porse anch’essa la guancia che sfiorai. A quel bacio non sarei sfuggito neppure se avessi sposato Ada.
– Vede ch’io avevo indovinato tutto, – mi disse con una disinvoltura incredibile e che non fu punita perché io non seppi né volli protestare.
Essa poi abbracciò Augusta e la grandezza del suo affetto si rivelò in un singhiozzo che le sfuggì interrompendo le sue manifestazioni di gioia. Io non potevo soffrire la signora Malfenti, ma devo dire che quel singhiozzo colorì, almeno per tutta quella sera, di una luce simpatica e importante il mio fidanzamento.
Alberta, raggiante, mi strinse la mano:
– Io voglio essere per voi una buona sorella. – E Ada:
– Bravo, Zeno! – Poi, a bassa voce: – Sappiatelo: giammai un uomo che creda di aver fatta una cosa con precipitazione, ha agito più saviamente di voi.
Guido mi diede una grande sorpresa:
– Da questa mattina avevo capito che volevate una o l’altra delle signorine Malfenti, ma non arrivavo a sapere quale.
Non dovevano dunque essere molto intimi se Ada non gli aveva parlato della mia corte! Che avessi davvero agito precipitosamente?
Poco dopo però, Ada mi disse ancora:
– Vorrei che mi voleste bene come un fratello. Il resto sia dimenticato: io non dirò mai nulla a Guido.
Era del resto bello di aver provocata tanta gioia in una famiglia. Non potevo goderne molto, solo perché ero molto stanco. Ero anche assonnato. Ciò provava che avevo agito con grande accortezza. La mia notte sarebbe stata buona.
A cena Augusta ed io assistemmo muti ai festeggiamenti che ci venivano fatti. Essa sentì il bisogno di scusarsi della sua incapacità di prender parte alla conversazione generale:
– Non so dir nulla. Dovete ricordare che, mezz’ora fa, io non sapevo quello che stava per succedermi.
Essa diceva sempre l’esatta verità. Si trovava fra il riso e il pianto e mi guardò. Volli accarezzarla anch’io con l’occhio e non so se vi riuscii.
Quella stessa sera a quel tavolo subii un’altra lesione. Fui ferito proprio da Guido.
Pare che poco prima ch’io fossi giunto per prendere parte alla seduta spiritistica, Guido avesse raccontato che nella mattina io avevo dichiarato di non essere una persona distratta. Gli diedero subito tante di quelle prove ch’io avevo mentito che, per vendicarsi, (o forse per far vedere ch’egli sapeva disegnare) fece due mie caricature. Nella prima ero rappresentato come, col naso in aria, mi poggiavo su un ombrello puntato a terra. Nella seconda l’ombrello s’era spezzato e il manico m’era penetrato nella schiena. Le due caricature raggiungevano lo scopo e facevano ridere col mezzuccio semplice che l’individuo che doveva rappresentarmi – invero affatto somigliante, ma caratterizzato da una grande calvizie – era identico nel primo e nel secondo schizzo e si poteva perciò figurarselo tanto distratto da non aver cambiato di aspetto per il fatto che un ombrello lo aveva trafitto.
Tutti risero molto e anzi troppo. Mi dolse intensamente il tentativo tanto ben riuscito di gettare su me del ridicolo. E fu allora che per la prima volta fui colto dal mio dolore lancinante. Quella sera mi dolsero l’avambraccio destro e l’anca. Un intenso bruciore, un formicolio nei nervi come se avessero minacciato di rattrappirsi. Stupito portai la mano destra all’anca e con la mano sinistra afferrai l’avambraccio colpito. Augusta mi domandò:
– Che hai?
Risposi che sentivo un dolore al posto contuso da quella caduta al caffè della quale s’era parlato anche quella sera stessa.
Feci subito un energico tentativo per liberarmi da quel dolore. Mi parve che ne sarei guarito se avessi saputo vendicarmi dell’ingiuria che m’era stata fatta. Domandai un pezzo di carta ed una matita e tentai di disegnare un individuo che veniva oppresso da un tavolino ribaltatoglisi addosso. Misi poi accanto a lui un bastone sfuggitogli di mano in seguito alla catastrofe. Nessuno riconobbe il bastone e perciò l’offesa non riuscì quale io l’avrei voluta. Perché poi si riconoscesse chi fosse quell’individuo e come fosse capitato in quella posizione, scrissi di sotto: «Guido Speier alle prese col tavolino». Del resto di quel disgraziato sotto al tavolino non si vedevano che le gambe, che avrebbero potuto somigliare a quelle di Guido se non le avessi storpiate ad arte, e lo spirito di vendetta non fosse intervenuto a peggiorare il mio disegno già tanto infantile.
Il dolore assillante mi fece lavorare in grande fretta. Certo giammai il mio povero organismo fu talmente pervaso dal desiderio di ferire e se avessi avuta in mano la sciabola invece di quella matita che non sapevo muovere, forse la cura sarebbe riuscita.
Guido rise sinceramente del mio disegno, ma poi osservò mitemente:
– Non mi pare che il tavolino m’abbia nociuto!
Non gli aveva infatti nociuto ed era questa l’ingiustizia di cui mi dolevo.
Ada prese i due disegni di Guido e disse di voler conservarli. Io la guardai per esprimerle il mio rimprovero ed essa dovette stornare il suo sguardo dal mio. Avevo il diritto di rimproverarla perché faceva aumentare il mio dolore.
Trovai una difesa in Augusta. Essa volle che sul mio disegno mettessi la data del nostro fidanzamento perché voleva conservare anche lei quello sgorbio. Un’onda calda di sangue inondò le mie vene a tale segno d’affetto che per la prima volta riconobbi tanto importante per me. Il dolore però non cessò e dovetti pensare che se quell’atto d’affetto mi fosse venuto da Ada, esso avrebbe provocata nelle mie vene una tale ondata di sangue che tutti i detriti accumulatisi nei miei nervi ne sarebbero stati spazzati via.
Quel dolore non m’abbandonò più. Adesso, nella vecchiaia, ne soffro meno perché, quando mi coglie, lo sopporto con indulgenza: «Ah! Sei qui, prova evidente che sono stato giovine?». Ma in gioventù fu altra cosa. Io non dico che il dolore sia stato grande, per quanto talvolta m’abbia impedito il libero movimento o mi abbia tenuto desto per notti intere. Ma esso occupò buona parte della mia vita. Volevo guarirne! Perché avrei dovuto portare per tutta la vita sul mio corpo stesso lo stigma del vinto? Divenire addirittura il monumento ambulante della vittoria di Guido? Bisognava cancellare dal mio corpo quel dolore.
Così cominciarono le cure. Ma, subito dopo, l’origine rabbiosa della malattia fu dimenticata e mi fu ora persino difficile di ritrovarla. Non poteva essere altrimenti: io avevo una grande fiducia nei medici che mi curarono e credetti loro sinceramente quando attribuirono quel dolore ora al ricambio ed ora alla circolazione difettosa, poi alla tubercolosi o a varie infezioni di cui qualcuna vergognosa. Devo poi confessare che tutte le cure m’arrecarono qualche sollievo temporaneo per cui ogni volta l’eventuale nuova diagnosi sembrava confermata. Prima o poi risultava meno esatta, ma non del tutto erronea, perché da me nessuna funzione è idealmente perfetta.
Una volta sola ci fu un vero errore: una specie di veterinario nelle cui mani m’ero posto, s’ostinò per lungo tempo ad attaccare il mio nervo sciatico coi suoi vescicanti e finì coll’essere beffato dal mio dolore che improvvisamente, durante una seduta, saltò dall’anca alla coppa, lungi perciò da ogni connessione col nervo sciatico. Il cerusico s’arrabbiò e mi mise alla porta ed io me ne andai – me lo ricordo benissimo – niente affatto offeso, ammirato invece che il dolore al nuovo posto non avesse cambiato per nulla. Rimaneva rabbioso e irraggiungibile come quando m’aveva torturata l’anca. È strano come ogni parte del nostro corpo sappia dolere allo stesso modo.
Tutte le altre diagnosi vivono esattissime nel mio corpo e si battono fra di loro per il primato. Vi sono delle giornate in cui vivo per la diatesi urica ed altre in cui la diatesi è uccisa, cioè guarita, da un’infiammazione delle vene. Io ho dei cassetti interi di medicinali e sono i soli cassetti miei che tengo io stesso in ordine. Io amo le mie medicine e so che quando ne abbandono una, prima o poi vi ritornerò. Del resto non credo di aver perduto il mio tempo. Chissà da quanto tempo e di quale malattia io sarei già morto se il mio dolore in tempo non le avesse simulate tutte per indurmi a curarle prima ch’esse m’afferrassero.
Ma pur senza saper spiegarne l’intima natura, io so quando il mio dolore per la prima volta si formò. Proprio per quel disegno tanto migliore del mio. Una goccia che fece traboccare il vaso! Io sono sicuro di non aver mai prima sentito quel dolore. Ad un medico volli spiegarne l’origine, ma non m’intese. Chissà? Forse la psico-analisi porterà alla luce tutto il rivolgimento che il mio organismo subì in quei giorni e specialmente nelle poche ore che seguirono al mio fidanzamento.
Non furono neppure poche, quelle ore!
Quando, tardi, la compagnia si sciolse, Augusta lietamente mi disse:
– A domani!
L’invito mi piacque perché provava che avevo raggiunto il mio scopo e che niente era finito e tutto avrebbe continuato il giorno appresso. Essa mi guardò negli occhi e trovò i miei vivamente annuenti così da confortarla. Scesi quegli scalini, che non contai più, domandandomi:
– Chissà se l’amo?
È un dubbio che m’accompagnò per tutta la vita e oggidì posso pensare che l’amore accompagnato da tanto dubbio sia il vero amore.
Ma neppure dopo abbandonata quella casa, mi fu concesso di andar a coricarmi e raccogliere il frutto della mia attività di quella serata in un sonno lungo e ristoratore. Faceva caldo. Guido sentì il bisogno di un gelato e m’invitò ad accompagnarlo ad un caffè. S’aggrappò amichevolmente al mio braccio ed io, altrettanto amichevolmente, sostenni il suo. Egli era una persona molto importante per me e non avrei saputo rifiutargli niente. La grande stanchezza che avrebbe dovuto cacciarmi a letto, mi rendeva più arrendevole del solito.
Entrammo proprio nella bottega ove il povero Tullio m’aveva infettato con la sua malattia, e ci mettemmo a sedere ad un tavolo appartato. Sulla via il mio dolore che io ancora non sapevo quale compagno fedele mi sarebbe stato, m’aveva fatto soffrire molto e, per qualche istante, mi parve si attenuasse perché mi fu concesso di sedere.
La compagnia di Guido fu addirittura terribile. S’informava con grande curiosità della storia dei miei amori con Augusta. Sospettava ch’io lo ingannassi? Gli dissi sfacciatamente che io di Augusta m’ero innamorato subito alla mia prima visita in casa Malfenti. Il mio dolore mi rendeva ciarliero, quasi avessi voluto gridare più di esso. Ma parlai troppo e se Guido fosse stato più attento si sarebbe accorto che io non ero tanto innamorato di Augusta. Parlai della cosa più interessante nel corpo di Augusta, cioè quell’occhio sbilenco che a torto faceva credere che anche il resto non fosse al suo vero posto. Poi volli spiegare perché non mi fossi fatto avanti prima. Forse Guido era meravigliato di avermi visto capitare in quella casa all’ultimo momento per fidanzarmi. Urlai:
– Intanto le signorine Malfenti sono abituate ad un grande lusso ed io non potevo sapere se ero al caso di addossarmi una cosa simile.
Mi dispiacque di aver così parlato anche di Ada, ma non v’era più rimedio; era tanto difficile di isolare Augusta da Ada! Continuai abbassando la voce per sorvegliarmi meglio:
– Dovetti perciò fare dei calcoli. Trovai che il mio denaro non bastava. Allora mi misi a studiare se potevo allargare il mio commercio.
Dissi poi che, per fare quei calcoli, avevo avuto bisogno di molto tempo e che perciò m’ero astenuto dal far visita ai Malfenti per cinque giorni. Finalmente la lingua abbandonata a se stessa era arrivata ad un po’ di sincerità. Ero vicino al pianto e, premendomi l’anca, mormorai:
– Cinque giorni son lunghi!
Guido disse che si compiaceva di scoprire in me una persona tanto previdente.
Io osservai seccamente:
– La persona previdente non è più gradevole della stordita!
Guido rise:
– Curioso che il previdente senta il bisogno di difendere lo stordito!
Poi, senz’altra transizione, mi raccontò seccamente ch’egli era in procinto di domandare la mano di Ada. M’aveva trascinato al caffè per farmi quella confessione oppure s’era seccato di aver dovuto starmi a sentire per tanto tempo a parlare di me e si procurava la rivincita?
Io sono quasi sicuro d’esser riuscito a dimostrare la massima sorpresa e la massima compiacenza. Ma subito dopo trovai il modo di addentarlo vigorosamente:
– Adesso capisco perché ad Ada piacque tanto quel Bach svisato a quel modo! Era ben suonato, ma gli Otto proibiscono di lordare in certi posti.
La botta era forte e Guido arrossì dal dolore. Fu mite nella risposta perché ora gli mancava l’appoggio di tutto il suo piccolo pubblico entusiasta.
– Dio mio! – cominciò per guadagnar tempo. – Talvolta suonando si cede ad un capriccio. In quella stanza pochi conoscevano il Bach ed io lo presentai loro un poco modernizzato.
Parve soddisfatto della sua trovata, ma io ne fui soddisfatto altrettanto perché mi parve una scusa e una sommissione. Ciò bastò a mitigarmi e, del resto, per nulla al mondo avrei voluto litigare col futuro marito di Ada. Proclamai che raramente avevo sentito un dilettante che suonasse così bene.
A lui non bastò: osservò ch’egli poteva essere considerato quale un dilettante, solo perché non accettava di presentarsi come professionista.
Non voleva altro? Gli diedi ragione. Era evidente ch’egli non poteva essere considerato quale un dilettante.
Così fummo di nuovo buoni amici.
Poi, di punto in bianco, egli si mise a dir male delle donne. Restai a bocca aperta! Ora che lo conosco meglio, so ch’egli si lancia a un discorrere abbondante in qualsiasi direzione quando si crede sicuro di piacere al suo interlocutore. Io, poco prima, avevo parlato del lusso delle signorine Malfenti, ed egli ricominciò a parlare di quello per finire col dire di tutte le altre cattive qualità delle donne. La mia stanchezza m’impediva d’interromperlo e mi limitavo a continui segni d’assenso ch’erano già troppo faticosi per me. Altrimenti, certo, avrei protestato. Io sapevo ch’io avevo ogni ragione di dir male delle donne rappresentate per me da Ada, Augusta e dalla mia futura suocera; ma lui non aveva alcuna ragione di prendersela col sesso rappresentato per lui dalla sola Ada che l’amava.
Era ben dotto, e ad onta della mia stanchezza stetti a sentirlo con ammirazione. Molto tempo dopo scopersi ch’egli aveva fatte sue le geniali teorie del giovine suicida Weininger. Per allora subivo il peso di un secondo Bach. Mi venne persino il dubbio ch’egli volesse curarmi. Perché altrimenti avrebbe voluto convincermi che la donna non sa essere né geniale né buona? A me parve che la cura non riuscì perché somministrata da Guido. Ma conservai quelle teorie e le perfezionai con la lettura del Weininger. Non guariscono però mai, ma sono una comoda compagnia quando si corre dietro alle donne.
Finito il suo gelato, Guido sentì il bisogno di una boccata d’aria fresca e m’indusse ad accompagnarlo ad una passeggiata verso la periferia della città.
Ricordo: da giorni, in città, si anelava ad un poco di pioggia da cui si sperava qualche sollievo al caldo anticipato. Io non m’ero neppure accorto di quel caldo. Quella sera il cielo aveva cominciato a coprirsi di leggere nubi bianche, di quelle da cui il popolo spera la pioggia abbondante, ma una grande luna s’avanzava nel cielo intensamente azzurro dov’era ancora limpido, una di quelle lune dalle guancie gonfie che lo stesso popolo crede capaci di mangiare le nubi. Era infatti evidente che là dov’essa toccava, scioglieva e nettava.
Volli interrompere il chiacchierio di Guido che mi costringeva ad un annuire continuo, una tortura, e gli descrissi il bacio nella luna scoperto dal poeta Zamboni: com’era dolce quel bacio nel centro delle nostre notti in confronto all’ingiustizia che Guido accanto a me commetteva! Parlando e scotendomi dal torpore in cui ero caduto a forza di assentire, mi parve che il mio dolore s’attenuasse. Era il premio per la mia ribellione e vi insistetti.
Guido dovette adattarsi di lasciare per un momento in pace le donne e guardare in alto. Ma per poco! Scoperta, in seguito alle mie indicazioni, la pallida immagine di donna nella luna, ritornò al suo argomento con uno scherzo di cui rise fortemente, ma solo lui, nella via deserta:
– Vede tante cose quella donna! Peccato ch’essendo donna non sa ricordarle.
Faceva parte della sua teoria (o di quella del Weininger) che la donna non può essere geniale perché non sa ricordare.
Arrivammo sotto la via Belvedere. Guido disse che un po’ di salita ci avrebbe fatto bene. Anche questa volta lo compiacqui. Lassù, con uno di quei movimenti che si confanno meglio ai giovanissimi ragazzi, egli si sdraiò sul muricciuolo che arginava la via da quella sottostante. Gli pareva di fare un atto di coraggio esponendosi ad una caduta di una diecina di metri. Sentii dapprima il solito ribrezzo al vederlo esposto a tanto pericolo, ma poi ricordai il sistema da me escogitato quella sera stessa, in uno slancio d’improvvisazione, per liberarmi da quell’affanno e mi misi ad augurare ferventemente ch’egli cadesse.
In quella posizione egli continuava a predicare contro le donne. Diceva ora che abbisognavano di giocattoli come i bambini, ma di alto prezzo. Ricordai che Ada diceva di amare molto i gioielli. Era dunque proprio di lei ch’egli parlava? Ebbi allora un’idea spaventosa! Perché non avrei fatto fare a Guido quel salto di dieci metri? Non sarebbe stato giusto di sopprimere costui che mi portava via Ada senz’amarla? In quel momento mi pareva che quando l’avessi ucciso, avrei potuto correre da Ada per averne subito il premio. Nella strana notte piena di luce, a me era parso ch’essa stesse a sentire come Guido l’infamava.
Debbo confessare ch’io in quel momento m’accinsi veramente ad uccidere Guido! Ero in piedi accanto a lui ch’era sdraiato sul basso muricciuolo ed esaminai freddamente come avrei dovuto afferrarlo per essere sicuro del fatto mio. Poi scopersi che non avevo neppur bisogno di afferrarlo. Egli giaceva sulle proprie braccia incrociate dietro la testa, e sarebbe bastata una buona spinta improvvisa per metterlo senza rimedio fuori d’equilibrio.
Mi venne un’altra idea che mi parve tanto importante da poter compararla alla grande luna che s’avanzava nel cielo nettandolo: avevo accettato di fidanzarmi ad Augusta per essere sicuro di dormir bene quella notte. Come avrei potuto dormire se avessi ammazzato Guido? Quest’idea salvò me e lui. Volli subito abbandonare quella posizione nella quale sovrastavo a Guido e che mi seduceva a quell’azione. Mi piegai sulle ginocchia abbattendomi su me stesso e arrivando quasi a toccare il suolo con la mia testa:
– Che dolore, che dolore! – urlai.
Spaventato, Guido balzò in piedi a domandarmi delle spiegazioni. Io continuai a lamentarmi più mitemente senza rispondere. Sapevo perché mi lamentavo: perché avevo voluto uccidere e forse, anche, perché non avevo saputo farlo. Il dolore e il lamento scusavano tutto. Mi pareva di gridare ch’io non avevo voluto uccidere e mi pareva anche di gridare che non era colpa mia se non avevo saputo farlo. Tutto era colpa della mia malattia e del mio dolore. Invece ricordo benissimo che proprio allora il mio dolore scomparve del tutto e che il mio lamento rimase una pura commedia cui io invano cercai di dare un contenuto evocando il dolore e ricostruendolo per sentirlo e soffrirne. Ma fu uno sforzo vano perché esso non ritornò che quando volle.
Come al solito Guido procedeva per ipotesi. Fra altro mi domandò se non si fosse trattato dello stesso dolore prodotto da quella caduta al caffè. L’idea mi parve buona e assentii.
Egli mi prese per il braccio e, amorevolmente, mi fece rizzare. Poi, con ogni riguardo, sempre appoggiandomi, mi fece scendere la piccola erta. Quando fummo giù, dichiarai che mi sentivo un poco meglio e che credevo che, appoggiato a lui, avrei potuto procedere più spedito. Così si andava finalmente a letto! Poi era la prima vera grande soddisfazione che quel giorno mi fosse stata accordata. Egli lavorava per me, perché quasi mi portava. Ero io che finalmente gl’imponevo il mio volere.
Trovammo una farmacia ancora aperta ed egli ebbe l’idea di mandarmi a letto accompagnato da un calmante. Costruì tutta una teoria sul dolore reale e sul sentimento esagerato dello stesso: un dolore si moltiplicava per l’esasperazione ch’esso stesso aveva prodotta. Con quella bottiglietta s’iniziò la mia raccolta di medicinali, e fu giusto fosse stata scelta da Guido.
Per dar base più solida alla sua teoria, egli suppose ch’io avessi sofferto di quel dolore da molti giorni. Mi spiacque di non poter compiacerlo. Dichiarai che quella sera, in casa dei Malfenti, io non avevo sentito alcun dolore. Nel momento in cui m’era stata concessa la realizzazione del mio lungo sogno, evidentemente non avevo potuto soffrire.
E per essere sincero volli proprio essere come avevo asserito ch’io fossi e dissi più volte a me stesso: «Io amo Augusta, io non amo Ada. Amo Augusta e questa sera arrivai alla realizzazione del mio lungo sogno».
Così procedemmo nella notte lunare. Suppongo che Guido fosse affaticato dal mio peso, perché finalmente ammutolì. Mi propose però di accompagnarmi fino a letto. Rifiutai e quando mi fu concesso di chiudere la porta di casa dietro di me, diedi un sospiro di sollievo. Ma certamente anche Guido dovette emettere lo stesso sospiro.
Feci gli scalini della mia villa a quattro a quattro e in dieci minuti fui a letto. M’addormentai presto e, nel breve periodo che precede il sonno, non ricordai né Ada né Augusta, ma il solo Guido, così dolce e buono e paziente. Certo, non avevo dimenticato che poco prima avevo voluto ucciderlo, ma ciò non aveva alcun’importanza perché le cose di cui nessuno sa e che non lasciarono delle tracce, non esistono.
Il giorno seguente mi recai alla casa della mia sposa un po’ titubante. Non ero sicuro se gl’impegni presi la sera prima avessero il valore ch’io credevo di dover conferire loro. Scopersi che l’avevano per tutti. Anche Augusta riteneva d’essersi fidanzata, anzi più sicuramente di quanto lo credessi io.
Fu un fidanzamento laborioso. Io ho il senso di averlo annullato varie volte e ricostituito con grande fatica e sono sorpreso che nessuno se ne sia accorto. Mai non ebbi la certezza d’avviarmi proprio al matrimonio, ma pare che tuttavia io mi sia comportato da fidanzato abbastanza amoroso. Infatti io baciavo e stringevo al seno la sorella di Ada ogni qualvolta ne avevo la possibilità. Augusta subiva le mie aggressioni come credeva che una sposa dovesse ed io mi comportai relativamente bene, solo perché la signora Malfenti non ci lasciò soli che per brevi istanti. La mia sposa era molto meno brutta di quanto avessi creduto, e la sua più grande bellezza la scopersi baciandola: il suo rossore! Là dove baciavo sorgeva una fiamma in mio onore ed io baciavo più con la curiosità dello sperimentatore che col fervore dell’amante.
Ma il desiderio non mancò e rese un po’ più lieve quella grave epoca. Guai se Augusta e sua madre non m’avessero impedito di bruciare quella fiamma in una sola volta come io spesso ne avrei avuto il desiderio. Come si avrebbe continuato a vivere allora? Almeno così il mio desiderio continuò a darmi sulle scale di quella casa la stessa ansia come quando le salivo per andare alla conquista di Ada. Gli scalini dispari mi promettevano che quel giorno avrei potuto far vedere ad Augusta che cosa fosse il fidanzamento ch’essa aveva voluto. Sognavo un’azione violenta che m’avrebbe ridato tutto il sentimento della mia libertà. Non volevo mica altro io ed è ben strano che quando Augusta intese quello ch’io volevo, l’abbia interpretato quale un segno di febbre d’amore.
Nel mio ricordo quel periodo si divide in due fasi. Nella prima la signora Malfenti ci faceva spesso sorvegliare da Alberta o cacciava nel salotto con noi la piccola Anna con una sua maestrina. Ada non fu allora mai associata in alcun modo a noi ed io dicevo a me stesso che dovevo compiacermene, mentre invece ricordo oscuramente di aver pensato una volta che sarebbe stata una bella soddisfazione per me di poter baciare Augusta in presenza di Ada. Chissà con quale violenza l’avrei fatto.
La seconda fase s’iniziò quando Guido ufficialmente si fidanzò con Ada e la signora Malfenti da quella pratica donna che era, unì le due coppie nello stesso salotto perché si sorvegliassero a vicenda.
Della prima fase so che Augusta si diceva perfettamente soddisfatta di me. Quando non l’assaltavo, divenivo di una loquacità straordinaria. La loquacità era un mio bisogno. Me ne procurai l’opportunità figgendomi in capo l’idea che giacché dovevo sposare Augusta, dovessi anche imprenderne l’educazione. L’educavo alla dolcezza, all’affetto e sopra tutto alla fedeltà. Non ricordo esattamente la forma che davo alle mie prediche di cui taluna m’è ricordata da lei che giammai le obliò. M’ascoltava attenta e sommessa. Io, una volta, nella foga dell’insegnamento, proclamai che se essa avesse scoperto un mio tradimento, ne sarebbe conseguito il suo diritto di ripagarmi della stessa moneta. Essa, indignata, protestò che neppure col mio permesso avrebbe saputo tradirmi e che, da un mio tradimento, a lei non sarebbe risultata che la libertà di piangere.
Io credo che tali prediche fatte per tutt’altro scopo che di dire qualche cosa, abbiano avuta una benefica influenza sul mio matrimonio. Di sincero v’era l’effetto ch’esse ebbero sull’animo di Augusta. La sua fedeltà non fu mai messa a prova perché dei miei tradimenti essa mai seppe nulla, ma il suo affetto e la sua dolcezza restarono inalterati nei lunghi anni che passammo insieme, proprio come l’avevo indotta a promettermelo.
Quando Guido si promise, la seconda fase del mio fidanzamento s’iniziò con un mio proponimento che fu espresso così: «Eccomi ben guarito del mio amore per Ada!» Fino ad allora avevo creduto che il rossore di Augusta fosse bastato per guarirmi, ma si vede che non si è mai guariti abbastanza! Il ricordo di quel rossore mi fece pensare ch’esso oramai ci sarebbe stato anche fra Guido e Ada. Questo, molto meglio di quell’altro, doveva abolire ogni mio desiderio.
È della prima fase il desiderio di violare Augusta. Nella seconda fui molto meno eccitato. La signora Malfenti non aveva certo sbagliato organizzando così la nostra sorveglianza con tanto piccolo suo disturbo.
Mi ricordo che una volta scherzando mi misi a baciare Augusta. Invece di scherzare con me, Guido si mise a sua volta a baciare Ada. Mi parve poco delicato da parte sua, perché egli non baciava castamente come avevo fatto io per riguardo a loro, ma baciava Ada proprio nella bocca che addirittura suggeva. Sono certo che in quell’epoca io m’ero già assueffatto a considerare Ada quale una sorella, ma non ero preparato a vederne far uso a quel modo. Dubito anche che ad un vero fratello piacerebbe di veder manipolare così la sorella.
Perciò, in presenza di Guido, io non baciai mai più Augusta. Invece Guido, in mia presenza, tentò un’altra volta di attirare a sé Ada, ma fu dessa che se ne schermì ed egli non ripeté più il tentativo.
Molto confusamente mi ricordo delle tante e tante sere che passammo insieme. La scena che si ripeté all’infinito, s’impresse nella mia mente così: tutt’e quattro eravamo seduti intorno al fine tavolo veneziano su cui ardeva una grande lampada a petrolio coperta da uno schermo di stoffa verde che metteva tutto nell’ombra, meno i lavori di ricamo cui le due fanciulle attendevano, Ada su un fazzoletto di seta che teneva libero in mano, Augusta su un piccolo telaio rotondo. Vedo Guido perorare e dev’essere successo di spesso che sia stato io solo a dargli ragione. Mi ricordo ancora della testa di capelli neri lievemente ricciuti di Ada, rilevati da un effetto strano che vi produceva la luce gialla e verde.
Si discusse di quella luce e anche del colore vero di quei capelli. Guido, che sapeva anche dipingere, ci spiegò come si dovesse analizzare un colore. Neppure questo suo insegnamento non dimenticai più e ancora oggidì, quando voglio intendere meglio il colore di un paesaggio, socchiudo gli occhi finché non spariscano molte linee e non si vedano che le sole luci che anch’esse s’abbrunano nel solo e vero colore. Però, quando mi dedico ad un’analisi simile, sulla mia retina, subito dopo le immagini reali, quasi una reazione mia fisica, riappare la luce gialla e verde e i capelli bruni sui quali per la prima volta educai il mio occhio.
Non so dimenticare una sera che fra tutte fu rilevata da un’espressione di gelosia di Augusta e subito dopo anche da una mia riprovevole indiscrezione. Per farci uno scherzo, Guido e Ada erano andati a sedere lontano da noi, dall’altra parte del salotto, al tavolo Luigi XIV. Così io ebbi presto un dolore al collo che torcevo per parlare con loro. Augusta mi disse:
– Lasciali! Là si fa veramente all’amore.
Ed io, con una grande inerzia di pensiero, le dissi a bassa voce che non doveva crederlo perché Guido non amava le donne. Così m’era sembrato di scusarmi di essermi ingerito nei discorsi dei due amanti. Era invece una malvagia indiscrezione quella di riferire ad Augusta i discorsi sulle donne cui Guido s’abbandonava in mia compagnia, ma giammai in presenza di alcun altro della famiglia delle nostre spose. Il ricordo di quelle mie parole m’amareggiò per varii giorni, mentre posso dire che il ricordo di aver voluto uccidere Guido non m’aveva turbato neppure per un’ora. Ma uccidere e sia pure a tradimento, è cosa più virile che danneggiare un amico riferendo una sua confidenza.
Già allora Augusta aveva torto di essere gelosa di Ada. Non era per vedere Ada ch’io a quel modo torcevo il mio collo. Guido, con la sua loquacità, m’aiutava a trascorrere quel lungo tempo. Io gli volevo già bene e passavo una parte delle mie giornate con lui. Ero legato a lui anche dalla gratitudine che gli portavo per la considerazione in cui egli mi teneva e che comunicava agli altri. Persino Ada stava ora a sentirmi attentamente quando parlavo.
Ogni sera aspettavo con una certa impazienza il suono del gong che ci chiamava a cena, e di quelle cene ricordo principalmente la mia perenne indigestione. Mangiavo troppo per un bisogno di tenermi attivo. A cena abbondavo di parole affettuose per Augusta; proprio quanto la mia bocca piena me lo permetteva, e i genitori suoi potevano aver solo la brutta impressione che il grande mio affetto fosse diminuito dalla mia bestiale voracità. Si sorpresero che al mio ritorno dal viaggio di nozze non avessi riportato con me tanto appetito. Sparì quando non si esigette più da me di dimostrare una passione che non sentivo. Non è permesso di farsi veder freddo con la sposa dai suoi genitori nel momento in cui ci si accinge di andar a letto con essa! Augusta ricorda specialmente le affettuose parole che le mormoravo a quel tavolo. Fra boccone e boccone devo averne inventate di magnifiche e resto stupito, quando mi vengono ricordate, perché non mi sembrerebbero mie.
Lo stesso mio suocero, Giovanni il furbo, si lasciò ingannare e, finché visse, quando voleva dare un esempio di una grande passione amorosa, citava la mia per sua figlia, cioè per Augusta. Ne sorrideva beato da quel buon padre ch’egli era, ma gliene derivava un aumento di disprezzo per me, perché secondo lui, non era un vero uomo colui che metteva tutto il proprio destino nelle mani di una donna e che sopra tutto non s’accorgeva che all’infuori della propria v’erano a questo mondo anche delle altre donne. Da ciò si vede che non sempre fui giudicato con giustizia.
Mia suocera, invece, non credette nel mio amore neppure quando la stessa Augusta vi si adagiò piena di fiducia.
Per lunghi anni essa mi squadrò con occhio diffidente, dubbiosa del destino della figliuola sua prediletta. Anche per questa ragione io sono convinto ch’essa deve avermi guidato nei giorni che mi condussero al fidanzamento. Era impossibile d’ingannare anche lei che deve aver conosciuto il mio animo meglio di me stesso.
Venne finalmente il giorno del mio matrimonio e proprio quel giorno ebbi un’ultima esitazione. Avrei dovuto essere dalla sposa alle otto del mattino, e invece alle sette e tre quarti mi trovavo ancora a letto fumando rabbiosamente e guardando la mia finestra su cui brillava, irridendo, il primo sole che durante quell’inverno fosse apparso. Meditavo di abbandonare Augusta! Diveniva evidente l’assurdità del mio matrimonio ora che non m’importava più di restar attaccato ad Ada. Non sarebbero mica avvenute di grandi cose se io non mi fossi presentato all’appuntamento! Eppoi: Augusta era stata una sposa amabile, ma non si poteva mica sapere come si sarebbe comportata la dimane delle nozze. E se subito m’avesse dato della bestia perché m’ero lasciato prendere a quel modo?
Per fortuna venne Guido, ed io, nonché resistere, mi scusai del mio ritardo asserendo di aver creduto che fosse stata stabilita un’altra ora per le nozze. Invece di rimproverarmi, Guido si mise a raccontare di sé e delle tante volte ch’egli, per distrazione, aveva mancato a degli appuntamenti. Anche in fatto di distrazione egli voleva essere superiore a me e dovetti non dargli altro ascolto per arrivare a uscir di casa. Così avvenne che andai al matrimonio a passo di corsa.
Arrivai tuttavia molto tardi. Nessuno mi rimproverò e tutti meno la sposa s’accontentarono di certe spiegazioni che Guido diede in vece mia. Augusta era tanto pallida che persino le sue labbra erano livide. Se anche non potevo dire di amarla, pure è certo che non avrei voluto farle del male. Tentai di riparare e commisi la bestialità d’attribuire al mio ritardo ben tre cause. Erano troppe e raccontavano con tanta chiarezza quello ch’io avevo meditato là nel mio letto, guardando il sole invernale, che si dovette ritardare la nostra partenza per la chiesa onde dar tempo ad Augusta di rimettersi.
All’altare dissi di sì distrattamente perché nella mia viva compassione per Augusta stavo escogitando una quarta spiegazione al mio ritardo e mi pareva la migliore di tutte.
Invece, quando uscimmo dalla chiesa, m’accorsi che Augusta aveva ricuperati tutti i suoi colori. Ne ebbi una certa stizza perché quel mio sì non avrebbe mica dovuto bastare a rassicurarla del mio amore. E mi preparavo a trattarla molto rudemente se si fosse rimessa da tanto da darmi della bestia perché m’ero lasciato prendere a quel modo. Invece, a casa sua, approfittò di un momento in cui ci lasciarono soli, per dirmi piangendo:
– Non dimenticherò mai che, pur non amandomi, mi sposasti.
Io non protestai perché la cosa era stata tanto evidente che non si poteva. Ma, pieno di compassione, l’abbracciai.
Poi di tutto questo non si parlò più fra me ed Augusta perché il matrimonio è una cosa ben più semplice del fidanzamento. Una volta sposati non si discute più d’amore e, quando si sente il bisogno di dirne, l’animalità interviene presto a rifare il silenzio. Ora tale animalità può essere divenuta tanto umana da complicarsi e falsificarsi ed avviene che, chinandosi su una capigliatura femminile, si faccia anche lo sforzo di evocarvi una luce che non c’è. Si chiudono gli occhi e la donna diventa un’altra per ridivenire lei quando la si abbandona. A lei s’indirizza tutta la gratitudine e maggiore ancora se lo sforzo riuscì. È per questo che se io avessi da nascere un’altra volta (madre natura è capace di tutto!) accetterei di sposare Augusta, ma mai di promettermi con lei.
Alla stazione Ada mi porse la guancia al bacio fraterno. Io la vidi solo allora, frastornato com’ero dalla tanta gente ch’era venuta ad accompagnarci e subito pensai: «Sei proprio tu che mi cacciasti in questi panni!» Avvicinai le mie labbra alla sua guancia vellutata badando di non sfiorarla neppure. Fu la prima soddisfazione di quel giorno, perché per un istante sentii quale vantaggio mi derivasse dal mio matrimonio: m’ero vendicato rifiutando d’approfittare dell’unica occasione che m’era stata offerta di baciare Ada! Poi, mentre il treno correva, seduto accanto ad Augusta, dubitai di non aver fatto bene. Temevo ne fosse compromessa la mia amicizia con Guido. Però soffrivo di più quando pensavo che forse Ada non s’era neppure accorta che non avevo baciata la guancia che mi aveva offerta.
Essa se ne era accorta, ma io non lo seppi che quando, a sua volta, molti mesi dopo, partì con Guido da quella stessa stazione. Tutti essa baciò. A me solo offerse con grande cordialità la mano. Io gliela strinsi freddamente. La sua vendetta arrivava proprio in ritardo perché le circostanze erano del tutto mutate. Dal ritorno dal mio viaggio di nozze avevamo avuti dei rapporti fraterni e non si poteva spiegare perché mi avesse escluso dal bacio.