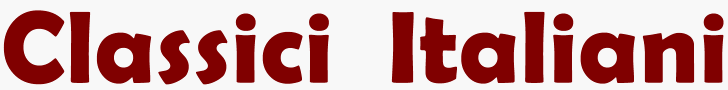Giacomo Leopardi.
Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica.
Capitolo IV.
Note
Diritti d’Autore: no
Edizione di riferimento
Giacomo Leopardi, Poesie e prose, vol. secondo, a cura di Rolando Damiani, Arnoldo Mondadori editore, collana I Meridiani, Milano 1988.

IV.
Ora non metterò a confronto la delicatezza la tenerezza la soavità del sentimentale antico e nostro, colla ferocia colla barbarie colla bestialità di quello dei romantici propri. Certamente la morte di una donna amata è un soggetto patetico in guisa ch’io stimo che se un poeta, colto da questa sciagura, e cantandola, non fa piangere, gli convenga disperare di poter mai commuovere i cuori. Ma perchè l’amore dev’essere incestuoso? perchè la donna trucidata? perchè l’amante una cima di scellerato, e per ogni parte mostruosissimo? Troppe parole si potrebbero spendere intorno a questo argomento, stante che l’orridezza è l’uno dei caratteri più cospicui del sentimentale romantico; ma quanto più cose ci sarebbero da dire, tanto più volentieri le tralascio; e sia pur gloria dei romantici, come gridano, l’esser più dilettati dalla sensibilità dei demonii che degli uomini, e vituperio nostro l’avere tanto o quanto di contraggenio alle bellezze infernali. Ma quel ridurre pressochè tutta la poesia ch’è imitatrice della natura, al sentimentale, come se la natura non si potesse imitare altrimenti che in maniera patetica; come se tutte le cose rispetto agli animi nostri fossero sempre patetiche; come se il poeta non fosse più spinto a poetare da nessuna cosa, eccetto la sensibilità, o per lo meno senza questa; come se non ci fosse più gioia non ira non passione quasi veruna, non leggiadria nè dolcezza nè forza nè dignità nè sublimità di pensieri, non ritrovato nè operazione veruna immaginativa senza un colore di malinconico; questa cosa con che nome si deve chiamare? Dunque le cetre dei poeti avranno per l’avvenire una corda sola? e ciaschedun poema assolutamente e tutti rispettivamente saranno unisoni? dunque non ci saranno epopee, non canzoni trionfali, non inni non odi non canti di nessuna sorta se non patetici? non parlo del quanto è da stimare che accresceremo il diletto della poesia, togliendole tanta parte di quella varietà senza la quale, si può dir tutte le cose di questo mondo, non che la poesia, vengono in fastidio così per poco. Ma che diremo dei cantori passati? Dunque Virgilio non fu poeta fuorchè nel quarto dell’Eneide, e nell’episodio di Niso ed Eurialo, e che so io? Dunque il Petrarca dove non parlò d’amore non fu poeta? dunque Pindaro, perchè non fu sentimentale, non fu poeta? dunque Omero non fu poeta? o vero fu (come parve a molti che fosse), ma non è più? o vero è poeta e sarà, e diletta e diletterà supremamente, ma nessun poeta moderno dee cantare in quella forma? Ora come sarà disdetto ai poeti il cantare nella forma di Omero e di Pindaro e in breve degli antichi, finattantochè gli antichi diletteranno? e questo ineffabilmente? Ma non voglio parere anch’io quello che paiono i romantici, mettendomi di proposito a confutare queste fandonie.
E non altrimenti io credo che gitterei le parole e il tempo se volessi ricordare la sazievolezza e la stanchezza massimamente del terribile e di tutti gli altri caratteri gagliardi oltre al consueto (peggio poi quando sieno eccessivi, come appresso i romantici), dei quali non si può far uso più che tanto lungo e frequente senza una singolare ignoranza delle cose dell’animo nostro, nè senza interminabile o riso o stupore o compassione della gente savia quando altri per soprappiù si dia vanto di psicologo eccellentissimo; se volessi notare la fatica e lo sforzo dei romantici per durarla sempre con quella veemenza sterminata, che ha per natura di essere in quasi tutte le cose ordinariamente poco durevole, il quale sforzo, e vengo a dire l’affettazione è così manifesta, che ci bisogna un cieco o un romantico a non vederla; se volessi domandare ai nuovi poeti come dalla psicologia non abbiano imparato ad apprezzare specialissimamente, e conservare con ogni studio la moderazione, non solamente in quelle che ho detto, ma in tutte le altre cose appartenenti alla poesia (giacchè adesso non ci conviene parlare fuorchè di queste), non la necessità di scelta avveduta e di mescolanza opportuna, non quelle tante verità ch’essendo certe e sperimentate, e la cognizione loro derivando o più tosto essendo contenuta nella cognizione dell’animo umano, e avendole notate e ripetute mille volte quell’arte poetica frivolissima e antica, è maraviglioso che le ignori la scienza psicologica divina e moderna; se volessi chiedere al mondo come abbia potuto nascere in questi tempi chi dimenticasse quella verità originaria e fondamentale, che nelle arti belle si richiede la convenienza, vale a dire che nessuna cosa stia fuori di luogo, la qual verità si para spontaneamente innanzi a chiunque considera tanto o quanto la natura o di esse arti o degli uomini o delle cose, nè si può disprezzare senza che qualsivoglia arte diventi inetta a produrre altro che mostri, come in un viso piccolo un naso grande, come in un edifizio svelto un ornato greve, come in qualunque sia cosa la sconvenienza cagiona la bruttezza, o più veramente la bruttezza assoluta non è altro che sconvenienza. Di queste cose perchè danno singolarmente nell’occhio, ha parlato o parla qualunque ha contraddetto o contraddice ai romantici, di modo ch’io poco o niente di nuovo ne potrei dire; come anche di quella mirabile e prodigiosa contraddizione, di negare che le credenze e i costumi antichi si convengano alla poesia moderna, e accogliere e cercare e rappresentare con sommo affetto le credenze e i costumi settentrionali orientali americani. Forsechè questi hanno molto che fare coi nostri? convengono molto col sapere odierno d’Europa? e non più tosto in grandissima parte assai meno che quelli de’ greci e de’ latini? E se cercano cose remote e diverse dalle nostrali a cagione del maraviglioso e del venerando, perchè dunque rigettano le cose greche e le latine? forsech’il venerando e il maraviglioso non può essere altro che barbaro? anzi come ponno esser venerande le cose di coloro che si disprezzano? e qual gente è più disprezzata che le barbare? massime di una barbarie come quella, per esempio, de’ popoli maomettani. Perchè, a dimostrare aspetti grandi, e rappresentare azioni nobili, va introdotto più tosto un Agà che un tribuno, più tosto un Pechinese che un Lacedemone, più tosto un ceffo che un volto? Ma lascio questo. Dunque tutto il male sta nel tempo, in maniera che quando la lontananza di luogo, con tutta la diversità di costumi e di opinioni che porta seco, non fa danno anzi giova, la lontananza di tempo è intollerabile e micidiale? Ora come succede che noi, leggendo i poeti, e non solamente i poeti ma eziandio gli storici e gli altri tali, siamo così facili a entrare a parte e frammetterci negli avvenimenti e nelle cose greche e romane di venti o più secoli addietro, e così difficili in quelle comunque freschissime o presenti, poniamo caso, del Tibet o della Nubia o degli irocchesi o degli afgani o anche di gente più nota e famosa? in prova di che, lasciando le molte ragioni che si potrebbero addurre, basti allegare l’esperienza universale. Che dirò delle favole barbare sostituite dai nostri riformatori in luogo delle greche? Niente, perch’è materia divulgatissima, e tocca, si può dire, da chiunque sparla dei romantici; se non che mi rallegrerò prima col nostro secolo, il quale tra il greco e il barbaro non dubito che non abbia fatto un bel cambio, poi co’ nemici della pedanteria, che non debbono trovar luogo dall’allegrezza, vedendo ch’i poeti oramai non si potranno intendere senza postille e comenti. Imperocchè le favole greche in europa si sanno a memoria da chicchessia: bene o male, convenga o disdica all’età nostra, piaccia o non piaccia ai romantici, il fatto sta così; e quando il poeta europeo si serve di esse favole, e usa quell’idioma favoloso, o anche se n’abusa, eccetto se l’abuso non fosse enorme, è inteso da tutti coloro fra’ quali ed a’ quali canta: ma le favole settentrionali orientali americane quanti le sanno o se ne curano? talmente ch’è forza o ch’i poeti nostri stando in europa, non cantino all’europa, ma più tosto all’asia all’affrica all’america, e, facciamo che debbano essere intesi adoperando le favelle europee, ci bisognerà un bel vocione a volere che sieno uditi; o si lavorino a posta un’altra europa bene istrutta di quelle favole onde questa nostra si beffa e non le n’importa un’acca; o finalmente ch’i poemi si trascinino dietro le loro note e le loro chiose, e questo senza fallo ammazzerà la pedanteria, giacchè sapete bene che un comento lastricato, per esempio, di pezzi dell’Edda maggiore o minore, o dell’Alcorano o di Ferdosi o dei Purana o del Ramaiuna o del Mega duta, non sarebbe mica pedantesco, ma seminato di versi d’Omero o di Virgilio o di Dante, sì bene, perchè la pedanteria sta essenzialmente e immobilmente fitta e radicata nelle cose greche e latine e italiane. E questo che ho detto delle favole, s’intenda parimente delle opinioni e delle usanze. Già non fa di mestieri non dico notare ma nè anche ricordare quella famosissima contraddizione dei romantici che riguarda le favole, essendoch’ella non può sdrucciolare dalla memoria degli uomini, se prima il tempo non abolisce ogni qualsivoglia ricordanza di questa setta. Certo ch’il rifiutare e deridere e bestemmiare le favole greche, negando ch’il sapere dell’età presente conceda spazio nelle menti nostre alle illusioni favolose, e intanto così facendo, pescar l’oriente e il settentrione e qualunque paese barbaro è illuminato dal sole, e far materia sostanzialissima di poesia le favole loro, in grandissima parte mostruosissime e ridicolissime, tutte oltremodo ripugnanti alle credenze nostre, tutte disprezzate, perch’essendo vanità per se stesse, niuna cosa estrinseca le fa venerande, non l’averle noi studiate e venerate da fanciulli, non memoria degli avi nostri, non pregio nè fama insigne nè uso frequente appresso noi di scrittori che le abbiano adoperate, o in altra maniera segnalate, non gloria nè dignità delle nazioni che le inventarono, o accolsero e coltivarono, le quali anzi essendo barbare e tali che ciascuno di noi si vergognerebbe se avesse per madre qualunque tra loro è più nobile, s’anche hanno qualche cosa pregevole, siamo inclinati a disprezzarla, e senz’alcun dubbio non sogliamo curarla gran fatto; certo che quest’è una contraddizione così formale e sfacciata, ch’è impossibile a nasconderla, impossibile a colorarla, e non voglio dire i fanciulli, ma credo che le bestie, purchè potessero intendere qualcheduno dei linguaggi umani, arriverebbero facilmente a conoscerla. Ora che dobbiamo stimare di quella disciplina dove troviamo ripugnanze di questa sorta? vale a dire e palpabili e capitali? quando colui che contraddice a se medesimo, tanto sta peggio di colui che dice il falso, quanto costui può esser convinto, quegli si convince di propria bocca; e il detto di costui può cadere per mano d’altri, quello senza nessuno impulso rovina da per se stesso; e questo anche svolto e messo in luce, può nondimeno aver sembianza di vero, quello, sol tanto che le sue parti sieno poste in chiaro e confrontate insieme, non può. E tuttavia la disciplina romantica ha seguaci e difensori e predicatori, e spazia per l’alemagna e l’inghilterra e assalisce l’italia nostra, tanto ch’io mi maraviglio veramente, o Lettori, di questo secolo.
Ma poichè m’è venuta fatta menzione delle favole greche, noterò con poche parole una svista rilevantissima del Cavaliere intorno a esse favole, dalla quale nuovamente potremo intendere quanta parte della scienza psicologica de’ nuovi settari consista nel gridare che ne son zeppi, e nel gergo scolastico e nelle tenebre. Imperocchè il Breme volendo mostrare la vanità poetica della mitologia (ponete mente ch’egli non dice mica la vanità filosofica o somigliante, ma poetica), e avendo detto che la natura è vita modificata in migliaia di guise, e che la poesia tanto più ama di credere o di fingere che dovunque è vita siavi parimenti coscienza e sentimento di un se stesso, quanto meno è dimostrato dalla ragione; e che l’attitudine poetica, ch’è nell’animo umano si compiacque mai sempre di questa fantasia; prosegue dicendo che nelle mitologie la natura veniva piuttosto convertita in individui che immediatamente avvivata; il qual sistema, se bene il primo concetto, da qualunque avvedimento sia proceduto, ne fu, anzichenò, immaginoso, nondimeno doveva sottrarre ogni dì più al sentimento e snaturare a poco per volta tutti gli oggetti, e impoverirci il cuore di elementi poetici: perocchè infrapponendo sempre persone fra noi e i fenomeni naturali, e fra noi e noi stessi, non solamente rendeva infine troppo uniforme l’artifizio poetico, ma lo spogliava della più miracolosa fra tutte le magie, quella cioè che attribuisce un senso ad ogni cosa, e riconosce vita sotto tutte le possibili forme, non esclusivamente sotto le umane. E così riprovando il sistema mitologico, e opponendogli il vitale, ch’è seguìto, dice, con predilezione dalla poesia moderna, vuole in sostanza che il poeta avvivi checchessia tal qual è, non trasmutandolo in persona umana; e che tutto senta e viva, non però tutto il mondo sia popolato di persone: e reca per esempio certi versi del Byron dove toccando una novella Persiana degli amori della rosa e dell’usignuolo, attribuisce alla rosa innamorata sospiri odoriferi. Della qual sentenza discorrerò brevemente.
È certo e manifestissimo e ingenito non solo ne’ poeti ma universalmente negli uomini, un desiderio molto efficace di vedere e toccare e aggirarsi tra cose vive, dal qual desiderio mossa la fantasia vivifica oggetti insensati, come vediamo, e come dice il Cavaliere nei passi riferiti di sopra, e io dirò poco stante. La natura di questo desiderio si può discernere considerando, a cagione d’esempio, gli effetti che fa negli animi nostri una pittura di paese, la quale s’è vota d’ogni figura d’animale, per molto che ci diletti a riguardarla, nondimeno sogliamo provare una certa scontentezza, e un desiderio maldistinto come di cosa che manchi; e la scontentezza è minore caso che ci si vegga rappresentata qualche statua, ma poco minore, perchè conoscendo che quella è imitazione di cosa non viva ma solamente ritratta, secondochè si finge, dal vivo, poca vita ci può trovare l’immaginazione. Molto più ci consola e ricrea, se ci occorre nessuna figura di bestia, che rompa la solitudine, e animi la veduta. Ma nè pur questa ci contenta, nè ci può contentare altro che figure umane, e queste tanto più quanto più sono accurate e notabili; che allora in esse quasi ci riposiamo, e per esse prendiamo più gusto delle altre parti del quadro, trovataci quella vita che desideriamo, benchè per l’ordinario senz’avvedercene. E questa è, non dico la principale, ma certo una delle cagioni per cui sono tanto più dilettose e pregiate le pitture e sculture di animali, e singolarmente di persone, che non di soli paesi o di qualsivoglia cosa inanimata. Ma vediamo in che forma soglia gratificare l’immaginativa nostra a questo desiderio ingenerato negli uomini, specialmente quand’ella essendo più libera, in modo che la sua forza è più manifesta, seconda meglio e più efficacemente la natura; io voglio dire nei fanciulli: nei quali in oltre sì come la podestà della natura universalmente è maggiore che nei provetti, così particolarmente di quel desiderio naturale ch’io dico; laonde le proprietà e gli effetti di questo risaltano meglio, e si possono esaminare più facilmente. E vi prego, o Lettori, che non vogliate credere ch’io dia nel leggero e nel fanciullesco, se anderò dietro a certe minuzie, perchè, s’io non fallo, indagando queste minuzie, perverremo in breve all’intento nostro, al quale forse anche non potremmo arrivare per altra strada. Quanto sia comune e trita usanza delle immaginative puerili il vivificare oggetti insensati, e non c’è quasi chi l’ignori, ed a me stesso è accaduto già di mentovarlo in questo Discorso. Ma bisogna considerare che vita sia quella che da esse immaginative si attribuisce a questi tali oggetti. Ora chiunque ci porrà mente, verrà subito in chiaro che nella immaginativa de’ putti il sole e la luna appresso a poco non sono altro che un uomo e una donna, e il tuono e il vento e il giorno e la notte e l’aurora e il tempo e le stagioni e i mesi e l’ozio e la morte e infinite cose d’ogni genere non sono altro che uomini o donne, e in somma i fanciulli non attribuiscono alle cose inanimate altri affetti altri pensieri altri sensi altra vita che umana, e quindi proccurano altresì di vestirle, ed effettivamente le vestono di forme umane il meglio che possono, quando più quando meno confusamente, secondo la facoltà immaginativa di ciascheduno, e le altre circostanze. Ed io mi ricordo ch’essendo piccino, costumava non solamente spassarmi ad avvivare, e guardare e mostrare altrui per maniera come se vivessero, ma eziandio cercare e trovare alcuni vestigi di sembianza umana, secondoch’allora mi pareano, evidenti, negli alberi ch’erano lungo le strade per cui mi menavano, e in altre cose tanto remote da ogni similitudine umana, ch’io stimo per certo d’avere a muovere il riso specificandone qualcheduna, come dire i caratteri dell’alfabeto, e seggiole e vaselli e altri arnesi di cento specie, e cose simili; nelle quali in oltre mi figurava di scorgere parecchie diversità di fisonomia, che riputandole argomento di buona o cattiva indole, m’erano poi motivo d’amar queste e d’odiar quelle. E tanto manifestamente si diletta la fantasia nostra in attribuire alle cose non vita semplicemente ma vita umana, che non appagandosi di qualunque non è tale, s’ingegna di trasmutarla in questa medesima nostra vita, come vediamo segnatamente nei fanciulli, che si fingono le bestie ragionevoli e intellettive, e discorrono e conversano seco loro non altrimenti che colle persone. Da tutte queste cose, che quantunque sieno più cospicue ne’ fanciulli, non per questo non appariscono almeno in parte anche nei provetti, secondo massimamente che resta all’immaginazione maggiore o minore imperio, da tutte queste, e da molte altre che si potrebbero dire, facilmente si raccoglie che quel desiderio naturale di vita del quale trattiamo, provenga da quella vastissima inclinazione che tutti abbiamo alle creature simili a noi, madre di svariatissimi effetti, e non sia veramente altro che un desiderio della presenza di tali creature; laonde se potesse avvenire che una cosa pensasse e non vivesse, questa cosa non rassomigliando alle creature viventi, nè anche avrebbe in se questo desiderio di vita; sì come questo medesimo (e intendo, come v’accorgete, non mica il desiderio di vivere, ma quello che ho determinato di sopra), se ha punto di forza nei bruti, è da credere che gli spinga a desiderare ciascuno la vita della sua specie. Ora venendo a quello che scaturisce da questi principii, non tanto io quanto voi stessi, o Lettori, spontaneamente avvertirete in primo luogo la naturalezza e bellezza delle favole greche, le quali compiacendo a questo desiderio poeticissimo ch’è in noi, popolarono il mondo di persone umane, e alle stesse bestie attribuirono origine umana, acciocchè l’uomo trovasse in certa maniera per tutto, quello che non l’esempio nè l’insegnamento nè l’uso nè la pedanteria nè il gusto classico nè le altre baie fantasticate dai romantici, ma la natura lo spinge irrepugnabilmente a cercare, dico enti simili a se, nè riguardasse veruna cosa con noncuranza; e il poeta potesse rivolgersi colle parole a checchessia, conforme ha per costume ingenito e naturale, non altrimenti che i fanciulli: secondariamente come stieno male in bocca d’un maestro di psicologia quelle parole, che il primo concetto d’avvivare la natura convertendola in individui di questa nostra specie, da qualunque avvedimento sia proceduto, fu, anzichenò, immaginoso; appunto come se questo concetto fosse stato casuale e arbitrario, e non naturalissimo e necessarissimo, nè venuto allo stesso Breme quando era bambino, e anche oggi mandato sovente ad effetto dalla sua propria immaginativa: ultimamente la vanità e stranezza di quella sentenza del Cavaliere, che abbiamo preso a discutere, vale a dire che il poeta volendo avvivar la natura, gli convenga avvivarla immediatamente, e non come gli antichi, trasformando le cose inanimate in persone. Il che quanto sia non dirò falso, ma peggio che ridicolo e intollerabile, apparisce non solo dalle cose che si son dette, ma in oltre primieramente da questo, che noi non fummo giammai nè saremo tocchi, nè prenderemo cura, nè verremo, per così dire, a parte degli affetti o delle azioni, o di qualsivoglia altra cosa appartenente alle creature introdotte o comunque mentovate dal poeta, se queste non saranno simili a noi; e veruno al mondo non pianse nè piangerà delle disgrazie d’un fiore o d’un pomo o d’un lago o d’un monte, nè si rallegrò delle fortune di una stella, eccetto se prima non l’ebbe immaginando trasmutata in persona. E che questo sia vero (se bene chi ne dubita? o chi non avrà voglia di burlarsi di me vedendo ch’io quasi mi metto a provare una sentenza così rancida e triviale?) non solamente è dannosa anzi mortifera la dissomiglianza delle creature, ma anche degli uomini, tanto che c’importano assai meno le cose dei Neri che quelle de’ Bianchi, e tra i Bianchi assai meno quelle de’ Samoiedi o de’ Cinesi o di qualunque differisce grandemente da noi di costumi o di forme o d’altra cosa notabile, che quelle de’ nostrali; onde’ è, lo dirò pure, propriamente matta la consuetudine dei romantici di pigliar soggetti e persone specialissimamente dai barbari cantando agl’inciviliti, o vero introdur gente il più che sanno straordinaria, e mostri di natura, coi quali ci convenga immedesimarci e rallegrarci e dolerci e provare quegli affetti che piaccia al poeta. E certamente che quello che tutto il mondo sa ed afferma, sia negato o ignorato dai romantici, è affatto maraviglioso, ma quello che sto per dire è incredibile. Poichè la maniera voluta dal Breme non solo è nemica della natura, non solo scemerebbe indicibilmente il diletto poetico, ma, lasciando tutto questo, è impossibile. In oltre l’esempio del Byron portato dal Cavaliere, non solamente non giova a lui, ma conferma nè più nè meno quello ch’io dico. Forsechè veruno di noi si può figurare nessuna vita diversa dall’umana? forsech’all’animo nostro è, non dico facile, ma possibile il concepire l’idea d’un sentimento d’un affetto d’un pensiero non umano? Lasciamo stare i poeti che non posson essere troppo sottili. Io provoco qualunque è al mondo o filosofo o metafisico o psicologo o, quello ch’è più di tutto, romantico a immaginarsi una maniera di vivere differente dalla nostra, la quale possano attribuire a Dio che sappiamo di certo come vive altrimenti che l’uomo, agli Angeli, a qualsivoglia sostanza visibile o invisibile, materiale o no, reale o immaginaria. E se non possono essi e non può l’uomo idearsi positivamente altra maniera di vivere che la propria (e dico positivamente perchè negativamente è facile, ma non ha che fare colla poesia), se altre specie di vita appena c’induciamo a credere che ci possano essere, non che sappiamo immaginarne veruna, come dunque e che vita se non umana attribuirà il poeta alle cose? come potrà il poeta, il quale parla al popolo, e non segue la ragione ma la natura, quello che non può il metafisico? Ma stante ch’egli non possa vivificare altrimenti, converrà che dia sì bene alle cose vita umana, ma non perciò le rivesta di forme umane? Che cos’è altro il poetare non dico da barbaro ma da persona di un altro mondo? E ci dovranno mettere avanti agli occhi ora piante ora sassi ora nuvole ora strumenti, e in somma cose d’ogni genere, con dir che sentono e pensano e vivono come fa l’uomo, non essendo altro a vederli che sassi e piante e che so io, non mutati niente di figura, nè meno confusamente nè meno lasciandolo il poeta immaginare agli uditori, anzi proccurando che quanto alla forma non si figurino punto di umano; e questo non come cose stravaganti e miracolose, ma ordinarie, non per capriccio ma per istituto, non di rado ma tuttogiorno? Non vede il Breme che queste sarebbero menzogne, non già sol tanto assolute, ma poetiche, inverisimili incredibili impudenti? non vede che tanto è naturale all’uomo il vestire gli oggetti insensati di forme umane, quanto l’avvivarli? nè quella proprietà si può separare da questa? e per levargli quel vizio bisognerebbe rifarlo? non vede ch’il poeta è uomo? che gli uditori del poeta son uomini? a questo dunque saremo giunti? e la poesia nostra non sarà più solamente barbara, ma in tutto e per tutto disumana? anzi, come ho detto, di un altro mondo, giacchè delle stesse bestie diceva Senofane che se i buoi se gli elefanti avessero mani, e con queste potessero dipingere, e fare quelle cose che fanno gli uomini, allora i cavalli dipingendo gli Dei gli avrebbero fatti di figura cavallina, e i buoi di figura bovina, e dato loro un corpo simile al proprio. E soggiungeva che gli Etiopi si figuravano i loro Dei neri e camosci, e i Traci d’occhio cilestro e colore vermiglio, e parimente gli Egizi i Medi i Persiani se li fabbricavano ciascuna gente in sembianza simile alla sua. La qual cosa detta da Senofane di queste poche nazioni barbare, noi la possiamo nello stesso modo affermare di cento altre sconosciute agli antichi: tanto è naturale e universale e indelebile il costume d’immaginarsi in figura somigliante alla propria quelle cose che sapendo o credendo o fingendo che vivano, altra vita non ce ne possiamo ideare fuorchè la propria. Che se le bestie, alle quali non sappiamo attribuire affetto o pensiero o sentimento altro che umano, tuttavia non ci pare incredibile che vivano, come fanno, sotto altra forma, questo nasce primieramente che la forma loro s’assomiglia alla nostra quanto conviene essendo il genere loro e il nostro uno solo; poi che l’inverisimile è vinto dal vero, e l’uso impedisce la maraviglia. Ma tanta è la forza del verisimile, che noi siamo più propensi a creder vivo qualunque oggetto inanimato s’accosta alla figura ordinaria degli animali, che non qualunque animale se ne scosta notabilmente, salvo se questo non è volgare in modo che la stranezza della forma non faccia caso per cagione della consuetudine. Ora poniamo che il poeta abbia avvivato oggetti privi di senso, lasciando loro nè più nè meno la forma naturale: o questi oggetti staranno sempre immobili e inoperosi, e al poeta basterà di dire che vivono e amano e odiano e sperano e temono e cose tali; o dovendo dar segni di vita, e operare, e dimostrare colle cose di fuori le cose di dentro, saprei volentieri che moti che atti che operazioni, in somma che vita esterna attribuirà loro il poeta; e quali effetti farà l’intrinseco, il quale come ho detto non può essere altro che umano, nell’estrinseco il quale sarà tutt’altro; e parimente in che modo le cose esterne opereranno in questi oggetti che non hanno organi come noi nè come gli altri animali. Vediamo in che maniera abbia proceduto il Byron, da certi versi del quale il Cavaliere prende occasione d’esporre questa sentenza che abbiamo per le mani; e i versi son questi, riportati dal Cavaliere secondo la traduzione del Rossi:
Che là sul colle e in seno al praticello
Dell’usignuol discopri la signora,
Quella per cui l’innamorato augello
Fa la sua risonar voce canora;
E del suo vago al canto un verginale
Rossor la donna de’ bei fior colora.
Lontana là dal verno occidentale,
Da freddi venti, da gelata brina,
E blandita da Zefiro vitale
La dei giardin, dell’usignuol regina
Il profumo che a lei natura diede
Ne’ suoi calici accoglie, e sì lo affina
Che in più soave incenso al ciel poi riede.
Oh quanta i suoi sospir spargon fragranza!
Ci vuole un tedesco a pronunziare quest’ultimo verso: ma badiamo al fatto nostro. Quando il poeta ha finto che la rosa innamorata si tinga in presenza dell’amante di rossore verginale, e sospiri, che altro ha fatto se non trasformata la rosa in persona umana? Chi s’immagina un sospiro non s’immagina anche una bocca? e se una bocca, non anche un volto? e se un volto, non anche una persona? Onde la rosa, volere o non volere, e nella fantasia del poeta e nella fantasia de’ lettori è una donna. Se non che l’immagine è languida e incerta perchè quelle due finzioni del poeta, essendo troppo comuni e leggere, non bastano a suscitare nella fantasia più che tanto, come se un pittore mostra solamente i capelli o altra tal parte di una figura. E già, non destando verun’immagine, il che senza fallo è piacevolissimo, e convenientissimo alla poesia, facilmente s’impedisce che il lettore non si figuri nessun vestigio di forma umana. Il fatto sta che o sorge nella fantasia de’ lettori l’immagine di una donna, o la rosa resta una rosa qual è, nè amante nè amata nè viva nè altro che un fior vero e semplice: e se molte o tutte le finzioni del poeta moderno riuscissero a un esito come questo, chi può dire il guadagno che ci farebbe la poesia nostra? Ed ecco la maniera onde il Breme ha dimostrato la vanità poetica della mitologia.
Qui potrei discorrere della foggia d’imitare tenuta dai romantici, e considerandola rispetto al fine della poesia ch’è il diletto, rammemorare ch’esso diletto quando scaturisce dalla imitazione del vero, non procede sol tanto dalle qualità degli oggetti imitati, ma in oltre specialissimamente ed essenzialmente dalla maraviglia che nasce dal vedere quei tali oggetti quasi trasportati dove non pareva appena che si potesse, e rappresentati da cose che non pareano poterli rappresentare; di modo che infiniti oggetti i quali in natura non dilettano punto, imitati dal poeta o dal pittore o da altro tale artefice, dilettano estremamente; e altri che dilettavano anche reali, dilettano da vantaggio imitati. Dalla qual cosa apparisce quanto s’ingannino i romantici pensando d’accrescer pregio alla poesia con rendere la imitazione oltre ogni modo facile, e sottrarla da ogni legge, e sostituire meglio che possono il vero in luogo del simile al vero, sì che vengono a scemare e quasi annullare il maraviglioso, e per conseguenza il dilettoso dell’imitazione, il quale è tanto essenziale che tolto via, si può dire che il diletto poetico parte si riduca alla metà, parte al niente. E in oltre imitando la poesia massime romantica infinite cose che in natura non solamente non dilettano anzi molestano, nè possono dilettare altrimenti che imitate, il metterci queste cose avanti agli occhi non tanto imitate quanto vere, non è nè bizzarria, nè gusto singolare, nè stranezza di opinioni, nè fierezza nè altro, ma pura e pretta ignoranza, e grossezza di cervello. Credono i romantici che l’eccellenza della imitazione si debba stimare solamente secondoch’ella è vicina al vero, tanto che cercando lo stesso vero, si scordano quasi d’imitare, perchè il vero non può essere imitazione di se medesimo. Ma l’imitare semplicemente al vivo, e del resto comechè sia, non è pur cosa facile ma triviale: imita ciascuno di noi tutto giorno, imita il volgo principalmente, imitano le bertucce, imitava quel buffone di Fedro quanto si può dire al naturale il grugnito del porco. Ma che maraviglia deriva da questa sorta d’imitazioni? e quindi che diletto? Se la sentenza dei romantici fosse vera, andrebbe fatto molto più conto delle balie che dei poeti, e un fantoccio vestito d’abiti effettivi con parrucca, viso di cera, occhi di vetro, varrebbe assai più che una statua del Canova o una figura di Raffaello. Ma la faccenda non va così, non mica perchè tutto il mondo tiene e ha tenuto il contrario; poichè ragionevolmente si persuadono i romantici che tutto il mondo e tutte le età del mondo non vagliano un’acca rispetto a loro; ma perchè il diletto cagionato dal poeta e dagli artefici, come sa e prova chiunque ha la mente sana, è senz’alcun paragone maggiore di quello che partoriscono queste imitazioni facili e volgari che vediamo e sentiamo e facciamo alla giornata, nonostantech’in grandissima parte sieno tanto vive quanto nessuna imitazione di poeta o d’artefice; e quelle difficoltà e quelle leggi, oltrechè sono convenientissime e necessarie per altri rispetti, fanno la imitazione maravigliosa e dilettevole; ma senza nessuna difficoltà e senza nessuna legge non è maraviglia che s’imiti vivamente. Ed io vedo, per esempio, che appresso i poeti antichi s’incontrano molto di rado quei troncamenti e quelle interruzioni e sospensioni che i moderni fanno a gara di seminarle da per tutto, empiendo le pagine di lineette o di punti; perchè stimavano che il vero nella poesia non si dovesse introdurre ma imitare, e che l’imitare in guisa troppo facile, e uscire dalle leggi ordinarie della poesia non accrescesse il diletto ma lo scemasse. Talmente che paragonando la poesia loro a quella statua o figura dipinta ch’io dicea poco sopra, la poesia romantica, la quale imita il calpestìo de’ cavalli col trap trap trap, e il suono de’ campanelli col tin tin tin, e così discorrendo, si può molto acconciamente rassomigliare a quel fantoccio, o volete a un burattino che ha la mobilità da vantaggio. Che se l’evidenza sola va cercata nelle imitazioni, perchè non dismettiamo del tutto questa materia disadattissima delle parole e dei versi, e non ci appigliamo a quella scrittura di certi barbari ch’esprime i concetti dell’animo con figure in vece di caratteri? anzi perchè ciaschedun poeta in cambio di scrivere non inventa qualche bella macchina la quale mediante diversi ingegni metta fuori di mano in mano vedute e figure di qualsivoglia specie, e imiti il suono col suono, e in breve, rappresentando ordinatamente quello che sarà piaciuto all’inventore, non operi sol tanto nella immaginativa ma eziandio ne’ sensi del non più lettore ma spettatore e uditore e che so io? E mentrech’io scrivo queste cose, viene con un nome infernale da un paese romantico uno strumento non dissimile in quanto all’ufficio da questo ch’io m’andava immaginando quasi per giuoco; ed io mi rallegro d’aver preveduto dove convenia che arrivasse la nuova scuola, e mi dolgo che nè meno da scherzo si possa quasi nè dire nè pensar cosa tanto strana e ridicola che dai romantici non sia pensata e detta e, potendo, praticata da buon senno. Anche potrei confermare quello che ho scritto in altro luogo di questo Discorso, del quanto giovi alla imitazione che gli oggetti sieno comuni, e per lo contrario noccia che sieno straordinari e sconosciuti; imperocchè allora il maraviglioso e per tanto il dilettevole della imitazione è molto scarso, non potendosi veruno maravigliare che sia ritratta al naturale una cosa ch’egli non sappia come sia fatta, e quando anche l’imitazione sia vivissima, cagionando appresso a poco lo stesso effetto che un’invenzione del poeta: ora fu noto ai bisavi, ed è noto ai fanciulli che generalmente è molto più facile e meno maraviglioso l’inventare che l’imitare. Ed io so bene che l’esperienza propria fa fede a chicchessia di quello ch’io dico, nè c’è persona la quale non si avveda che quando ella contempla, poniamo caso, una bella pittura o scultura, suol provare a cagione della maraviglia uno squisitissimo diletto notando così tutta l’imitazione come questa o quella parte quanto somigli bene e accuratamente al vero, e quasi credendo di vedersi davanti lo stesso oggetto imitato; nel quale anche sogliamo por mente allora a non poche minuzie, che nel vederlo effettivamente, per lo più non attendiamo: nè questo diletto può cadere in chiunque non conoscendo o appena conoscendo l’oggetto reale, non può confrontare seco medesimo senza veruna difficoltà nè fatica l’imitazione colla cosa imitata, nè discernere a prima giunta la somiglianza scambievole dell’una e dell’altra. Avea deliberato di parlare di tutte queste cose distintamente. Ma oramai sono sazio di scrivere, e voi sarete sazi di leggere, se però la pazienza v’avrà sostenuti fin adesso, o Lettori miei. Perciò bastino le cose che si son dette. Ma già sul finire, essendomi sforzato sin qui di costringere i moti dell’animo mio, non posso più reprimerli, nè tenermi ch’io non mi rivolga a voi, Giovani italiani, e vi preghi per la vita e le speranze vostre che vi moviate a compassione di questa nostra patria, la quale caduta in tanta calamità quanta appena si legge di verun’altra nazione del mondo, non può sperare nè vuole invocare aiuto nessuno altro che il vostro. Io muoio di vergogna e dolore e indignazione pensando ch’ella sventuratissima non ottiene dai presenti una goccia di sudore, quando assai meno bisognosa ebbe torrenti di sangue dagli antichi prontissimi e lieti; nè c’è una penna tra noi che s’adopri per quella che gli avi nostri difesero e accrebbero con milioni e milioni di spade. Soccorrete, o Giovani italiani, alla patria vostra, date mano a questa afflitta e giacente, che ha sciagure molto più che non bisogna per muovere a pietà, non che i figli, i nemici. Fu padrona del mondo, e formidabile in terra e in mare, e giudice dei popoli, e arbitra delle guerre e delle paci, magnifica ricca lodata riverita adorata; non conosceva gente che non la ubbidisse, non ebbe offesa che non vendicasse, non guerra che non vincesse; non c’è stato imperio nè fortuna nè gloria simile alla sua nè prima nè dopo. Tutto è caduto: inferma spossata combattuta pesta lacera e alla fine vinta e doma la patria nostra, perduta la signoria del mondo e la signoria di se stessa, perduta la gloria militare, fatta in brani, disprezzata oltraggiata schernita da quelle genti che distese e calpestò, non serba altro che l’imperio delle lettere e arti belle, per le quali come fu grande nella prosperità, non altrimenti è grande e regina nella miseria. Questo solo regno questa gloria questa vita rimane alla patria nostra quasi levata dal numero delle nazioni, grande avanzo d’immensa grandezza, sempre finora invidiato e bestemmiato invano dagli altri popoli, insofferenti che la regina del mondo quantunque sordida e guasta, a ogni modo non sia per anche spogliata di scettro e di corona. Ma già per rapirle questo medesimo avanzo adoprano armi ed arti assai più terribili e potenti che per l’addietro, studiandosi di viziare e corrompere gl’ingegni italiani, e imbarbarire le arti e lettere nostre, e fare che la misera Italia di maestra delle nazioni moderne diventi emula e imitatrice, e di signora, uguale e serva, e, quello che nessun altro ha potuto, si spogli finalmente del regno e s’uccida essa stessa. Io vi prego e supplico, o Giovani italiani, io m’atterro dinanzi a voi; per la memoria e la fama unica ed eterna del passato, e la vista lagrimevole del presente, impedite questo acerbo fatto, sostenete l’ultima gloria della nostra infelicissima patria, non commettete per Dio che quella che per colpa d’altri infermò, per colpa d’altri agonizza, muoia fra le mani vostre per colpa vostra. Che valse che quella nazione il cui dominio consumato nella decima parte di un secolo, tanto ha durato meno del nostro quanto era degno, ci rapisse le opere de’ nostri artefici, e sfornisse le vie le case i tempii gli altari nostri per adornare le sue piazze e le sale, forse anche i tempii e gli altari insanguinati, quasi le dovesse fruttar gloria e non vergogna l’aver tolto colle armi a un popolo inerme quelle opere ch’ella forzatamente ammirando e invidiando, non seppe nè sa produrre? Non le opere dovea rapirci ma gl’ingegni, e quella divina fiamma che non ci fa ebbri nè pazzi nè rabbiosi, non diavoli incarnati nè bestie, ma quasi numi; nè però ci taglia i nervi, nè c’empie di superstizione e codardia, nè del timore d’offendere occhi e orecchi paurosi e schivi della natura, nè ci manda dietro alle inezie e alle bolle per piacere a un popolo tutto fatto di spuma, presso al quale è vanto la leggerezza come presso agli altri la gravità, nè ritrova lode una pagina che non sia stillata per lambicco dal cervello dello scrittore, biasimato e disprezzato ogni volta che non sia spiritoso. Certo quelle tele e quei marmi cattivi in un luogo dove confluia tutta l’europa, accusavano la povertà e superbia di quella gente, e predicavano l’eccellenza e ricchezza di questa terra ch’ella ha sempre odiata e odierà, già vinta dalle armi nostre armata e potente e ripugnante, poi vincitrice di noi fiacchi ed inermi ed immobili, ma sempre vinta nelle arti e nello scrivere, ch’è maschio appresso noi, femmina imbelle e civetta appresso lei. Ora questa, debellata due volte dal ferro, e aperto a viva forza l’artiglio, ha rilasciato la preda; e quelle opere immortali ch’erano e saranno sempre nostre, dovunque la fortuna le sbalzi, ritornate alla patria loro, albergano qui fra noi, beando gli occhi e gli animi nostri, e quasi gridando ci esortano ad emulare quei divini artefici nati da una stessa madre con noi, che imitando questa natura, e contemplando questo cielo e questi campi e questi colli, a se medesimi acquistarono e alla patria mantennero nome e gloria più durevole dei regni e delle nazioni. Ma se alla voce loro e dei sommi scrittori nostri e di tutte le età passate e della ragione e della natura prevarrà la voce dei nuovi maestri, e se alla fine ci sarà tolto, non la vista delle pitture e delle statue, ma l’uso conveniente dei nostri ingegni, certo che questo tesoro ricuperato incredibilmente, laddove prima svergognava i suoi ladroni, svergognerà noi medesimi, e attesterà la fine del nostro regno e la morte dell’italia. La qual cosa pur troppo è da temere che non avvenga, e in questa medesima età spettatrice del lutto e del giubilo dell’italia spogliata e rivestita; pur troppo vedo corrotta la lingua, il che non è mai scompagnato dalla corruttela del gusto; vedo negletti e avuti a schifo i nostri sovrani scrittori, e i greci e i latini antecessori nostri, e accolte, e ingozzate ghiottissimamente, e lodate e magnificate quante poesie quanti romanzi quante novelle quanto sterco sentimentale e poetico ci scola giù dalle alpi o c’è vomitato sulle rive dal mare; vedo languido e pressochè spento l’amore di questa patria: vedo gran parte degl’italiani vergognarsi d’essere compatriotti di Dante e del Petrarca e dell’Ariosto e dell’Alfieri e di Michelangelo e di Raffaello e del Canova. Ora chi potrebbe degnamente o piangere o maledire questa portentosa rabbia, per cui, mentre i Lapponi e gl’Islandesi amano la patria loro, l’italia, l’italia dico, non è amata, anzi è disprezzata, anzi sovente è assalita e addentata e insanguinata da’ suoi figli? O Giovani italiani: lascio stare le cose antiche: purchè vogliamo essere questo medesimo, io dico italiani, ancora siamo grandi; ancora parliamo quella favella a cui cedono tutte le vive, e che forse non cederebbe alle morte; ancora abbiamo nelle vene il sangue di coloro che prima in un modo e quindi in un altro signoreggiarono il mondo; ancora beviamo quest’aria e calchiamo questa terra e godiamo questa luce che godè un esercito d’immortali; ancora arde quella fiamma che accese i nostri antenati, e parlino le carte dell’Alfieri e i marmi del Canova; ancora non è cambiata quell’indole propria nostra, madre di cose altissime, ardente e giudiziosa, prontissima e vivacissima, e tuttavia riposata e assennata e soda, robusta e delicata, eccelsa e modesta, dolce e tenera e sensitiva oltre modo, e tuttavia grave e disinvolta, nemica mortalissima di qualsivoglia affettazione, conoscitrice e vaga sopra ogni cosa della naturalezza, senza cui non c’è nè fu nè sarà mai beltà nè grazia, amante spasimata e finissima discernitrice del bello e del sublime e del vero, e finalmente savissima temperatrice della natura e della ragione; ancora siamo più di qualunque altro popolo vicini a quel punto, che quando si oltrepassa, non è quella civiltà ma barbarie, come si vide ne’ greci e si vide ne’ romani, e se ora non ci par di vedere in nessuna gente d’europa, viene che molti oggetti non si distinguono da presso ma solamente discosto, e che non sappiamo quasi mai ragguagliare le cose lontane colle vicine in maniera che non ci paiano differenti, come spessissimo non sono. Questa patria, o Giovani italiani, considerate se vada sprezzata e rifiutata, vedete se sia tale da vergognarsene quando non accatti maniere e costumi e lettere e gusto e linguaggio dagli stranieri, giudicate se sia degna di quella barbarie la quale io seguitando fin qui colla scrittura, non ho saputo nè potuto appena adombrare. Io non vi parlo da maestro ma da compagno, (perdonate all’amore che m’infiamma verso la patria vostra, se ragionando per lei m’arrischio di far parola di me stesso) non v’esorto da capitano, ma v’invito da soldato. Sono coetaneo vostro e condiscepolo vostro, ed esco dalle stesse scuole con voi, cresciuto fra gli studi e gli esercizi vostri, e partecipe de’ vostri desideri e delle speranze e de’ timori. Prometto a voi prometto al cielo prometto al mondo, che non mancherò finch’io viva alla patria mia, nè ricuserò fatica nè tedio nè stento nè travaglio per lei, sì ch’ella quanto sarà in me non ritenga salvo e fiorente quel secondo regno che le hanno acquistato i nostri maggiori. Ma che potrò io? e qual uomo solo ha potuto mai tanto quanto bisogna presentemente alla patria nostra? Alla quale se voi non darete mano così com’è languida e moribonda, sopravvivrete o Giovani italiani all’italia, forse anch’io sciagurato sopravvivrò. Ma sovvenite alla madre vostra ricordandovi degli antenati e guardando ai futuri, dai quali non avrete amore nè lode se trascurando avrete si può dire uccisa la vostra patria; secondando questa beata natura onde il cielo v’ha formati e circondati; disprezzando la fama presente che tocca per l’ordinario agl’indegni, e cercando la fama immortale che agl’indegni non tocca mai, ch’essendo toccata agli artefici e scrittori italiani e latini e greci, non toccherà nè a’ romantici nè a’ sentimentali nè agli orientali nè a veruno della schiatta moderna; considerando la barbarie che ci sovrasta; avendo pietà di questa bellissima terra, e de’ monumenti e delle ceneri de’ nostri padri; e finalmente non volendo che la povera patria nostra in tanta miseria, perciò si rimanga senz’aiuto, perchè non può essere aiutata fuorchè da voi.
*******
Avvertimento
Questo discorso che da principio s’intitolava, Intorno alle Osservazioni del Cavaliere Lodovico di Breme sulla poesia moderna, fu cominciato appena venute in luce le dette Osservazioni ne’ quaderni undecimo e seguente dello «Spettatore italiano»: poi non sapendo l’autore sbrigarsi in un batter d’occhio dell’assunto di trattare queste materie, e intanto altri più felice avendo risposto, e il Cavaliere felicissimo avendo replicato immediatamente e diffusissimamente, l’autore non giudicò di frammettersi in questa lite per allora; e oltracciò non parendogli che l’Italia fosse mossa da quelle Osservazioni a segno che dovesse far troppo caso di un libro che semplicemente le confutasse, e crescendogli la materia fra le mani, si regolò in guisa che questo Discorso, cambiato il titolo, a ogni modo ritiene la sua prima forma di risposta alle Osservazioni del Cavaliere.