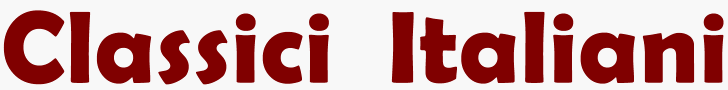Giacomo Leopardi.
Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica.
Capitolo I.
|
Note Link esterni |

I.
Se alla difesa delle opinioni de’ nostri padri e de’ nostri avi e di tutti i secoli combattute oggi da molti intorno all’arte dello scrivere e segnatamente alla poetica si fossero levati uomini famosi e grandi, e se agl’ingegni forti e vasti si fosse fatta incontro la forza e la vastità degl’ingegni, e ai pensieri sublimi e profondi, la sublimità e profondità dei pensieri, nè ci sarebbe oramai bisogno d’altre discussioni, nè quando bene ci fosse stato, avrei però ardito io di farmi avanti. Ora s’è risposto fin qui alle cose colle parole, e agli argomenti colle facezie, e alla ragione coll’autorità, e la guerra è stata fra la plebe e gli atleti, e fra i giornalisti e i filosofi, di maniera che non è maraviglia se questi imbaldanziscono e paiono tenere il campo, e noi tra paurosi e vergognosi e superbi, tenendoci al sicuro come dentro a recinti di muraglie e di torri, gl’insultiamo tuttavia cogli stessi motteggi, quasi ch’esser ultimo a replicare fosse vincere; nè però questo stesso ci è conceduto. Ma se la nostra causa è giusta e buona, e se noi siamo gagliardi e valorosi, e se confidiamo nel favore del[la] ragione e della verità, che non usciamo e non combattiamo? e perchè mostriamo di non intendere quello che intendiamo ottimamente ma che non ci quadra, o come ci persuadiamo senza nessuna considerazione che sia falso quello che non intendiamo? Forse ci basta di mantenere in quiete la coscienza nostra, e purch’ella con dubbi importuni non ci molesti, e ci lasci seguitare sicuramente e lietamente i nostri studi e i nostri scritti senza quella formidabile svogliatezza che proviene dal timore di gittare il tempo e le fatiche, non ci curiamo d’altro, e per questo fuggiamo di venire alle prese e giuochiamo largo, non temendo tanto il nemico che è fuori quanto quello ch’è dentro di noi medesimi? No, per Dio, non sia così; ma non cerchiamo altro che il vero: e se tutto quello che abbiamo imparato è vano, e se quello che parea certo è falso, e quello che credevamo di vedere non si vedeva, e quello che credevamo di toccare non si toccava, e se tanti altissimi ingegni, e tanti dotti e tanti secoli tutti nè più nè meno si sono ingannati, sia con Dio. Non guardiamo che bisognerà far conto di non avere fino ad ora studiato nè sudato, anzi di avere e studiato e sudato da pazzi e per niente, dire addio ai libri quasi nostri amici e compagni, bruciare gli scritti nostri, e in somma farci da capo, e giovani o vecchi che siamo, cominciare una vita nuova: rallegriamoci più tosto che ci sia toccato quello che a’ nostri maggiori non toccò, di conoscere finalmente il vero, e di questo vero gioviamoci noi e facciamo ch’altri si giovi parimente. Ma se nebbie e sogni e fantasmi sono più tosto le opinioni moderne, e se i nostri antenati hanno veduto chiaro, e se la verità non ha penato tanti secoli a uscire al giorno, perchè lasciamo che la gente sia confusa e ingannata, e che la gioventù nostra stia in forse di quale delle due dottrine s’abbia a fidare? Confesso che un silenzio magnanimo pareva a me pure il meglio, anzi la sola cosa che convenisse ai veri savi in questa disputa: e l’esempio de’ veri savi che non ci aprono bocca, non mi confermava nella mia opinione nella quale era fermissimo, ma mi consolava il vedere che il giudizio loro concordava in questo particolare col mio. Nondimeno sì molte altre cose, come l’aver lette e considerate le Osservazioni del Cavaliere Lodovico di Breme intorno alla poesia moderna, secondochè la chiama egli, m’hanno indotto a pensare che se forse il commuoversi di un uomo illustre e il rompere quel silenzio disdegnoso potrebbe nuocere, il comparire di un uomo oscuro il quale dica non motti ma ragioni, non possa nuocere e possa giovare, perchè nè la sconfitta d’un fiacchissimo combattente potrà pregiudicare alla fama dell’esercito, e caso ch’egli paresse aver fatto qualche cosa, si potrà stimare quante e quanto più grandi ne farebbero i forti. Senz’altro le Osservazioni del Cavaliere a me paiono pericolose; e dico pericolose, perchè sono per la più parte acute e ingegnose e profonde, e questo, se a noi non par vero quello che pare al Breme, dobbiamo giudicare che sia pericoloso, potendo persuadere a molti quello che secondo noi è falso, e che certamente è di tanto rilievo quanto le lettere e la poesia. Però così debole come sono, ho deliberato di vedere se l’affetto che porto focosissimo alla mia patria e molto più al vero, mi darà forza dicendo e per la patria e per quello ch’io credo vero. Userò, come ho detto, le ragioni, e niente altro che le ragioni: non so se saranno metafisiche, ma saranno ragioni; e se non tutte o non molte nuove, da questo stesso facilmente si potrà inferire che le opinioni di coloro che si chiamano romantici, posto che non sieno antiche, certo hanno radici antichissime, e con istrumenti d’antichissimo uso si possono abbattere e sradicare. E come mi terrò lontano da molte usanze di quei che per l’addietro sono venuti a quistione coi romantici, così massimamente non proccurerò nè mi vanterò di non intendere, del qual costume si lagna il Breme a ragione, imperocchè chi del continuo protesta di non intendere, quegli rifiuta ogni controversia. Ma, dirò pure quello che sento, a volere intender bene il Cavaliere e qualcheduno de’ romantici, forse alle volte non basta nè il desiderio nè l’ingegno, ma ci vuole un cuore che sappia aprirsi e diffondersi e palpitare d’altro che di paura o cose simili, e una mente non al tutto inesperta del fuoco e dell’impeto delle arti belle. Ora se la mia mente sia tale, e se il mio cuore abbia mai palpitato per cagione non vile, non è cosa da farne discorso: basta ch’io penso d’avere intesi i ragionamenti del Cavaliere: questo però nè egli nè altro lo dovrà credere alle mie parole, ma sì bene ai fatti, cioè se io nel discutere le osservazioni del Cavaliere, darò indizio d’averle intese. Tratterò della poesia romantica non già pienamente, che questo da vero sarebbe un carico disadatto alle mie spalle, ed io togliendolo mi mostrerei temerario non coraggioso; ma quanto basterà per tener dietro alle Osservazioni predette: e già quest’assunto non è piccolo, anzi io guardando come di lontano la folla delle materie dentro la quale bisogna ch’io mi cacci, quasi mi sbigottisco, e non so che strada troverò d’esser breve in tanta moltitudine di cose e in tanta necessità d’esser chiaro. Tuttavia stimo che agitando le opinioni del Breme verrò anche a tentare i fondamenti delle opinioni romantiche, se bene queste sono così confuse e gregge e scombinate e in gran parte ripugnanti che bisogna quasi assalirle a una a una, e atterrata una parte dell’edifizio, l’altra non pertanto si tiene in piede, segno non di fortezza ma di sconnessione, e però di debolezza. E incominciando dico che non paleserò il nome mio, per non far vista di credere nè che altri, letto quello ch’io scriverò, possa desiderare d’aver notizia di chi scrisse, nè che il mio nome manifestato vaglia a darmi a conoscere, ignotissimo com’egli è. Per queste cagioni terrò nascosto il mio nome, non per timore, o Italiani, ch’io non temerò mai scrivendo il vero e scrivendo come potrò per voi, nè l’odio di chicchessia nè il potere o la fama di chicchessia.
Già è cosa manifesta e notissima che i romantici si sforzano di sviare il più che possono la poesia dal commercio coi sensi, per li quali è nata e vivrà finattantochè sarà poesia, e di farla praticare coll’intelletto, e strascinarla dal visibile all’invisibile e dalle cose alle idee, e trasmutarla di materiale e fantastica e corporale che era, in metafisica e ragionevole e spirituale. Dice il Cavaliere che la smania poetica degli antichi veniva soprattutto dall’ignoranza, per la quale maravigliandosi balordamente d’ogni cosa, e credendo di vedere a ogni tratto qualche miracolo, pigliarono argomento di poesia da qualunque accidente, e immaginarono un’infinità di forze soprannaturali e di sogni e di larve: e soggiunge che presentemente, avendo gli uomini considerate e imparate, e intendendo e conoscendo e distinguendo tante cose, ed essendo persuasi e certi di tante verità, nelle facoltà loro non sono, dic’egli co’ suoi termini d’arte, compatibili insieme e contemporanei questi due effetti, l’intuizione logica e il prestigio favoloso: smagata è dunque di questa immaginazione la mente dell’uomo. Ora da queste cose, chi voglia discorrer bene e da logico, segue necessarissimamente che la poesia non potendo più ingannare gli uomini, non deve più fingere nè mentire, ma bisogna che sempre vada dietro alla ragione e alla verità. E notate, o lettori, sul bel principio quell’apertissima e famosa contraddizione. Imperocchè i romantici i quali s’accorgevano ottimamente che tolta alla poesia già conciata com’essi l’avevano, anche la facoltà di fingere e di mentire, la poesia finalmente nè più nè meno sarebbe sparita, e di netto si sarebbe immedesimata e diventata tutt’uno colla metafisica, e risoluta in un complesso di meditazioni, non che abbiano soggettata pienamente la poesia alla ragione e alla verità, sono andati in cerca fra la gentaglia presente di ciascheduna classe, e specialmente fra il popolaccio, di quelle più strane e pazze e ridicole e vili e superstiziose opinioni e novelle che si potevano trovare, e di queste hanno fatto materia di poesia; e quello ch’è più mirabile, intantochè maledicevano l’uso delle favole greche, hanno inzeppate ne’ versi loro quante favole turche arabe persiane indiane scandinave celtiche hanno voluto, quasi che l’intuizione logica che col prestigio favoloso della grecia non può stare, con quello dell’oriente e del settentrione potesse stare. Ma di questa incredibile contraddizione d’aver fatto tesoro delle favole orientali e settentrionali dopo scartate le favole greche come ripugnanti ai costumi e alle credenze e al sapere dell’età nostra, parlerò più avanti a suo luogo. Ora tornando al Cavaliere, seguita egli dicendo immediatamente che la facoltà immaginativa è sostanzialissima nell’uomo, di maniera che non può svanire nè scemare, ma per l’opposto arde oggi come sempre d’essere invasa rapita innamorata atterrita E PERFIN SEDOTTA (qui sta il punto); nè avverrà mai che non soggiaccia alle ILLUSIONI delle forme armoniche, alle estasi della sublime contemplazione, all’efficacia dei quadri ideali, purchè non sieno più arbitrari DEL TUTTO, e DEL TUTTO nudi di analogia con quel vero che ne circonda, o con quello ch’è in noi. Ed ecco come anch’egli concede che la poesia debba ingannare, la qual cosa poi asserisce e conferma risolutamente in cento altri luoghi delle sue osservazioni. A me pare di scorgere molto chiaramente che il Cavaliere medesimo arrivato a questo passo vide che il suo ragionamento si piegava, e la punta si disviava, e s’io non erro, quelle parole perfino e del tutto sono la saldatura ch’egli ci volle fare, come tutto giorno si fa, dopo che quello, torcendosegli fra le mani, se gli fu rotto. Ma questa saldatura è veramente di parole, perchè dalle cose precedenti seguita che la poesia non possa nè debba ingannare, e se ella può e deve ingannare, tutti i raziocini susseguenti del Cavaliere e dei romantici, non avendo dove posino, è forza che caschino a terra. Imperocchè non c’è chi non sappia che bisogna distinguere due diversi inganni; l’uno chiameremo intellettuale, l’altro fantastico. Intellettuale è quello per esempio d’un filosofo che vi persuada il falso. Fantastico è quello delle arti belle e della poesia a’ giorni nostri; giacchè non è più quel tempo che la gente si guadagnava il vitto cantando per le borgate e pe’chiassuoli i versi d’Omero, e che tutta la Grecia raunata e seduta in Olimpia ascoltava e ammirava le storie d’Erodoto più soavi del mele, onde poi nel vederlo, l’uno diceva all’altro, mostrandolo a dito: Questi è quegli che ha scritte le guerre di Persia, e lodate le vittorie nostre: ma oggi i lettori o uditori del poeta non sono altro che persone dirozzate e, qual più qual meno, intelligenti: vero è ch’il poeta in certo modo deve far conto di scrivere pel volgo; se bene i romantici pare che vengano a volere per lo contrario ch’egli scriva pel volgo e faccia conto di scrivere per gl’intelligenti, le quali due cose sono contraddittorie, ma quelle che ho detto io, non sono; perchè la fantasia degl’intelligenti può bene, massime leggendo poesie e volendo essere ingannata, quasi discendere e mettersi a paro di quella degl’idioti, laddove la fantasia degl’idioti non può salire e mettersi a paro di quella degl’intelligenti. Ora di questi che ho detto essere i lettori o uditori del poeta, l’intelletto non può essere ingannato dalla poesia, ben può essere ed è ingannata molte volte l’immaginativa. Il Cavaliere dunque e col Cavaliere i romantici, quando gridano che il poeta nel fingere s’adatti ai costumi e alle opinioni nostre e alle verità conosciute presentemente, non guardano che il poeta non inganna gl’intelletti nè gl’ingannò mai, se non per avventura in quei tempi antichissimi che ho detto di sopra, ma solamente le fantasie; non guardano che sapendo noi così tosto come, aperto un libro, lo vediamo scritto in versi, che quel libro è pieno di menzogne, e desiderando e proccurando quando leggiamo poesie, d’essere ingannati e nel metterci a leggere preparando e componendo quasi senz’avvedercene la fantasia a ricevere e accogliere l’illusione, è ridicolo a dire che il poeta non la possa illudere quando non s’attenga alle opinioni e ai costumi nostri, quasi che noi non le dessimo licenza di lasciarsi ingannare più che tanto, e che ella non avesse forza di scordarsi nè il poeta di farle scordare e opinioni e consuetudini e checchessia, non guardano che l’intelletto in mezzo al delirio dell’immaginativa conosce benissimo ch’ella vaneggia, e onninamente e sempre tanto crede al meno falso quanto al più falso, tanto agli Angeli del Milton e alle sostanze allegoriche del Voltaire quanto agli Dei d’Omero, tanto agli spettri del Bürger e alle befane del Southey quanto all’inferno di Virgilio, tanto che un Angelo collo scudo celeste di lucidissimo diamante abbia difeso Raimondo, quanto che Apollo coll’egida
irsuta e fimbriata abbia preceduto Ettore nella battaglia. In somma tutto sta, come ho detto da principio, se la poesia debba illudere o no; se deve, com’è chiaro che deve, e come i romantici affermano spontaneamente, tutto il resto non è altro che parole e sofisticherie e volerci far credere a forza d’argomenti quello che noi sappiamo che non è vero; perchè in fatti sappiamo che il poeta sì come per cristiano e filosofo e moderno che sia in ogni cosa, non c’ingannerà mai l’intelletto, così per pagano e idiota e antico che si mostri, c’ingannerà l’immaginazione ogni volta che fingerà da vero poeta.
Resta perciò che questi potendo illudere come vuole, scelga dentro i confini del verisimile quelle migliori illusioni che gli pare, e quelle più grate a noi e meglio accomodate all’ufficio della poesia, ch’è imitar la natura, e al fine, ch’è dilettare. E sia pure più malagevole a preparare quelle illusioni che ci debbono quasi vestire d’opinioni e consuetudini diverse dalle nostre: non è obbligo nè virtù del poeta lo scegliere assunti facili, ma il fare che paiano facili quelli che ha scelti. Ora bisogna vedere se quel poeta che non va molto dietro alle opinioni e alle usanze d’oggidì, posto che del rimanente sia gran poeta, diletta più o meno gli animi, seconda più o meno la natura e per tanto il buon gusto, di chi tuttavia s’attiene alle cose presenti: imperocchè è manifesto che quella strada la quale conduce al maggiore e sostanziale e sodo e puro e naturale diletto degli uditori, quella senz’altro va tenuta nella poesia, non potendo accadere che questa c’inganni mai altro che l’immaginativa. Ma forse, contuttoch’il volgo, non mica ieri nè ierlaltro, ma da lunghissimo tempo abbia finito di sentire la voce dei poeti, vorranno i romantici che anch’egli debba essere effettivamente uditore o lettore del poeta; e questo mentrechè si sforzano di rendere la poesia quanto più possono astrusa e metafisica e sproporzionata all’intelligenza del volgo. Comunque sia, poniamo che questo possa essere indotto ad ascoltare o leggere i poeti: più facilmente crederò che altri speri di farlo di quello che si possa fare; ma poniamo che sia fatto, e che però anche l’illusione intellettuale sia possibile al poeta: primieramente domando quale delle due sia meglio; o adattandosi alla religione alle opinioni ai costumi e in questa maniera conciliandosi la credenza del popolo, e contuttociò mentendo così per la necessità della poesia; come perchè grandissima parte delle opinioni del popolo è falsa, ingannarlo positivamente, e riempiergli la testa d’errori e di fandonie, e conficcarci meglio quelle che ci sono, e confortarlo alle fanciullaggini, e accrescergli le superstizioni e gli spauracchi, e corroborargli l’ignoranza; o seguendo altre opinioni e costumi, fingere in maniera che il volgo abbia sì bene da tali finzioni quel diletto ch’è il fine della poesia, ma non le creda fuorchè coll’immaginativa, e quindi senza nessun danno. Imperocchè, tratta materia di poesia dalla religione e dalle opinioni e dai costumi presenti, di necessità deve accadere una di queste tre cose; o che il poeta non menta mai, e non sia più poeta; o che mentendo inganni gl’intelletti del volgo, e gli noccia veramente ed empiamente, sopraccaricandolo di credenze vane e malvage, atteso ch’in materia di religione, secondo noi, qualunque credenza falsa è malvagia; o che gl’inganni solamente le immaginative, e da questo (conceduto che possa avvenire, che certo non avverrebbe se non di rarissimo, perchè il volgo per lo più crederebbe da vero) discendo a quello ch’io voleva dire in secondo luogo, cioè che potendo il poeta ingannare le fantasie anche quando non s’attenga alle credenze e agli usi moderni, quello che s’è detto in proposito degl’intelligenti, dee valere anche per gl’idioti; sì che per questi parimente andrebbero scelte quelle finzioni che dilettassero meglio, più o meno che ingannassero, stante ch’il fine della poesia non è l’ingannare ma il dilettare: l’inganno pel poeta è un mezzo, capitalissimo certo, ma basta l’inganno dell’immaginazione, se no nessuno degl’intelligenti sarebbe dilettato dalla poesia, e quell’inganno che può stare col vero e proprio diletto poetico. Queste cose che ho dette del popolo, bisogna intenderle dirittamente, il che avverto perchè quasi pare ch’io tenga contro i romantici che la poesia non debba esser popolare, quando e noi la vogliamo popolarissima, e i romantici la vorrebbero metafisica e ragionevole e dottissima e proporzionata al sapere dell’età nostra del quale il volgo partecipa poco o niente. Ma già ho notato due volte questa contraddizione dei romantici, e di contraddizioni la nuova filosofia ne ribocca; talmente che forse in progresso mi toccherà qualche altra volta di combattere due opinioni contrarie, l’una delle quali s’avvicini alla nostra, e se il lettore non ci guarderà molto per minuto, gli dovrà parere ch’io combatta me medesimo. Ora cerchiamo quello che ho detto, cioè quale delle due maniere sia più naturale nella poesia e più sodamente dilettevole tanto agl’intelligenti che agl’idioti, voglio dire o l’antica o la moderna.
E l’esperienza e la conversazione scambievole e lo studio e mille altre cagioni che non occorre dire, ci hanno fatti col tempo tanto diversi da quei nostri primi padri che se questi risuscitassero, si può credere che a stento ci ravviserebbero per figli loro. Laonde non è maraviglia se noi così pratici e dotti e così cambiati come siamo, ai quali è manifesto quello che agli antichi era occulto, e noto un mondo di cagioni che agli antichi era ignoto, e certo quello che agli antichi era incredibile, e vecchio quello che agli antichi era nuovo, non guardiamo più la natura ordinariamente con quegli occhi, e nei diversi casi della vita nostra appena proviamo una piccolissima parte di quegli effetti che le medesime cagioni partorivano ne’ primi padri. Ma il cielo e il mare e la terra e tutta la faccia del mondo e lo spettacolo della natura e le sue stupende bellezze furono da principio conformate alle proprietà di spettatori naturali: ora la condizione naturale degli uomini è quella d’ignoranza; ma la condizione degli scienziati che contemplando le stelle, sanno il perchè delle loro apparenze, e non si maravigliano del lampo nè del tuono, e contemplando il mare e la terra, sanno che cosa racchiuda la terra e che cosa il mare, e perchè le onde s’innoltrino e si ritirino, e come soffino i venti e corrano i fiumi e quelle piante crescano e quel monte sia vestito e quell’altro nudo, e che conoscono a parte a parte gli affetti e le qualità umane, e le forze e gli ordigni più coperti e le attenenze e i rispetti e le corrispondenze del gran composto universale, e secondo il gergo della nuova disciplina le armonie della natura e le analogie e le simpatie, è una condizione artificiata: e in fatti la natura non si palesa ma si nasconde, sì che bisogna con mille astuzie e quasi frodi, e con mille ingegni e macchine scalzarla e pressarla e tormentarla e cavarle di bocca a marcia forza i suoi segreti: ma la natura così violentata e scoperta non concede più quei diletti che prima offeriva spontaneamente. E quello che dico degli scienziati dico proporzionatamente più o meno di tutti gl’inciviliti, e però di noi, massime di quella parte di noi che non è plebe, e tra la plebe di quella parte ch’è cittadina, e di qualunque è più discosto dalla condizione primitiva e naturale degli uomini. Non contendo già dell’utile, nè mi viene pure in mente di gareggiare con quei filosofi che piangono l’uomo dirozzato e ripulito e i pomi e il latte cambiati in carni, e le foglie d’alberi e le pelli di bestie rivolte in panni, e le spelonche e i tuguri in palazzi, e gli eremi e le selve in città: non è del poeta ma del filosofo il guardare all’utile e al vero: il poeta ha cura del dilettoso, e del dilettoso alla immaginazione, e questo raccoglie così dal vero come dal falso, anzi per lo più mente e si studia di fare inganno, e l’ingannatore non cerca il vero ma la sembianza del vero. Le bellezze dunque della natura conformate da principio alle qualità ed ordinate al diletto di spettatori naturali, non variano pel variare de’ riguardanti, ma nessuna mutazione degli uomini indusse mai cambiamento nella natura, la quale vincitrice dell’esperienza e dello studio e dell’arte e d’ogni cosa umana mantenendosi eternamente quella, a volerne conseguire quel diletto puro e sostanziale ch’è il fine proprio della poesia (giacchè il diletto nella poesia scaturisce dall’imitazione della natura), ma che insieme è conformato alla condizione primitiva degli uomini, è necessario che, non la natura a noi, ma noi ci adattiamo alla natura, e però la poesia non si venga mutando, come vogliono i moderni, ma ne’ suoi caratteri principali, sia, come la natura, immutabile. E questo adattarsi degli uomini alla natura, consiste in rimetterci coll’immaginazione come meglio possiamo nello stato primitivo de’ nostri maggiori, la qual cosa ci fa fare senza nostra fatica il poeta padrone delle fantasie. Ora che così facendo noi, ci s’apra innanzi una sorgente di diletti incredibili e celesti, e che la natura invariata e incorrotta discopra allora non ostante l’incivilimento e la corruzione nostra il suo potere immortale sulle menti umane, e che in somma questi diletti sieno anche oggidì quelli che noi pendiamo naturalmente a desiderare sopra qualunque altro quando ci assettiamo ad essere ingannati dalla poesia, di leggeri si può comprendere, sol tanto che, oltre il fatto medesimo, si ponga mente alla nostra irrepugnabile inclinazione al primitivo, e al naturale schietto e illibato, la quale è per modo innata negli uomini, che gli effetti suoi perchè sono giornalieri non si considerano, e accade in questa come in mille altre cose, che la frequenza impedisce l’attenzione. Ma da quale altra fonte derivano e il nostro infinito affetto alla semplicità de’ costumi e delle maniere e del favellare e dello scrivere e d’ogni cosa; e quella indicibile soavità che ci diffonde nell’anima non solamente la veduta ma il pensiero e le immagini della vita rustica, e i poeti che la figurano, e la memoria de’ primi tempi, e la storia de’ patriarchi e di Abramo e d’Isacco e di Giacobbe e dei casi e delle azioni loro ne’ deserti e della vita nelle tende e fra gli armenti, e quasi tutta quella che si comprende nella Scrittura e massimamente nel libro della Genesi; e quei moti che ci suscita e quella beatitudine che ci cagiona la lettura di qualunque poeta espresse e dipinse meglio il primitivo, di Omero di Esiodo di Anacreonte di Callimaco singolarmente? E quelle due capitali disposizioni dell’animo nostro, l’amore della naturalezza e l’odio dell’affettazione, l’uno e l’altro ingeniti, credo, in tutti gli uomini, ma gagliardissimi ed efficacissimi in chiunque ebbe dalla natura indole veramente accomodata alle arti belle, provengono parimente dalla nostra inclinazione al primitivo. E questa medesima fa che qualora ci abbattiamo in oggetti non tocchi dall’incivilimento, quivi e in ogni reliquia e in ogni ombra della prima naturalezza, quasi soprastando, giocondissimamente ci compiacciamo con indistinto desiderio; perchè la natura ci chiama e c’invita, e se ricusiamo, ci sforza, la natura vergine e intatta, contro la quale non può sperienza nè sapere nè scoperte fatte nè costumi cambiati nè coltura nè artifizi nè ornamenti, ma nessuna nè splendida nè grande nè antica nè forte opera umana soverchierà mai nè pareggerà, non che altro, un vestigio dell’opera di Dio. E che questo che ho detto, sia vero, chi è di noi, non dico poeta non musico non artefice non d’ingegno grande e sublime, dico lettore di poeti e uditore di musici e spettatore d’artefici, dico qualunque non è così guasto e disumanato e snaturato che non senta più la forza di nessuna fuorchè lorda o bassa inclinazione umana e naturale, — chi è che non lo sappia e non lo veda e non lo senta e non lo possa confermare col racconto dell’esperienza propria certissima e frequentissima? E se altri mancano, chiamo voi, Lettori, in testimonio, chiamo voi stesso o Cavaliere: non può mancare a voi quell’esperienza ch’io cerco, non può ignorare il cuor vostro quei moti ch’io dico, non può essere che la natura incorrotta, che il primitivo, che la candida semplicità, che la lezione de’ poeti antichi non v’abbia inebbriato mille volte di squisitissimo diletto; voi fatemi fede che come le forme primitive della natura non sono mutate nè si muteranno, così l’amore degli uomini verso quelle non è spento nè si spegnerà prima della stirpe umana. Ma che vo io cercando cose o minute o scure o poco note, potendo dirne una più chiara della luce, e notissima a chicchessia, della quale ciascuno, ancorchè non apra bocca, mi debba essere testimonio? Imperocchè quello che furono gli antichi, siamo stati noi tutti, e quello che fu il mondo per qualche secolo, siamo stati noi per qualche anno, dico fanciulli e partecipi di quella ignoranza e di quei timori e di quei diletti e di quelle credenze e di quella sterminata operazione della fantasia; quando il tuono e il vento e il sole e gli astri e gli animali e le piante e le mura de’ nostri alberghi, ogni cosa ci appariva o amica o nemica nostra, indifferente nessuna, insensata nessuna; quando ciascun oggetto che vedevamo ci pareva che in certo modo accennando, quasi mostrasse di volerci favellare; quando in nessun luogo soli, interrogavamo le immagini e le pareti e gli alberi e i fiori e le nuvole, e abbracciavamo sassi e legni, e quasi ingiuriati malmenavamo e quasi beneficati carezzavamo cose incapaci d’ingiuria e di benefizio; quando la maraviglia tanto grata a noi che spessissimo desideriamo di poter credere per poterci maravigliare, continuamente ci possedeva; quando i colori delle cose quando la luce quando le stelle quando il fuoco quando il volo degl’insetti quando il canto degli uccelli quando la chiarezza dei fonti tutto ci era nuovo o disusato, nè trascuravamo nessun accidente come ordinario, nè sapevamo il perchè di nessuna cosa, e ce lo fingevamo a talento nostro, e a talento nostro l’abbellivamo; quando le lagrime erano giornaliere, e le passioni indomite e svegliatissime, nè si reprimevano forzatamente e prorompevano arditamente. Ma qual era in quel tempo la fantasia nostra, come spesso e facilmente s’infiammava, come libera e senza freno, impetuosa e istancabile spaziava, come ingrandiva le cose piccole, e ornava le disadorne, e illuminava le oscure, che simulacri vivi e spiranti che sogni beati che vaneggiamenti ineffabili che magie che portenti che paesi ameni che trovati romanzeschi, quanta materia di poesia, quanta ricchezza quanto vigore quant’efficacia quanta commozione quanto diletto. Io stesso mi ricordo di avere nella fanciullezza appreso coll’immaginativa la sensazione d’un suono così dolce che tale non s’ode in questo mondo; io mi ricordo d’essermi figurate nella fantasia, guardando alcuni pastori e pecorelle dipinte sul cielo d’una mia stanza, tali bellezze di vita pastorale che se fosse conceduta a noi così fatta vita, questa già non sarebbe terra ma paradiso, e albergo non d’uomini ma d’immortali; io senza fallo (non m’imputate a superbia, o Lettori, quello che sto per dire) mi crederei divino poeta se quelle immagini che vidi e quei moti che sentii nella fanciullezza, sapessi e ritrargli al vivo nelle scritture e suscitarli tali e quali in altrui. Ora che la memoria della fanciullezza e dei pensieri e delle immaginazioni di quell’età ci sia straordinariamente cara e dilettevole nel progresso della vita nostra, non voglio nè dimostrarlo nè avvertirlo: non è uomo vivo che non lo sappia e non lo provi alla giornata, e non solamente lo provi, ma se ne sia formalmente accorto, e purch’abbia filo d’ingegno e di studio, se ne sia maravigliato. Ecco dunque manifesta e palpabile in noi, e manifesta e palpabile a chicchessia la prepotente inclinazione al primitivo, dico in noi stessi, cioè negli uomini di questo tempo, in quei medesimi ai quali i romantici proccurano di persuadere che la maniera antica e primitiva di poesia non faccia per loro. Imperocchè dal genio che tutti abbiamo alle memorie della puerizia si deve stimare quanto sia quello che tutti abbiamo alla natura invariata e primitiva, la quale è nè più nè meno quella natura che si palesa e regna ne’ putti, e le immagini fanciullesche e la fantasia che dicevamo, sono appunto le immagini e la fantasia degli antichi, e le ricordanze della prima età e le idee prime nostre che noi siamo così gagliardamente tratti ad amare e desiderare, sono appunto quelle che ci ridesta l’imitazione della natura schietta e inviolata, quelle che ci può e secondo noi ci deve ridestare il poeta, quelle che ci ridestano divinamente gli antichi, quelle che i romantici bestemmiano e rigettano e sbandiscono dalla poesia, gridando che non siamo più fanciulli: e pur troppo non siamo; ma il poeta deve illudere, e illudendo imitar la natura, e imitando la natura dilettare: e dov’è un diletto poetico altrettanto vero e grande e puro e profondo? e qual è la natura se questa non è? anzi qual è o fu mai fuorchè questa?
Nelle usanze e nelle opinioni e nel sapere del tempo nostro cercheremo la natura e le illusioni? Che natura o che leggiadra illusione speriamo di trovare in un tempo dove tutto è civiltà, e ragione e scienza e pratica e artifizi; quando non è luogo nè cosa che abbia potuto essere alterata dagli uomini, in cui la natura primitiva apparisca altrimenti che a somiglianza di lampo rarissimo, dovunque coperta e inviluppata come nel più grosso e fitto panno che si possa pensare; quando la maraviglia è vergogna; quando non è quasi specie non forma non misura non effetto non accidente menomissimo di passione ch’altri non abbia avvertito e non avverta ed esplori e distingua e smidolli; quando il cuor nostro o disingannato dall’intelletto non palpita, o se anche palpita, corre tosto l’intelletto a ricercargli e frugargli tutti i segreti di questo palpito, e svanisce ogn’illusione svanisce ogni dolcezza svanisce ogni altezza di pensieri; quando si spiano e s’uccellano gli andamenti dell’animo nostro non altrimenti che i cacciatori facciano le salvaggine; quando gli affetti i moti i cenni i diversi casi del cuore e della volontà umana si prevedono e predicono come fanno gli astronomi le apparenze delle stelle e il ritorno delle comete; quando non è persona d’ingegno alquanto vivo ed esercitato che non conosca l’indole e i pregi e i difetti propri, e non sappia descrivere le cagioni de’ fatti e de’ pensieri suoi, e discutere le speranze e i timori della sua vita futura, e pronosticare di se medesimo e delle vicende del cuor suo; quando la scienza dell’animo umano già certa e quasi matematica e risolutamente analitica, secondo l’idioma scolastico de’ moderni, per poco non s’espone con angoli e cerchi, e non si tratta per computi e formole numerali? La vicendevole fratellanza delle scienze e delle arti, i miracoli dell’industria, l’esperienze le scoperte gli effetti dell’incivilimento daranno lena, secondochè dice il Cavaliere, alla fantasia? quelle cose che l’affogano l’avviveranno? la ragione ch’a ogni poco la mette in fuga e la perseguita e l’assalisce e quasi la sforza a confessare ch’ella sogna, l’esperienza che l’assedia e la stringe e le oppone al volto la sua molestissima lucerna, la scienza che le contrasta e le sbarra tutti i passi col vero, queste cose alimenteranno e conforteranno l’immaginativa? Non le angustie, non le carceri non le catene danno baldanza alla fantasia, ma la libertà, nè per lei sono campi le scienze nè i ritrovati, ma d’ordinario fossi ed argini, nè la molta luce del vero può far bene a quella ch’è vaneggiatrice per natura, nè di quelle cose onde s’arricchisce l’intelletto, s’arricchisce la fantasia già sterminatamente ricca per se stessa; ma la sua prima e somma ricchezza consiste nella libertà, ed il vero conosciuto ed il certo hanno per natura di togliere la libertà d’imaginare. E se il fatto stesse come vogliono i romantici, il confine dell’immaginativa sarebbe ristrettissimo ne’ fanciulli, e s’allargherebbe a proporzione che l’intelletto venisse acquistando; ma per lo contrario avviene ch’egli ne’ putti sia distesissimo, negli adulti mezzano, ne’ vecchi brevissimo. Laonde, come vediamo chiarissimamente in ciascuno di noi che il regno della fantasia da principio è smisurato, poi tanto si va ristringendo quanto guadagna quello dell’intelletto, e finalmente si riduce quasi a nulla, così nè più nè meno è accaduto nel mondo; e la fantasia che ne’ primi uomini andava liberamente vagando per immensi paesi, a poco a poco dilatandosi l’imperio dell’intelletto, vale a dire crescendo la pratica e il sapere, fugata, e scacciata dalle sue terre antiche, e sempre incalzata e spinta, alla fine s’è veduta, come ora si vede, stipata e imprigionata e pressoch’immobile: e in questa sua condizione, o Lettori, la chiamano i romantici, la chiama il Cavaliere beatissima, e padrona di vastissimi regni. Non però va creduto, come pare che molti facciano, che col tempo sia scemata all’immaginazione la forza, e venga scemando tuttavia secondochè s’aumenta il dominio dell’intelletto: non la forza ma l’uso dell’immaginazione è scemato e scema; il quale e negli antichi nè per giovanezza nè per maturità nè per vecchiezza non s’allentava mai più che un poco, e in noi, come piglia piede la signoria dell’intelletto, così va calando finattantoch’in ultimo quasi manca. Resta la forza ma oziosa, restano i campi per li quali soleva esercitarsi la foga della fantasia, ma chiusi dai ripari dell’intelletto: a volere che l’immaginazione faccia presentemente in noi quegli effetti che facea negli antichi, e fece un tempo in noi stessi, bisogna sottrarla dall’oppressione dell’intelletto, bisogna sferrarla e scarcerarla, bisogna rompere quei recinti: questo può fare il poeta, questo deve; non contenerla dentro le stesse angustie e fra le stesse catene e nella stessa schiavitù, secondo la portentosa dottrina romantica: e ogni volta che l’immaginativa è rimessa da un vero poeta nella condizione che ho detto, chiamo il mondo in testimonio dell’attività ch’ella palesa in questo medesimo tempo nelle medesime nostre menti.