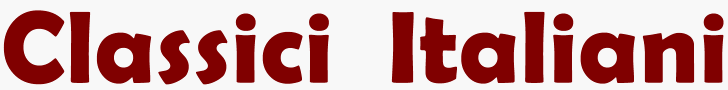Giovanni Berchet.
Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo
1816.
M’ha fatto maraviglia davvero che tu, convittore di un collegio, ti dessi a cercarmi con desiderio cosí vivo una traduzione italiana di due componimenti poetici del Bürger. Che posso io negare al figliuolo mio? Povero vecchio inesercitato, ho penato assai a tradurli; ma pur finalmente ne sono venuto a capo.
È l’incipit dell’opera che reca la data del 1816, quando sul campo della letteratura infuria il duello tra i sostenitori del Classicismo e i sostenitori del Romanticismo. Considerato – forse più allora che oggi – il vero e proprio manifesto del Romanticismo italiano; l’autore è un poeta e scrittore originario di Milano, che in gioventù ha dato il meglio di sè soprattutto come traduttore: Giovanni Berchet.
Note
Diritti d’autore: no
Edizione di riferimento: Giovanni Berchet, Lettera semiseria, Scritti scelti di critica e di polemica, Collana GUM, Mursia, Milano 1977.
Link esterni
Biografia di Giovanni Berchet (da milanosifastoria)
Figliuolo Carissimo,
M’ha fatto meraviglia davvero che tu, Convittore di un Collegio, ti dessi a cercarmi con desiderio cosí vivo una traduzione italiana di due componimenti poetici del Bürger.
Che posso io negare al figliuolo mio? Povero vecchio inesercitato, ho penato assai a tradurli; ma pur finalmente ne sono venuto a capo.
In tanta condiscendenza non altro mi stava a cuore che di farti conoscere il Bürger; però non mi resse l’animo di alterare con colori troppo italiani i lineamenti di quel Tedesco: e la traduzione è in prosa. Tu vedi che anche col fatto io sto saldo alle opinioni mie; e la verità è che gli esempi altrui mi ribadiscono ogni dí piú questo chiodo. Non è, per altro, ch’io intenda dire che tutto tuttoquanto di poetico manda una lingua ad un’altra, s’abbia da questa a tradurre in prosa. Nemico giurato di qualunque sistema esclusivo, riderei di chi proponesse una legge siffatta, come mi rido di Voltaire che voleva che i versi fossero da tradursi sempre in versi. Le ragioni che devono muovere il traduttore ad appigliarsi più a l’uno che all’altro partito stanno nel testo e variano a seconda della diversa indole e della diversa provenienza di quello.
Tutti i popoli che più o meno hanno lettere, hanno poesia. Ma non tutti i popoli posseggono un linguaggio poetico separato dal linguaggio prosaico. I termini convenzionali per l’espressione del bello non sono da per tutto i medesimi. Come la squisitezza nel modo di sentire, così anche l’ardimento nel modo di dichiarare poeticamente le sensazioni, è determinato presso di ciaschedun popolo da accidenti dissimili. E quella spiegazione armoniosa di un concetto poetico, che sarà sublime a Londra od a Berlino, riescirà non di rado ridicola, se ricantata in Toscana.
Ché se tu mi lasci il concetto straniero, ma per servire alle inclinazioni della poesia della tua patria me lo vesti di tutti panni italiani e troppo diversi da’ suoi nativi, chi potrà in coscienza salutarti come autore, chi ringraziarti come traduttore?
Colla prosa la faccenda è tutt’altra; da che allora il lettore non si dimentica un momento mai che il libro ch’ei legge è una traduzione; e tutto perdona in grazia del gusto ch’egli ha nel fare amicizia con genti ignote, e nello squadrarle da capo a piedi tal quali sono. Il lettore, quand’ha per le mani una traduzione in verso, non sempre può conseguire intera una tale soddisfazione. La mente di lui, divisa in due, ora si rivolge a raffigurare l’originalità del testo, ora a pesare quanta sia l’abilità poetica del traduttore. Queste due attenzioni non tirano innanzi molto così insieme; e la seconda per io più vince; perché l’altra, come quella che è la meno direttamente adescata e la meno contentata, illanguidisce. Ed è allora che chi legge si fa schizzinoso di più; e come se esaminasse versi originali italiani, ti crivella le frasi fino allo scrupolo.
Chi porrà mente alle circostanze differenti che rendono differente il modo di concepire le idee e verrà investigando le origini delle varie lingue e letterature, troverà che i popoli, anche per questo lato, hanno tra di loro de` gradi maggiori o minori di parentela. Da ciò deriverà al traduttore tanto lume che basti per metter lui sulla buona via, ov’egli abbia intenzione conforme all’obbligo che gli corre: quella cioè di darci a conoscere il testo, non di regalarcene egli uno del suo.
Il sig. Bellotti imprese a tradurre Sofocle; e prima ancora che comparisse in luce quell’esimio lavoro, chi sognò mai ch’egli si fosse ingannato nella scelta del mezzo, per aver pigliato a condurre in versi la sua traduzione? Per lo contrario, vedi ora, figliuolo mio, se io ti abbia vaticinato il falso quando ti parlai tempo fa d’una traduzione del Teatro di Shakespeare, prossima allora ad uscire in Firenze. Il sig. Leoni ha ingegno, anima, erudizione, acutezza di critica, disinvoltura di lingua italiana, cognizione molto di lingua inglese, tutti, insomma, i requisiti per essere un valente traduttore di Shakespeare. Ma il sig. Leoni l’ha sbagliata. I suoi versi sono buoni versi italiani. Ma che vuoi? Shakespeare è svisato; e noi siamo tuttavia costretti ad invidiare ai Francesi il loro Le Tourneur. E sí che il sig. Leoni bastava a smorzarcela affatto questa invidia!
Di quanti altri puntelli potrebbesi rinfiancare questo argomento lo sa Dio. Ma perché sbracciarmi a dimostrare che il fuoco scotta? Chi s’ostina a negarlo, buon pro per lui!
E non occorre dire che la lingua nostra non si pieghi ad una prosa robusta, elegante, snella, tenera quanto la francese. La lingua italiana non la sapremo maneggiare con bella maniera né io, né tu; perché tu sei un ragazzotto, ed io un vecchio dabbene e nulla più; ma fa ch’ella trovi un artefice destro ed è materia da cavarne ogni costrutto. Ma questa materia non istà tutta negli scaffali delle biblioteche. Ma non là solamente la vanno spolverando quei pochi cervelli acuti che non aspirano alla fama di messer lo Sonnifero.
In Italia qualunque libro non triviale esca in pubblico, incontra bensì qua e là qualche drappelletto minuto di scrutinapensieri, che pure non lo spaventano mai con brutto viso, perché genti di lor natura savie e discrete. Ma, poveretto! eccolo poi dar nel mezzo ad un esercito di scrutinaparole, infinito, inevitabile, e sempre all’erta, e prodigo sempre d’anatemi. Però io, non avuto riguardo per ora alla fatica che costano i bei versi a tesserli, confesso che qui tra noi, per rispetto solamente alla lingua, chiunque si sgomenta de` latrati dei pedanti piglia impresa meno scabra d’assai se scrive in versi e non in prosa. Confesso che, per rispetto solamente alla ligua e non ad altro, tanto nel tradurre come nel comporre di getto originale, il montar su’ trampoli e verseggiare costa meno pericoli. Confesso che allo scrittore di prose bisogno studiare e: libri e uomini e usanze; perocché altro è lo stare ristretto a’ confini determinati di un linguaggio poetico, altro è lo spaziarsi per l’immenso mare di una lingua tanto lussuriante ne’ modi, e viva e parlata ed alla quale non si può chiudere il Vocabolario, se prima non le si fanno le esequie .Ma lo specifico vero per salire in grido letterario è forse l’impigrire colle mani in mano, e l’inchiodar sé stessi sul Vocabolario della Crusca, come il Giudeo inchioda sul travicello i suoi paperi perché ingrassino? No no, figliuolo mio, la penuria che oggidí noi abbiamo di belle prose non proviene, grazie a Dio, da questo che la lingua nostra non sia lingua che da sonetti. Fa che il tuo padre spirituale ti legga la parabola dei talenti nell’Evangelista; e la santa parola con quel «serve male et piger» ti snebbierà questo fenomeno morale. Ora, per dire di ciò che importa a te, sappi, o carissimo, che i Lirici Tedeschi piú rinomati, parlo della scuola moderna, sono tre: il Goethe, lo Schiller e il Bürger. Quest’ultimo dotato di un sentire dilicato, ma d’una immaginazione altresí arditissima, si piacque spesso di trattare il terribile. Egli scrisse altre poesie sull’andare del Cacciatore Feroce e della Eleonora; ma queste due sono le piú famose. Io credo di doverle chiamare Romanzi: e se il vocabolo spiacerà ai dotti d’Italia, non farò per questo a scappellotti colle signorie loro.
Poesie di simil genere avevano i Provenzali; bellissime piú di tutti e molte ne hanno gli Inglesi; ne hanno gli Spagnuoli; altre e d’altri autori i Tedeschi; i Francesi le coltivavano un tempo; gli Italiani, ch’io sappia, non mai: se pure non si ha a tener conto di leggende in versi, congegnate, non da’ poeti letterati, ma dal volgo, e cantate da lui; fra le quali quella della Samaritana meriterebbe forse il primato per la fortuna di qualche strofetta. Non pretendo con ciò di menomare d’un pelo la reputazione di alcuni Romanzi in dialetti municipali; perché, parlando di letteratura italiana, non posso aver la mira che alla lingua universale d’Italia. [1]
Il Bürger portava opinione che «la sola vera poesia fosse la popolare». Quindi egli studiò di derivare i suoi poemi quasi sempre da fonti conosciute, e di proporzionarli poi sempre con tutti i mezzi dell’arte alla concezione del popolo. Anche delle composizioni che ti mando oggi tradotte, l’argomento della prima è ricavato da una tradizione volgare; quello della seconda è inventato, imitando le tradizioni comuni in Germania; il che vedremo in seguito piú distesamente. Anche in entrambi questi componimenti v’ha una certa semplicità di narrazione che manifesta nel poeta il proponimento, di gradire alla moltitudine.
Forse il Bürger, com’è destino talvolta degli uomini d’alto ingegno, trascorreva in quella sua teoria agli estremi.
Ma perché i soli uomini d’alto ingegno sanno poi di per sé stessi ritenersene giudiziosamente nella pratica, noi, leggendo i versi del Bürger, confessiamo che neppure il dotto vi scapita, né ha ragione di dolersi del poeta. L’opinione nondimeno che la poesia debba essere popolare non albergò solamente presso del Bürger; ma a lei s’accostarono pur molto anche gli altri poeti sommi d’una parte della Germania. Né io credo d’ingannarmi dicendo ch’ella pende assai nel vero. E se, applicandola alla storia dell’arte e pigliandola per codice nel far giudizio delle opere dei poeti che furono, ella può sembrare troppo avventata – giacché al Petrarca, a modo d’esempio, ed al Parini, benché, rade volte popolari, bisogna, pur fare di cappello – parmi che, considerandola come consiglio a’ poeti che sono ed ammettendola con discrezione, ella sia santissima. E dico cosi, non per riverenza servile a’ Tedeschi ed agli Inglesi, ma per libero amore dell’arte e per desiderio che tu, nascente poeta d’Italia, non abbia a dare nelle solite secche che da qualche tempo in qua impediscono il corso agli intelletti e trasmutano la poesia in matrona degli sbadigli.
Questa è la precipua cagione per la quale ho determinato che tu smetta i libri del Blair, del Villa e de’ loro consorti, tosto che la barba sul mento darà indizio di senno in te piú maturo. Allora avrai da me danaro per comperartene altri, come a dire del Vico, del Burke, del Lessing, del Bouterweck, [2] dello Schiller, del Beccaria, di Madama de Staël, dello Schlegel e d’altri che fin qui hanno pensate e scritte cose appartenenti alla Estetica: né il Platone in Italia del Consigliere Cuoco sarà l’ultimo dei doni ch’io ti farò. Ma per ora non dir nulla di questo co’ maestri tuoi, che già non t’intenderebbono.
Tuttavolta, perché la massima della popolarità della poesia mi preme troppo che la si faccia carne e sangue in te, contentati ch’io m’ingegni fin d’ora di dimostrartene la convenienza cosí appena di volo, e come meglio può un vecchiarello che non fu mai in vita sua né poeta né filologo né filosofo.
Tutti gli uomini, da Adamo in giú fino al calzolaio che ci fa i begli stivali, hanno nel fondo dell’anima una tendenza alla Poesia. Questa tendenza, che in pochissimi è attiva, negli altri non è che passiva; non è che una corda che risponde con simpatiche oscillazioni al tocco della prima. La natura, versando a piene mani i suoi doni nell’animo di que’ rari individui ai quali ella concede la tendenza poetica attiva, pare che si compiaccia di crearli differenti affatto dagli altri uomini in mezzo a cui li fa nascere. Di qui le antiche favole sulla quasi divina origine de’ poeti, e gli antichi pregiudizi sui miracoli loro, e l’«est Deus in nobis». Di qui il piú vero dettato di tutti i filosofi; che i Poeti fanno classe a parte, e non sono cittadini di una sola società ma dell’intero universo. E per verità chi misurasse la sapienza delle nazioni dalla eccellenza de’ loro poeti, parmi che non iscandaglierebbe da savio. Né savio terrei chi nelle dispute letterarie introducesse i rancori e le rivalità nazionali. Omero, Shakespeare, il Calderon, il Camoens, il Racine, lo Schiller per me sono italiani di patria tanto quanto Dante, l’Ariosto e l’Alfieri.
La repubblica delle lettere non è che una, e i poeti ne sono concittadini tutti indistintamente. La predilezione con cui ciascheduno di essi guarda quel tratto di terra ove nacque, quella lingua che da fanciullo imparò, non nuoce mai, né alla energia dell’amore che il vero poeta consacra per istinto dell’arte sua a tutta insieme la umana razza, né alla intensa volontà, per la quale egli studia colle opere sue di provvedete al diletto ed alla educazione di tutta insieme l’umana razza. Però questo amore universale, che governa l’intenzione de’ poeti, mette universalmente nella coscienza degli uomini l’obbligo della gratitudine e del rispetto; e nessuna occasione politica può sciogliere noi da questo sacro dovere. Fin anche l’ira della guerra rispetta la tomba d’Omero e la casa di Pindaro.
Il poeta, dunque, sbalza fuori dalle mani della natura in ogni tempo, in ogni luogo. Ma per quanto esimio egli sia, non arriverà mai a scuotere fortemente l’animo de’ lettori suoi, né mai potrà ritrarne alto e sentito applauso, se questi non sono ricchi anch’essi della tendenza poetica passiva. Ora siffatta disposizione degli animi umani, quantunque universale, non è in tutti gli uomini egualmente squisita.
Lo stupido Ottentoto, sdraiato sulla soglia della sua capanna, guarda i campi di sabbia che la circondano, e s’addormenta. Esce de’ suoi sonni, guarda in alto, vede un cielo uniforme stenderseli sopra del capo, e s’addormenta. Avvolto perpetuamente tra il fumo del suo tugurio e il fetore delle sue capre, egli non ha altri oggetti, dei quali domandare alla propria memoria l’immagine, pe’ quali il cuore gli batta di desiderio. Però alla inerzia della fantasia e del cuore in lui tiene dietro di necessità quella della tendenza poetica.
Per lo contrario un Parigino agiato ed ingentilito da tutto il lusso di quella gran capitale, onde pervenire a tanta Civilizzazione, è passato attraverso una folla immensa di oggetti, attraverso mille e mille combinazioni di accidenti. Quindi la fantasia di lui è stracca, il cuore allentato per troppo esercizio. Le apparenze esterne delle cose non lo lusingano (per cosí dire); gli effetti di esse non lo commuovono piú, perché ripetuti le tante volte. E per togliersi di dosso la noia, bisogna a lui investigare le cagioni, giovandosi della mente. Questa sua mente inquisitiva cresce di necessità in vigoria, da che l’anima a pro di lei spende anche gran parte di quelle forze che in altri destina alla fantasia ed al cuore, cresce in arguzie per gli sforzi frequenti a’ quali la meditazione la costringe. E il Parigino di cui io parlo, anche senza avvedersene, viene assuefacendosi a perpetui raziocini, o per dirla a modo del Vico, diventa filosofo.
Se la stupidità dell’Ottentoto è nemica alla poesia, non è certo favorevole molto a lei la somma civilizzazione del Parigino. Nel primo la tendenza poetica è sopita; nel secondo è sciupata in gran parte. I canti del poeta non penetrano nell’anima del primo, perché non trovano la via d’entrarvi. Nell’anima del secondo appena appena discendono accompagnati da paragoni e da raziocini: la fantasia ed il cuore non rispondono loro che come a reminiscenze lontane. E siffatti canti, che sono l’espressione arditissima di tutto ciò che v’ha di piú fervido nell’umano pensiero, potranno essi trovar fortuna fra tanto gelo? E che meraviglia se presso del Parigino ingentilito quel poeta sarà piú bene accolto che piú penderà all’epigrammatico?
Ma la stupidità dell’Ottentoto è separata dalla leziosaggine del Parigino fin ora descritto per mezzo di gradi moltissimi di civilizzazione che piú o meno dispongono l’uomo alla poesia. E s’io dovessi indicare uomini che piú si trovino oggidí in questa disposizione poetica, parmi che andrei a cercarli in una parte della Germania. A consolazione, non pertanto, de’ poeti, in ogni terra, ovunque è coltura intellettuale, vi hanno uomini capaci di sentire poesia. Ve n’ha bensí in copia ora maggiore ora minore, ma tuttavia sufficiente sempre. Ma fa d’uopo conoscerli e ravvisarli ben bene, e tenerne conto. Ma il poeta non si accorgerà mai della loro esistenza, se per rinvenirli visita le ultime casipole della plebe affamata, e di là salta a dirittura nelle botteghe da caffè, ne’ gabinetti delle Aspasie nelle corti dei Principi, e nulla piú. Ad ogni tratto egli rischierà, di cogliere in iscambio la sua patria, ora credendola il Capo di Buona Speranza, ora il Cortile del Palais-Royal. E dell’indole dei suoi concittadini egli non saprà mai un ette.
Che s’egli considera che la sua nazione non la compongono que’ dugento che gli stanno intorno nelle veglie o ne’ conviti; se egli ha mente a questo, che mille e mille famiglie pensano, leggono, scrivono, piangono, fremono, e sentono le passioni tutte, senza pure avere un nome ne’ teatri, può essere che a lui si schiarisca innanzi un altro orizzonte; può essere che egli venga accostandosi ad altri pensieri ed a piú vaste intenzioni.
L’annoverare qui gli accidenti fisici propizi o a i versi alla tendenza poetica; il dire minutamente come questa, del pari che la virtú morale, possa essere aumentata o ristretta in una nazione dalla natura delle instituzioni civili, delle leggi religiose e di altre circostanze politiche, non fa all’intendimento mio. Te ne discorreranno, o carissimo, a tempo opportuno, i libri ch’io ti presterò. Basti a te per ora il sapere che tutte le presenti nazioni d’Europa (l’italiana anch’essa, né piú né meno)sono formate da tre classi d’individui: l’una di Ottentoti; l’una di Parigini; e l’una, per ultimo, che comprende tutti gli altri individui leggenti ed ascoltanti, non, eccettuati quelli che, avendo anche studiato ed esperimentato quant’altri, pur tuttavia ritengono attitudine alle emozioni. A questi tutti io do nome di popolo.
Della Prima classe, che è quella dei balordi calzati e scalzi, non occorre far parole. La seconda, che racchiude in sé quei pochi, I quali escono della comune in modo da perdere ogni impronta nazionale, vuole bensí essere rispettata dal poeta, ma non idolatrata, ma non temuta. Il giudizio che i membri di questa classe fanno delle moderne opere poetiche, non suole derivare dal suffragio immediato delle sensazioni, ma da’ confronti. Negli anni del fervore eglino hanno trovato il bello presso tale e tal altro poeta; e ciò che non somiglia al bello sentito un tempo, pare loro di doverlo ora ricusare. Le opinioni scolastiche, i precetti bevuti pigramente un tempo come infallibili, reggono tuttavia il loro intelletto, che non li mise mai ad esame, perché d’altro curante. Però l’orgoglio umano, a cui è duro il dover discendere a discredere ciò che per molti anni s’è creduto, il piú delle volte li fa tenaci delle massime inveterate. E il piú delle volte eglino combattono per esse come per l’antemurale della loro riputazione. Allora ogni arme, ogni scudo giova. E perché una serie di secoli non si brigò piú che tanto di discutere l’importanza di quelle massime, eccoti in campo un bell’argomento di difesa nel silenzio delle generazioni. Chi tace non parla, diciamo noi. Ma chi tace approva, dicono essi; e il sopore dei secoli lo vanno predicando come consenso assoluto di tutta quanta la ragione umana alla necessità di certe regole chiamate, Dio sa perché, di buon gusto; e però via via d’ugual passo sgozzano ad esse ogni tratto qualche vittima illustre.
La lode che al poeta viene da questa minima parte della sua nazione non può davvero farlo andare superbo; quindi anche il biasimo ch’ella sentenzia, non ha a mettergli grande spavento. La gente ch’egli cerca, i suoi veri lettori stanno a milioni nella terza classe. E questa, cred’io, deve il poeta moderno aver di mira, da questa deve farsi intendere, a questa deve studiar di piacere, s’egli bada al proprio interesse ed all’interesse vero dell’arte. Ed ecco come la sola vera poesia sia la popolare: salve le eccezioni sempre, come ho già detto; e salva sempre la discrezione ragionevole questa regola vuole essere interpretata.
Se i poeti moderni d’una parte della Germania menano tanto romore di sé in casa loro, e in tutte le contrade d’Europa, ciò è da ascriversi alla popolarità della poesia loro. E questa salutare direzione ch’eglino diedero all’arte fu suggerita loro dagli studi profondi fatti sul cuore umano, sullo scopo dell’arte, sulla storia di lei e sulle opere ch’ella in ogni secolo produsse: fu suggerita loro dalla divisione in classica e romantica ch’eglino immaginarono nella poesia.
Però sappi, tra parentesi, che tale divisione non è un capriccio di bizzarri intelletti, come piace di borbottare a certi giudici, che senza processare sentenziano; non è un sotterfugio per sottrarsi alle regole che ad ogni genere di poesia convengono; da che uno de’ poeti chiamati romantici, è il Tasso. E fra le accuse che si portano alla Gerusalemme, chi udì mai messa in campo quella di trasgressione delle regole? Qual altro poema piú si conforma alle speculazioni algebraiche degli Aristotelici? Né ti dare a credere, figliuolo mio, che con quella divisione i tedeschi di cui parlo pretendessero che d’una arte, la quale è unica, indivisibile, si avesse a farne due; perocché stolti non erano. Ma se le produzioni di quest’arte, seguendo l’indole diversa dei secoli e delle civilizzazioni, hanno assunte facce differenti, perché non potrò io distribuirle in tribù differenti? E se quelle della seconda tribù hanno in sé qualche cosa che più intimamente esprime l’indole della presente civilizzazione europea, dovrò io rigettarle per questo solo che non hanno volto simile al volto della prima tribù?
Di mano in mano che le nazioni europee si riscuotevano dal sonno e dall’avvilimento, di che le aveva tutte ingombrate la irruzione de’ barbari dopo la caduta dell’impero romano, poeti qua e là emergevano a ringentilirle. Compagna volontaria del pensiero e figlia ardente delle passioni, l’arte della poesia, come la fenice, era risuscitata di per sé in Europa, e di per sé anche sarebbe giunta al colmo della perfezione. I miracoli di Dio, le angosce e le fortune dell’amore, la gioia de’ conviti, le acerbe ire, gli splendidi fatti de’ cavalieri muovevano la potenza poetica nell’anima de’ trovatori. E i trovatori, né da Pindaro instruiti né da Orazio, correndo all’arpa prorompevano in canti spontanei ed intimavano all’anima del popolo il sentimento del bello, gran tempo ancora innanzi che l’invenzione della stampa e i fuggitivi di Costantinopoli profondessero daper tutto i poemi de’ greci e de’ latini. Avviata così nelle nazioni d’Europa la tendenza poetica, crebbe ne’ poeti il desiderio di lusingarla più degnamente. Però industriaronsi per mille maniere di trovare soccorsi; e giovandosi della occasione, si volsero anche allo studio delle poesie antiche, in prima come ad un santuario misterioso accessibile ad essi soli, poi come ad una sorgente pubblica di fantasie, a cui tutti i lettori potevano attignere. Ma ad onta degli studi e della erudizione, i poeti, che dal risorgimento delle lettere giù fino a’ dì nostri illustrarono l’Europa e che portano il nome comune di moderni, tennero strade diverse. Alcuni, sperando di riprodurre le bellezze ammirate ne’ greci e ne’ romani, ripeterono, e più spesso imitarono modificandoli, i costumi, le opinioni, le passioni, la mitologia de’ popoli antichi.
Altri interrogarono direttamente la natura: e la natura non dettò loro né pensieri né affetti antichi, ma sentimenti e massime moderne. Interrogarono la credenza del popolo: e n’ebbero in risposta i misteri della religione cristiana, la storia di un Dio rigeneratore, la certezza di una vita avvenire, il timore di una eternità di pene. Interrogarono l’animo umano vivente: e quello non disse loro che cose sentite da loro stessi e da’ loro contemporanei; cose risultanti dalle usanze ora cavalleresche, ora religiose, ora feroci, ma o praticate e presenti o conosciute generalmente; cose risultanti dal complesso della civiltà del secolo in cui vivevano. La poesia de’ primi è classica, quella de’ secondi è romantica. Cosí le chiamarono i dotti d’una parte della Germania, che dinanzi agli altri riconobbero la diversità delle, vie battute dai poeti moderni. Chi trovasse a ridire a questi, vocaboli, può cambiarli a posta sua. Però io stimo di poter nominare con tutta ragione poesia de’ morti la prima, e poesia de’ vivi la seconda. Né temo d’ingannarmi dicendo che Omero, Pindaro, Sofocle, Euripide ec. ec., al tempo loro, furono in certo modo romantici, perché non cantarono le cose degli Egizzi o de’ Caldei, ma quelle dei loro Greci; siccome il Milton non cantò le superstizioni omeriche, ma le tradizioni cristiane. Chi volesse poi soggiungere che anche fra i poeti moderni seguaci del genere classico quelli sono i migliori, che ritengono molta mescolanza del romantico, e che giusto giusto allo spirito romantico essi devono saper grado se le opere loro vanno salve da l’oblio, parmi che no meriterebbe lo staffile. E la ragione non viene ella forse in sussidio di siffatte sentenze, allorché gridando c’insegna che la poesia vuole essere specchio di ciò che conmuove maggiormente anima? Ora l’anima è commossa al vivo dalle cose nostre che ci circondano tutto dí, non dalle antiche altrui, che a noi sono notificate per mezzo soltanto de’ libri e della storia.
Allorché tu vedrai addentro in queste dottrine, e ciò non sarà per via delle gazzette, imparerai come i confini del bello poetico siano ampi del pari che quelli della natura, e che la pietra di paragone, con cui giudicare di questo bello, è la natura medesima e non un fascio di pergamene; imparerai come va rispettata davvero la letteratura de’ Greci e de’ Latini; imparerai come davvero giovartene. Ma sentirai altresí come la divisione proposta contribuisca possentemente a sgabellarti dal predominio sempre nocivo dell’autorità. Non giurerai piú nella parola di nessuno, quando trattasi di cose a cui basta il tuo intelletto. Farai della poesia tua una imitazione della natura, non una imitazione di imitazione. A dispetto de’ tuoi maestri, la tua coscienza ti libererà dal l’obbligo di venerare ciecamente gli oracoli di un codice vecchio e tarlato, per sottoporti a quello della ragione, perpetuo e lucidissimo. E riderai de’ tuoi maestri che colle lenti sul naso continueranno a frugare nel codice vecchio e tarlato, e vi leggeranno fin quello che non v’è scritto.
Materia di lungo discorso sarebbe il voler parlare all’Italia della divisione suaccennata; ed importerebbe una anatomia lunghissima delle qualità costituenti il genere classico, e di quelle che determinano il romantico. A me non concede la fortuna né tempo, né forze. sufficienti per tentare una siffatta dissertazione: perocché il ripetere quanto hanno, detto su di ciò i Tedeschi non basterebbe. Avvezzi a vedere ogni cosa complessivamente, eglino non di rado trascurano, di segnare i precisi confini de’ loro sistemi; e la fiaccola, con cui illuminano i passi altrui, manda talvolta una luce confusa.
Ma poiché in Italia, a giudicare da qualche cenno già apparso non v’ha difetto intero di buona filosofia, io prego, che un libro sia composto finalmente qui tra noi, il quale non tratti d’altro che di questo argomento, e trovi modo di appianar tutto, di confermare nel proposito i già iniziati, rincorare i timidi, e di spuntare con cristiana carità le corna al pedanti.
Ben è vero che a que’ pochi del mestiere, a’ quali può giovare per le opere loro una idea distinta del genere romantico, questa, io spero, sarà già entrata nel cervello loro, mercè l’acume della propria lor mente. Ma perché voi altri giolvinetti siete esposti alla furia di tante contrarie sentenze, e la verità non siete in caso di snudarla da per voi, è bene che qualcuno metta in mano vostra ed in mano del pubblico un libro che vi scampi dal peccato, pur sí frequente in Italia, di bestemmiare ciò che si ignora. Intanto, che il voto mio va ricercando chi lo accolga e lo secondi; intanto che, irritati dalla novità del vocabolo romantico, da Dan fino a Bersabea si levano a fracasso i pedanti nostri, e fanno a rabbuffarsi l’un l’altro, e a contumeliarsi e a sagramentare, e a non intendersi tra di loro, come a Babilonia; intanto che la divisione, per cui si arrovellano, è per loro piú mistica della piú mistica dottrina del Talmud, vediamo, figliuolo mio, quali effetti ottenessero i poeti che la immaginarono.
Posti frammezzo a un popolo non barbaro, non civilissimo, se se ne riguarda tutta, la massa degli abitanti, e non la sola schiera degli studiosi, i poeti recenti d’una parte della Germania dovevano superare in grido i loro confratelli contemporanei sparsi nel restante d’Europa. Ma della fortuna della poesia loro tutto il merito non, è da darsi alla fortuna del loro nascimento. L’essersi avveduti di questa propizia circostanza, e l’aver saputo trarne partito, è merito personale. E a ciò contribuí, del pari che l’arguzia dell’ingegno, la santità del cuore. Sentirono essi che la verissima delle Muse è la Filantropia e che l’arte loro aveva un fine ben piú sublime che il diletto momentaneo di pochi oziosi. Però, avidi di richiamare l’arte a’ di lei principi, indirizzandola al perfezionamento morale del maggior numero de’ loro compatrioti, eglino non gridarono, come Orazio: «Satis est equitem nobis plaudere»; non mirarono a piaggiare un Mecenate, a gratificarsi un Augusto, a procurarsi un seggio al banchetto dei grandi; non ambirono i soli battimani d’un branco di scioperati raccolti nell’anticamera del Principe. Oltrediché non è da tacersi come insieme a questo pio sentimento congiurasse anche nelle anime di que’, poeti la sete della gloria, ardentissima sempre ne’ sovrani ingegni, e sprone inevitabile al far bene. Eglino avevano letto che in Grecia la corona del lauro non l’accordavano né Principi, né Accademie, ma cento e cento mila persona convenute d’ogni parte in Tebe e in Olimpia. Avevano letto che i canti di Omero, di Tirteo non erano misteri di letterati, ma canzoni di popolo. Avevano letto che Eschilo, Sofocle, Euripide, Aristofane non si facevano belli della lode de’ loro compagni di mestiere; ma anelavano al plauso di trentamila spettatori; e l’ottenevano. Quindi, agitati da castissima invidia, vollero anch’essi quel plauso e quella corona. Ma e in che modo conseguirla? Posero mente alle opere che ci rimangono de’ poeti greci; e quantunque s’innamorassero sulle prime della leggiadria di quei versi, dello splendore di quella elocuzione, dell’artificio mirabile con cui le immagini erano accoppiate e spiegate, pure non si diedero a credere che in ciò fosse riposto tutto il talismano. E come crederlo, se in casa loro e fuori di casa vedevano condannati all’untume del pizzicagnolo versi, a cui né sceltezza di frasi mancava, né armonia?
Lambiccarono allora essi con piú fina critica quelle opere onde scoprire di che malìe profittavansi in Grecia i poeti per guadagnarsi tanto suffragio dai loro contemporanei. Videro che queste malíe erano i loro Dei, la loro religione, le loro superstizioni, le loro leggi, i loro riti, i loro costumi, la storia loro, le loro tradizioni volgari, la geografia loro, le loro opinioni, i loro pregiudizi, le foggie loro ec. ec. ec.
– E noi, dissero eglino, noi, abbiamo altro Dio, altro culto; abbiamo anche noi le nostre superstizioni, abbiamo altre leggi, altri costumi, altre inclinazioni piú ossequiose e piú cortesi verso la beltà femminina. Caviamo di qui anche noi le malíe nostre, e il popolo c’intenderà. E i versi nostri non saranno per lui reminiscenze d’una fredda erudizione scolastica, ma cose proprie e interessanti e sentite nell’anima.
– A rinforzarli nella determinazione soccorse loro l’esempio altresí de’ poeti che dal risorgimento delle lettere in Europa fino a’ dí nostri sono i piú famosi. E chi negherà questi essere tanto piú venerati e cari, quanto di queste nuove malie piú sparsero ne’ loro versi? Cosí i poeti d’una parte della Germania co’ medesimi auspici, con l’arte medesima né piú né meno, col medesimo intendimento de’ Greci scesero nell’arringo, desiderarono la palma, e chiesero al popolo che la desse loro. E il popolo, non obbliato, non vilipeso da’ suoi poeti; ma carezzato, ma dilettato, ma istruito, non ricusò d’accordarla.
A che miri la parola mia, tu lo sai; però fanne senno, figliuolo mio, e non permettere che la paterna carità si sfoghi al vento. So che agli uomini piace talvolta di onestare la loro inerzia con bei paroloni. Ma io non darò retta mai né a te, né a chiunque mi ritesserà le solite canzoni: e che l’Italia è un armento di venti popoli divisi l’uno dall’altro, e ch’ella non ha una gran città capitale dove ridursi a gareggiare gli ingegni, e che tutto vien meno ove non è una patria. Lo sappiamo, lo sappiamo. Ma l’avevano questa unità di patria e questo tumulto d’una capitale unica i poeti dei quali ho parlato? E se noi non possediamo una comune piatria politica, come neppure essi la possedevano, chi ci vieta di crearci intanto, com’essi, a conforto delle umane sciagure una patria letteraria comune? Forse che Dante, il Petrarca, l’Ariosto per fiorire aspettarono che l’Italia fosse una? Forse che la latina è la piú splendida delle letterature? E non di meno qual piú vasta metropoli di Roma sotto Ottaviano e sotto i Cesari?
«Voi (gridava l’altro dí nella voce dell’ira sua il Curato di Monte Atino, l’amico mio dall’anima ardente), voi, se i siete caldi di vero amore per la vostra, bella Italia, levate l’orecchio, o generosi italiani. Udite come tutta quanta l’Europa ne rinfaccia d’ogni parte il presente decadimento delle nostre lettere è egli da credersi che tanta universalità di disprezzo si tutta opera della malignità? Ponetevi, in nome di Dio! Ponetevi una mano al petto; interrogate la coscienza vostra. E non la sentite anch’essa tremar di vergogna? Però perdonate gli insulti villani, con che ne strapazzano oggi que’ popoli stessi che un tempo, o ne lodavano, o taciturni rodevansí d’invidia pe’ nostri trionfì letterari. Alle calunnie chè calunnie pur anco piovono addosso all’Italia, non istate ad occorre altro che la dignità del silenzio; e cadranno di per sé. Ma dè consigli giovatevi: e la gloria della vostra terra ricuperatela col far voi, non col citare le opere degli avi nostri. Gloria nostra sit terstimonium conscientae nostrae, diceva S. Paolo a que’ di Corinto. Vincete l’avversità collo studio; smettete una volta la boria di reputarvi i soli europei che abbiano occhi in testa; smettete la petulanza con cui vi sputate l’un l’altro in viso e per inezie da fanciulli, unitevi l’un l’altro coi vincoli di amorosa concordia fraterna, senza della quale voi sarete sempre nulli in tutto e pertutto. E poichè perspicacia d’intelletto non ve ne manca, solo che vogliate rifarvi dalle male abitudini, lavorate, ve ne scongiuro, e lavorate da senno. Ma prima di tutto spogliatevi della stolida devozione per un solo idolo letterario. Leggete Omero, leggete Virgilio, che Dio ve ne benedica. Ma tributate e vigilie e incenso anche a tutti gli altri begli altari che i poeti in ogni tempo e in ogni luogo innalzarono la natura. E quantunque a rischio di lasciare qualche dì nella dimenticanza e i volumi dell’antichità e i volumi de’ moderni, traetevi ad esaminare da vicino voi stessi la natura, e lei imitate, lei solo davvero e niente altro. Rendetevi coevi al secolo vostro, e non ai secoli seppelliti: spacciatevi dalla nebbia che oggidì invocate sulla vostra dizione; spacciatevi dagli arcani sibillini, dalle vetuste liturgie, da tutte le Veneri e da tutte le loro turpitudini; cavoli già putridi non rifriggeteli. Fate di piacere al popolo vostro; investigate l’animo di lui; pascetelo di pensieri e non di vento. Credete voi forse che i lettori italiani non gustino altro che il sapore dell’idioma e il lusso della verbosità? Badate che leggono libri stranieri, che s’accostumano a pensare, e che dalle fatuità vanno ogni dì più divezzandosi. Badate che i progressi intellettuali d’una parte di Europa finiranno col tirar dietro a sé anche il restante. E voi con tutta la vostra albagia rimarrete lì soli soli, a far voi da autori insieme e da lettori. Insomma siate uomini e non cicale; e i vostri paesani vi benediranno, e lo straniero ripiglierà modestia e parlerà di voi coll’antico rispetto».
Nessuno de’ ricchi tra’ tuoi terrazzani venga a morte fuori della tua giurisdizione parrocchiale, o buon curato di Monte Atino, o anima italiana davvero! Chi non ti perdonerebbe la declamazione in grazia dello zelo e del patriottismo che spirano le tue ammonizioni? Ora, figliuolo mio, ti sia palese che tutto il discorso fatto sin qui, sebbene paresse sviarsi dal soggetto, pure era necessario. Così mi sono preparata la via alla soluzione de’ due quesiti che tu mi hai fatti, ed ai quali posso ora rispondere con maggiore brevità. Eccoli entrambi, e in termini più precisi de’ tuoi:
- La moderna Italia ammetterebbe ella poesie di questo genere (i Romanzi)?
- Il Cacciatore feroce e l’Eleonora piaceranno in Italia?
Interrogazione prima:
La moderna Italia ammetterebbe ella poesie di questo genere (i Romanzi)?
Non fa mestieri, cred’io, di molte lucubrazioni per trovare che alla prima interrogazione vuolsi rispondere con un «Sì» netto e stentoreo. Da quanto ho detto sulla opportunità di indirizzare la poesia non all’intelligenza di pochi eruditi ma a quella del popolo, affine di propiziarselo e di guadagnarne l’attenzione, tu avrai di per te stesso inferita questa sentenza: che i poeti italiani possono del pari che gli stranieri dedurre materia pe’ loro canti dalle tradizioni e dalle opinioni volgari, e che anzi gioverebbe di presente ch’eglino preferissero queste a tutto intero il libro di Natale de’ Conti. Però non voglio sprecar tempo in dimostrarti che, per tale rispetto, questo genere di romanzi si conviene anche all’Italia; e per verità non farei che ridire le parole mie. Che poi questo modo di narrare liricamente una avventura offenderà gli italiani, non credo.
La poesia d’Italia non è arte diversa dalla poesia degli altri popoli. I principi e lo scopo di lei sono perpetui ed universali. Ella, come vedemmo, è diretta a migliorare i costumi degli uomini, a farne gentili gli animi, a contentarne i bisogni della fantasia e del cuore; poiché la tendenza alla poesia, simigliante ad ogni altro desiderio, suscita in noi veri bisogni morali. Per arrivare all’intento suo la poesia si vale di quattro forme elementari: la lirica, la didascalica, l’epica e la drammatica. Ma perché ella di sua natura abborre i sistemi costrettivi e perché i bisogni che ella prende ad appagare possono essere modificati in infinito, ha diritto anche ella di adoperare mezzi modificati in infinito. Quindi a sua posta ella unisce e confonde insieme in mille modi le quattro forme elementari, derivandone mille temperamenti. Se la poesia è l’espressione della natura viva, ella deve essere viva come l’oggetto ch’ella esprime, libera come il pensiero che le dà moto, ardita come lo scopo a cui è indirizzata.
Le forme ch’ella assume non costituiscono la di lei essenza, ma solo contribuiscono occasionalmente a dare effetto alle di lei intenzioni. Però fino a tanto ch’ella non esce dell’instituto suo, non v’ha muso d’uomo che di propria facoltà le abbia a dettare restrizioni su questo punto del tra mischiare le forme elementari. Che i due romanzi del Bürger spiaceranno agli italiani per l’argomento loro e per lo stile, forse sarà. Ma che l’Italia non patirebbe che i suoi poeti scrivessero romanzi del genere di questi, perché forse schifa della mescolanza dell’epico collirico, non credo. Siffatte obbiezioni non suggeriscono che al cervello de’ pedanti, i quali parlano della poesia senza conoscerne la proprietà. Ma se il presagio non mi falla, la tirannide dei pedanti sta per cadere in Italia. E il popolo e i poeti si consiglieranno a vicenda senza paura delle Signorie Loro, ed a vicenda si educheranno; e non andrà molto, spero.
La meditazione della filosofia riuscirà bensì a determinare, a un di presso, di quali materiali debbano i poeti giovarsi nell’esercizio dell’arte, di quali no, e fin dove possano estendere l’ardimento della imitazione. E l’esperienza dimostra che in questo l’arte della poesia soffre confini come tutte le di lei sorelle. Ma quale filosofia potrà dire in coscienza al poeta: le modificazioni delle forme sono queste, non altre? So che i pedanti si stilleranno l’intelletto per rinvenire, a modo d’esempio, la bandiera sotto cui far trottare le terzine del signor Torti sulla Passione del Salvatore. So che, nel repertorio de’ titoli disceso loro da padre in figlio, non ne troveranno forse uno che torni a capello per quelle terzine. Carme no, ode no, Idillio no, Eroide forse?…
Ma intanto quella squisita poesia, con buona pace delle Signorie Loro, è già per le bocche di tutti. E l’Italia, non badando a’ frontispizi, scongiura il signor Torti a non lasciarla lungamente desiderosa d’altri regali consimili. Lo stesso avverrà d’ogni altra poesia futura, quando le modificazioni delle forme siano corrispondenti all’argomento ed alla intenzione del poeta, e quando siffatta intenzione sia conforme allo scopo dell’arte ed a’ bisogni dell’uomo.
Il sentimento della convenienza, che induce il poeta alla scelta di un metro piuttosto che di un altro, è contemporaneo nella mente di lui alla concezione delle idee ch’egli ha in animo di spiegare nel suo componimento ed al disegno che lo muove a poetare. Le regole generali degli scrittori di Poetiche non montano gran fatto, da che ogni caso vorrebbe regola a parte. Laonde è opinione mia che un uomo dell’arte possa bensì assisterti ogni volta con un buon consiglio; ma che se tu aspetti che te lo diano i trattatisti, non ne faremo nulla, figliuolo mio. E a questo proposito mi piace di rallegrarti con un’altra scappata declamatoria, in cui diede, non ha guari, il buon curato di Monte Atino, l’amico mio dall’anima ardente.
Una persona, che aveva aria d’uomo non dozzinale e non l’era davvero, parlava della poesia romantica con Sua Reverenza. E Sua Reverenza l’udiva con volto pacato e con segni d’approvazione, perché erano lodi alla poesia romantica, la prediletta dell’anima sua. Quando tutt’adun tratto il panegirista uscì fuori con un voto, perché alcuno in Italia pigliasse a scrivere una Poetica romantica. «Che Poetiche di Dio!» gridò allora il buon curato di Monte Atino, dimenandosi sul suo seggiolone come un energumeno, «che Poetiche di Dio! Se ai giorni nostri vivesse Omero, vivesse Pindaro, vivesse Sofocle, dovrebbono essi cambiare arte forse? No, in nome del cielo, no. Ma la differenza dei secoli renderebbe differenti le cose che que’ poeti imprenderebbono ora a trattare. E la differenza delle cose indurrebbe di necessità differenza nella mescolanza delle forme e nell’accoppiamento delle immagini. E Omero, Pindaro, Sofocle sarebbero poeti «romantici», volere o non volere. Ma l’arte loro sarebbe tuttavia quella stessa de’ classici antichi. Che importa a me se il Cellini oggi micesella un vezzo per madama d’Étampes e domani un calice pel santo padre? Egli è pur sempre Benvenuto, l’orefice fiorentino. Ma questo Proteo irrequieto come l’amore, quest’arte della poesia, questa perpetua inventrice del bello, chi l’insegna? Le Poetiche forse? Sono forse le Poetiche che hanno sviluppate le menti a que’ tre miracoli della Grecia? sono forse le Poetiche che dissero come tener la penna in mano a Dante, all’Ariosto, a Shakespeare? Al diavolo queste corbellerie! Mostratemi una Poetica anteriore alla esistenza di un poeta. Mostratemi un vero poetaeducato e formato dalle Poetiche. Dov’è, dov’è? Io vi mostrerò de’ poetiche colle opere loro hanno prestata materia di che rimpinzare di regoluzze un libruzzo a trenta maestruzzi. Io vi mostrerò trentamila pedanti, e tutti figli delle Poetiche, e tutti misuratori di sillabe, e tutti sputasentenze, e tutti teste di legno. Al diavolo colle Poetiche! Perché non t’incarni un’altra volta, o bella anima di Omar, tanto appena che ti basti tempo per discendere in Italia a metter fuoco a tutte le Poetiche, da quella di Aristotile fino a quella del Menzini?»
E qui Sua Reverenza mandò un lungo sospiro di desiderio. Poi tosto ammutì, guardò in alto per poco, e si fece tutto rosso in viso, vergognando, cred’io, d’avere unito il nome d’Aristotile a quello di un guasta mestiere. Poi, ripreso fiato, stese la mano all’ospite e col sorriso della cortesia lo pregò perché proseguisse il panegirico che tanto gli andava a sangue.
Terminato il dire, l’ospite pigliò licenza. Il povero curato lo accompagnò fino all’uscio; e lasciata scappare una lagrima, gli strinse la mano e gli disse: «Domando mille scuse; ho gridato fuori d’ogni creanza: ma sappia Vossignoria ch’io nonl’aveva con lei. A lei io ho dato la mia stima. Capperi! Vossignoria ha detto pel primo in Italia cose che non tutti sanno dire o che tutti qui s’ostinano a non voler dire. Da bravo! Stia fermo, e non si lasci atterrire da chi senza entrare in ragionamenti le abbaia dietro de’ mali motteggi e delle insipide satire. Siamo cristiani e sacerdoti entrambi; perdoniamo adunque di buona volontà agli insolenti. Dio n’abbia anch’egli misericordia! Sono montato in furia contro le Poetiche, perché la sento così e perché questo mio maledetto naturale è tutto stizza e non lo so mai frenare. Ma i filosofi estetici io non li confondo cogli scrittori di Poetiche. No, no, quelli li rispetto, e glielo giuro sull’onor mio. E le giuro che qualche volta leggo con vera avidità le cose del Burke e del Lessing, come se fossero squarci della Città di Dio del mio sant’Agostino. Ma Ella compatisca se in questo punto delle Poetiche io sono di parere contrario a quello manifestato da lei: compatisca e mi voglia bene.»
Interrogazione seconda.
Il Cacciatore feroce e l’Eleonora piaceranno in Italia?
Questo è quesito di non così facile scioglimento come il primo. Madama de Staël, nell’ingegnosa ed arguta sua opera sull’Alemagna, ha analizzati entrambi questi Romanzi. E come è solito dei fervidi ed alti intelletti, che hanno sortita fantasia vasta, l’aggiungere senza avvedersene qualche cosa sempre del loro alle opere altrui delle quali s’innamorano, ella vi trovò bellezze forse più che non hanno e gli ammirò forse troppo. Nondimeno ella è di parere che difficile e quasi impossibile sarebbe il far gustare que’ Romanzi in Francia; e che ciò provenga dalla difficoltà del tradurli in versi, e da questo: che in Francia rien de bizarre n’est naturel. In quanto alla bizzarria ed alla difficoltà di tradurre in versi, sta a’ Francesi ed a madama de Staël il decidere. In quanto al poterne tentare una versione in prosa francese, io credo di non errare pensando che, se madama de Staël avesse voluto piegarsi ella stessa all’ufficio di traduttore, i francesi avrebbero accolta come eccellente la traduzione di lei. E se mai il giudizio, che ella portò sulla incompatibilità del gusto francese colla bizzarria de’ pensieri, fosse meno esatto, la tanta poesia che vive in tutte le prose di madama si sarebbe trasfusa di certo anche in questa, per modo che la mancanza del metro non sarebbe stata sciagura deplorabile. L’armonia non è di così essenziale importanza da dover dipendere totalmente da essa la fortuna di un componimento.
Per riguardo all’Italia, io non saprei temere di un ostacolo dal semplice lato della bizzarria, da che l’Ariosto è l’idolo delle fantasie italiane. Però, lasciato stare il danno che a questi Romanzi può venire dall’andar vestiti di una poco bella traduzione per le contrade d’Italia, dico che a me sembra di ravvisare in essi una cagione più intrinseca, per la quale non saranno forse comunemente gustati tra di noi.
Entrambi questi Romanzi sono fondati sul maraviglioso e sul terribile, due potentissime occasioni di movimento per l’animo umano. Ma l’uomo che, per uscire del letargo che gli è incomportabile, invoca anche scosse violente all’anima sua e anela sempre di afferrare siffatte occasioni pure non se ne lascia vincere mai, se non per via della credenza. E il terribile e il maraviglioso, quando non sono creduti, riescono inoperosi e ridicoli, come la verga di Mosè in mano a un misero Levita. L’effetto dunque che produrranno i due Romanzi del Burger sarà proporzionato sempre alla fede che il lettore presterà agli argomenti di maraviglia e di terrore, de’ quali essi riboccano. Ora, dipendendo da ciò principalmente l’esito della loro emigrazione presso gli Italiani, a me non d’a’ il cuore di prognosticarla fortunata. Cominciamo dal primo: ecco la traduzione del Cacciator feroce.
IL CACCIATORE FEROCE
Il Conte di Rheingrafenstein [3] diede fiato alla cornetta:
«Olà, olà, su su, in piedi e in sella!».
Il suo cavallo mise nitriti, e via d’un salto si slanciò innanzi.
E dietro a lui precipitosa a fracasso tutta la salmeria; e un correre, uno squittire di cani sguinzagliati su e giú per mezzo a biade e prunaie, per mezzo a ginestreti ed a stoppie.
Illuminata dal raggio mattutino della Domenica, biancheggiava da alto la cupola del Duomo. Con tocchi distinti, con un rombar grave le campane festive chiamavano il popolo alla messa cantata. Di lontano risonavano i cantici della turba divota de’ Cristiani.
E via, via, via, attraverso bivi e quadrivi veniva impetuosa la caccia: e da per tutto erano gridi, «to to to, ciuée, ciuée».
Ed ecco a destra, ecco a sinistra uscire un cavaliero di qui, un cavaliero di là. Il corridore del cavaliero a destra era nitido come argento; del color del fuoco era quello che portava il cavaliero a sinistra.
Chi era mai il cavaliero a destra, chi mai il cavaliero a sinistra? Ben me lo presagisce il cuore, ma chi sieno, non so. Il cavaliero a destra comparve in candido vestimento, e con volto soave, come la primavera. Il cavaliero a sinistra, orrendo e vestito di un fosco giallo, vibrava folgori dall’occhio, come la tempesta.
– «In tempo, in tempo giungeste! Ben venga ognuno di voi alla nobile caccia! Né qui in terra, né su in cielo vi ha spasso piú caro di questo!».
Egli cosí esclamò; e lieto fe’ scoppiar la palma sull’anca; e toltosi di testa il cappello, l’agitò su per l’aria.
– «Mal si accorda il suono della tua cornetta alla squilla festiva ed a’ cantici del coro (disse con placido animo il cavaliero a destra). Torna, torna indietro: la tua caccia è mal augurata quest’oggi. Cedi al consiglio dell’angelo buono, e non ti lasciar traviare dal cattivo».
– «Innanzi, innanzi, séguita su, séguita la tua caccia, o mio nobil Signore! (interruppe violento il cavaliero a sinistra). Che ronzo di squilla? Che clamore di coro? Ben piú vi farà allegri la gioia della caccia. Io, io v’insegnerò quali trastulli si convengano a’ principi. Non istate a dar, no, retta al costui spauracchio».
– «Ah sí, ben parli, o cavaliero a sinistra! Tu sei un eroe secondo il cuor mio. Chi rifugge l’uscire a caccia, vada in malora a, snocciolar Paternostri. A tuo dispetto, bacchettone scimunito, a tuo dispetto voglio cavarmi la mia brama».
E via via via, fuor d’un campo, dentro un altro, su pel poggio, giú per la china, sempre gli venivano cavalcando stretti a’ fianchi il cavaliero a destra, e il cavaliero a sinistra. Quand’ecco a un tratto smacchiar di lontano un bianco cervo con corna di sedici palchi.
Il conte raddoppiò il fiato alla cornetta; e piú veloci accorsero d’ogni parte cavalieri e pedoni. Ed ecco or di dietro, or dinanzi, or l’uno or l’altro de’ seguaci stramazzare tramortito sul terreno per la gran furia.
– «Stramazza pure, stramazza al diavolo! Non per questo deve andar guasto lo spasso de’ principi». La belva si accascia in un campo di spighe, e vi spera rifugio. Ecco un povero contadino trarre innanzi umilmente, e metter gemiti e lagrime:
– «Pietà, Signor mio, pietà! Abbiate riguardo agli stenti, al sudore del poverello!».
Il cavaliero a destra galoppa avanti, e con dolcezza e bontà ammonisce il conte. Ma il cavaliero a sinistra lo infervora, lo instiga all’oltraggio maligno. il conte schernisce le ammonizioni del cavaliero a destra, e si lascia traviare dal cavaliero a sinistra.
– «Via di qua, miserabile! (grida sbuffando terribile il conte al povero aratore) o ch’io, per Satanasso! su te, su te dirizzo la caccia. –Olà, compagni! addosso, addosso! dàlli dàlli! In segno che ho giurato il vero, fategli fischiar le fruste sugli orecchi».
Detto fatto, il conte si scagliò furibondo al disopra la siepe; e dietro a lui un bisbiglio, un rimbombo, e tutto quanto il traino con cani e cavalli e pedoni. E cani e pedoni e cavalli pestavano i fusti del grano, sicché la campagna tutta era un polverío.
All’avvicinarsi di quello schiamazzo, spaventata, la belva, via via, fuor d’un campo, dentro un altro, su pel poggio, giú per la china, messa in fuga, inseguita, ma non arrivata, guadagna i piani del pascolo comunale; e astuta si frammette alle mansuete mandre onde salvarsi. Ma di qua, di là, per campagne e per boschi; di su, di giú, per boschi e per campagne, i veliri la perseguitano, e n’hanno tosto fiutata la traccia.
Il mandriano, [4] pieno d’angoscia pel suo armento, si butta a’ piedi del conte.
– «Pietà, Signore, pietà! Fate di lasciare in pace queste mie povere bestie mansuete. Ponete mente, Signor mio, che qui pascolano le vacche di tante povere vedove, che non hanno altra sostanza. Abbiate pietà de’ poveri. Misericordia, Signor mio, misericordia!». Il cavaliero a destra galoppa innanzi, e con dolcezza e bontà ammonisce il conte. Ma il cavaliero a sinistra lo infervora, allo instiga all’oltraggio maligno. Il conte schernisce le ammonizioni del cavaliero a destra, e si lascia traviare dal cavaliero a sinistra.
– «Ribaldo, temerario che a me contrasti! Ah! perché non sei tu incarnato, tu stesso nella migliore delle tue vacche, e in lei non è incarnata altresí ognuna di quelle sgualdrine? Che gioia sarebbe allora pel cuor mio lo incalzarvi tutti insieme a dirittura fino all’altro mondo! – «Olà, compagni! addosso addosso, dàlli dàlli! To to, qui, qui, ciuée ciuée ciuée!».
E ciascuno dei cani s’avventò, aizzato, sul primo oggetto che gli si parò innanzi. Insanguinato cadde a terra il mandriano, insanguinate caddero l’una dopo l’altra le vacche.
A stento la belva si sottrae a quel macello con sempre minor, lena di corso. Spruzzata di sangue, intrisa di bava, eccola prendere il cupo della foresta, e ripararvisi. Addentro addentro ella s’ínselva, e viene a trovar nascondiglio nella cappelletta di un Eremita.
Via via, senza posa mai, «to to, ciuée ciuée, to to to!».
Allo scoppiar delle fruste, all’abbaiare de’ veltri, allo squillare dei corni la schiera feroce anche colà si precipita. Il santo Eremita uscí dalla cappelletta, e si fece incontro con mite scongiuro.
– «Rimanti, rimanti, abbandona la traccia. Non profanare l’asilo di Dio.
«La creatura manda gemiti al cielo, e implora da Dio il castigo tuo. Làsciati per l’ultima volta ammonire, o la tua empietà ti trarrà in perdizione».
Sollecito il cavaliero a destra galoppa innanzi, e con dolcezza e bontà ammonisce il conte. Ma il cavaliero a sinistra lo infervora, lo instiga all’oltraggio maligno. Eh, oh Dio! ad onta delle ammonizioni del cavaliero a destra, egli si lescia traviare dal cavaliero a sinistra.
– «Che empietà? che perdizione parli tu mai? Forse, grida egli, forse che la mi spaventa gran fatto? Questa mia caccia, dovessi io anche vederla spinta fino al terzo cielo, che rileva, che monta a me? Sí, per Dio! vo’, proseguirla; voglio sbramarmi. E sia pure a dispetto di te, o scimunito, e a dispetto di Dio».
Egli mena vibrata la frusta, dà fiato alla cornetta.
«Olà, compagni, addosso addosso! dàlli dàlli!».
Oh Dio! ecco, in un tratto spariscono innanzi a lui ed Eremita e cappelletta; spariscono dietro a lui e cavalli e pedoni. E in un batter d’occhio, e fracassi e suoni ed urli di caccia, tutto tutto ingoia un silenzio di morte. Atterrito il conte gita lo sguardo; dà fiato alla cornetta, e la cornetta non rende suono; mette un grido, e non In piú sentore della propria voce; vibra la frusta, e la frusta non fischia; sprona l’un fianco e l’altro al destriero, né può cavalcare innanzi o retrocedere. E subito intorno a lui un buio, e piú e piú sempre un buio, come di sepolcro; ed un mugghiare, come di marina lontana. Su alto per l’aria al disopra del suo capo una voce di tuono grida tremenda con furor di burrasca questa sentenza:
– «O tiranno, o indole d’inferno, che insolentisci contro di Dio, contro gli uomini, contro ogni cosa! Il singulto, il gemito della creatura, e la tua iniquità ti hanno citato a gran voce innanzi al tribunale, là su dove arde la fiaccola della vendetta. Fuggi, empio, fuggi. E sia tu da qui innanzi per tutta l’eternità perseguitato tu stesso in caccia dall’inferno e dal demonio. E sia spavento, questo, de’ principi d’ogni secolo che, a saziare le loro voglie scellerate, non perdonano né a Creatore né a creatura».
A queste parole un bagliore giallo. come zolfo guizza intorno alle frondi della foresta. Via via per l’ossa e per le midolle discorre al conte l’angoscia. Una vampa gli opprime il respiro. Stordisce, e non ode piú nulla. Innanzi, tutto gli soffia sul viso gelo e terrore; e alla nuca lo insiegue il fischio della bufera.
Cresce il soffio del terrore, cresce il fischio della.bufera; e sulla terra, oh spavento! ecco un pugno negro emergere) giganteggiare. Apresi, stringe gli artigli; abi ahi! già lo abbranca pel ciuffo; ahi ahi! travolta in un attimo la faccia del conte sovrasta alle spalle di lui.
Intorno intorno a lui un corruscar di faville e di fiamme verdi, brune e sanguigne. Un mar di fuoco presso presso gli ondeggia d’ogni lato; e dentro vi brulica la ciurma infernale. In un subito mille veltri infernali prorompono aizzati a fracasso su dalla voragine.
Via precipitoso egli si scaglia attraverso i boschi, attraverso la campagna; e fugge, mettendo lai e ululati.
«Ahi me misero! misero!».
Ma per tutto l’ampio mondo lo perseguita il latrar dell’inferno, di giorno giú per le caverne della terra, a mezzanotte su in alto per l’aria.
La faccia di lui sovrasta perpetuamente alle spalle; ond’egli abbia perpetuamente la veduta d’mostri che lo inseguono. E per quanto rapida la fuga lo trascini innanzi, incintato dagli urli dello spirito cattivo, gli bisogna mirare perpetuamente il digrignar dei denti, e lo spalancarsi delle fauci ringhiose che gli stanno sopra per azzannarlo. Tale è la caccia della ciurma feroce; e dura, e durerà fino al dì del giudizio. Spesso nella. Notte ella passa innanzi al vagabondo a spaventarlo e inorridirlo. E testimonianza ne potrebbe far tuttavia la lingua d’assai cacciatori, se per altre ragioni non convenisse a loro il silenzio. [5]
La favola di questo Romanzo è tratta da una tradizione popolare in Germania, però è un soggetto bello e opportuno per un poeta tedesco. Ivi il popolo la crede vera: e da questa opinione acquistandosi fede il poeta, ha potuto a suo talento far piangere e tremar di terrore i suoi lettori.: I costumi ch’egli ha dipinti sono, o costumi de’suoi tempi, o costumi moderni e notissimi al popolo: quindi sempre maggiore l’interesse e sempre più aumentata la fede.
Ma noi, lettori italiani, non abbiamo come i tedeschi quella tradizione. E a voler reputar vera o verisimile la catastrofe del Cacciatore Feroce, Ci bisognerebbe uno sforzo d’immaginosa superstizione. Ora, che che ne dicano gli stranieri, siamo noi Italiani dotati di tanta superstizione? La ragione nostra ben ci sarebbe tenere come racconto verisimile che Dio avesse castigato severamente la ferocia del cacciatore. Ma il castigo strano ed incessante su questa terra piuttosto che nell’inferno, noi non lo crederemmo, perché non abbiamo esempi consimili da paragonargli. Ben è vero che nella novella 8° della Giornata V del Decamerone noi leggiamo di una pena sull’andare di questa, benchè per colpa tutt’altra. Ma quella storia non è creduta più in Italia: e forse non era tradizione indigena qui neppure a’ tempi del Boccaccio, che probabilmente la tolse ad imprestito al monaco francese Elinando, scrittore del 1200; e di suo capriccio la traspiantò nella pineta di Ravenna. Oltre dichè noi non viviamo sulla sponda del Reno. La ingiustizia feudale e l’insultante privilegio delle cacce riservate ai nobili sono mali che noi ora non proviamo. La narrazione di sciagure contemporanee, alle quali non partecipiamo, non sarà davvero udita con indifferenza; ma non ci commuoverà tanto, quanto i Tedeschi. L’uomo non può pensare all’uomo lontano e posto in circostanze diverse dalle sue, con quell’interessemedesimo, con cui egli pensa a sè stesso ed a’ vicini. Le lacrime del povero contadino, l’angoscia del mandriano, la pace dell’eremita profanata ci faranno pietà. Ma questa pietà, paragonata con quella de’Tedeschi, sarà minore d’assai; come il batticuore di noi europei mediterranei è minore di quello degli onesti fra gli abitanti delle colonie al rammentare la compassionevole Tratta dei Negri. Discendendo giù per questa scala di compassioni decrescenti si giunge fino a quel grado di affanno leggere leggero, con cui noi, viventi del secolo decimonono ascoltiamo le sventure degli Atridi, de’Tiestei e de’ Priamidi.
Cessate anche in Germania parte delle prepotenze feudali,variate anche alcune costumanze, mille memorie nondimeno di luogo e di nomi, mille affinità di patria e famiglie richiameranno la storia di quelle alla mente de’Tedeschi e per lunghissimi secoli: Così, e per le stesse ragioni, le sciagure che affissero anticamente i padri nostri in Italia, quantunque non più le medesime che proviamo noi, pure percuoteranno l’animo nostro con bastante vigore, ricordandole poeticamente. E come le iniquità, a modo d’esempio, de’ nostri Visconti non sarebbero mai sentite tanto fortemente da’ lettori tedeschi, quanto dagli italiani così la storia del Cacciatore feroce non lo sarà, temo, da noi, quanto da loro.
Non so indurmi a dar l’ultimo addio al Cacciatore feroce, se prima non fo qualche cosa a onore e gloria de’ commentatori e della consuetudine loro. Sappi dunque, o figliuolo, d’un pezzo di poesia italiana che ha qualche sorta di cognazione con questo del Bürger.
Erasmo di Valvasone, verso la fine del canto terzo del suo poema La Caccia, raccomanda a’ cacciatori di non uscire mai alla campagna sprovveduti di una messa sentita e dell’aiuto invocato di tutti i santi. E per ispaventare gli scapestrati, reca in mezzo la mala ventura di un certo Terone, ch’egli stesso, il poeta, dice d’aver conosciuto. Terone, mentre viveva giovinetto lungo la riva del nativo Tagliamento, era gran cacciatore e persona divota; e Dio l’aveva scampato sempre d’ogni pericolo. Fatto adulto, viaggiò tutta la Germania e v’imparò altri costumi. Tornò a casa, e non usò più né a messe né a chiese. Uncignale orribile metteva a guasto ed a spavento la campagna d’Aquilea: però una caccia generale fu bandita per tal domenica. Infinite genti v’intervennero, e Terone anch’egli, come il feritore più certo. La comitiva si recò sull’alba al tempio e non n’uscì che benedetta dal sacerdote. Terone solo si rimase, schernendo il rito. La caccia ha principio: la belva si appiatta in un pantano; è scoperta; i cacciatori le sono addosso. Ma impaurito si arretra ognuno. Solo a Terone il cuore non batte di paura. Egli bestemmia la viltà de’ compagni, bestemmia la lor divozione, bestemmia Dio; e si avventa alla fiera. Quella, come mossa dalla divina vendetta, sdegna ogni altro nemico e si scaglia su Terone, né lo lascia che dopo di avergli tolto e ardimento e vita. Dismessa poi la ferocia, anch’essa, la fiera, viene ad offrirsi da sé a’ colpi de’ cacciatori, e cade morta. E il poeta, che sente oramai stracco il suo colascione, dà fine al canto con un paio di versi, tutti novità di pensiero, tutti eleganza di modi:
Imparate giustizia, o genti umane,
e non spregiar le deità sovrane.
Virgilio glieli perdoni. E tu perdona a me se ti ho fatto ingozzare tutto questo episodio. Quel poema della Caccia so che non lo hai letto mai, né lo leggerai forse, benché stampato fra i Classici italiani; del che non vorrò biasimarti. Ma a’ discendenti di quegli eruditi che, zelanti della loro Italia, seppero trovare l’origine italiana del Paradiso perduto del Milton, io regalo questo bel pezzo del museo Valvasoni, insieme alla novella ottava della Giornata quinta del Decamerone, affinché ne compongano un solo manicaretto, e ne estraggano la quintessenza, e se la bevano; poi, con una predica scritta sugosamente, sul fare, per esempio, delle Orazioni di
monsignore della Casa, escano a ridomandare le sostanze che sono di nostro diritto, mostrando come in Italia v’abbia la semenza di tutto e come, infine del conto, gli stranieri non si facciano pavoni che con le penne nostre. Quella novella, per altro, del Boccaccio, a dirla tra di noi, è una grande infamia. Volere che la giustizia di Dio punisca di ripetute morti acerbissime una donna, perché costantemente ricusò di amare! E che diritto aveva Guido degli Anastagi, che diritto hanno gli uomini qualunque sul cuore femminino? È forse uno de’ comandamenti per la femmina il cedere alle voglie di chi la prega d’amore? Se Guido degli Anastagi s’era ammazzato, peggio per lui! L’amore è una passione spontanea che vive di libertà. E la donna, che si ostina a dirmi di no, mi farà infelice; ma della mia infelicità ella non può essere né accusata né condannata da legge veruna. La massima che le donne sieno in obbligo di riamare chi le ama, è uno de’ sofismi usati da’ seduttori. Limitandola anche al caso di amore onesto, cioè accompagnato dall’intenzione di strigner nozze, è una massima che fa a pugni colla dottrina de’ cristiani; atteso ché ella reputa stato di perfezione la castità del celibato. E per chi scriveva egli, il Boccaccio, se non per gente cattolica?
Pedanti e non pedanti hanno biasimato il Sannazaro, perché, non contento egli di avere già sparso bastantemente di erudizioni mitologiche antiche tutto quanto il suo poema sulla nascita di Gesù Cristo, De partu Virginis, abbia poi voluto introdurvi anche, come enti contemporanei ed operanti, le naiadi e le driadi. Ma l’errore del Sannazaro non è egli forse meno grave di cotesto del Boccaccio? Non è egli peggio forse il falsare la morale della religione che uno introduce nel suo componimento, di quello non sia l’unirvi alcune invenzioni eterogenee, col solo, innocente e manifesto proposito di sbizzarrirsi in fantasie poetiche?
Basterebbe che questa infame novella della pineta di Ravenna venisse creduta vera a’ dì nostri e lodata in Italia, perché fosse data vinta la causa a quegli stranieri che ci mandano titolo di vendicativi, di feroci, di superstiziosi e di poco religiosi nel cuore. Ma come è vero che noi non siamo così tristi, nessuno in Italia vorrebbe oggi avere scritto egli quel vituperio della pineta. E Dio lo tolga dalla memoria fino de’ bibliotecari!
Leggi ora, figliuolo mio, la traduzione della Eleonora.
ELEONORA
Sul far del mattino Eleonora sbalzò su agitata da sogni affannosi: «Sei tu infedele, o Guglielmo, o sei tu morto? E fino a quando indugerai?».
Egli era uscito coll’esercito del Re Federigo alla battaglia di Praga; e non aveva scritto mai se ne fosse scampato. Stanchi delle lunghe ire, il Re e l’Imperatrice ammollirono le feroci anime, e finalmente fecero pace. Ed ogni schiera, preceduta da inni, da cantici, dal fragore de’ timpani, da suoni e da sinfonie, adornata di verdi rami, si riduceva alle proprie case.
E da per tutto, da per tutto, sulle strade, sui sentieri, giovani e vecchi traevano incontro ai viva d’allegrezza de’ vegnenti. «Sia lode al cielo!» esclamavano fanciulli e mogli. «Ben venga!» esclamavano assai spose contente. Ma, oh Dio! per Eleonora non v’era né saluto, né bacio. Ella di qua di là cercò tutto l’esercito, dimandò tutti i nomi. Ma fra tanti reduci non uno v’era che le desse ragguaglio. Oltrepassate che furono da ultimo tutte quante le schiere, ella si stracciò la nera chioma, [6] e furibonda si buttò sul terreno.
Accorse precipitosa la madre. «O Dio, misericordia! Che hai, che t’avvenne, figlia mia cara?». E se la serrò fra le braccia.
– «O madre, madre! è perduto, è morto. Or vada in rovina il mondo, e tutto vada in rovina! Non ha misericordia Iddio. Ahi me misera! misera!».
– «O Dio, ne assisti! Misericordia, o Signore! Dí, figlia mia, dí un Paternostro. Quello che è fatto da Dio è ben fatto. Egli sí, Iddio, è pietoso di noi».
– «O madre, madre! Tutte illusioni! Nulla di bene ha fatto per me il Signore! nulla. Che giovarono, che giovarono le mie orazioni? Oramai non n’è piú bisogno».
«O Dio, ne assisti! Chi in Dio riconosce il nostro padre, sa ch’egli soccorre a’ figliuoli. Il santissimo Sacramento metterà calma al tuo affanno».
– «O madre, madre! Questo incendio che m’arde, non v’ha Sacramento che me lo calmi. Non v’ha Sacramento che restituisca a’ morti la vita».
– «Ascoltami, o cara; e se quell’uom falso, là lontano, nellUngheria, avesse rinnegata la fede per isposarsi ad altra donna? No, cara, non pensar piú a quel suo cuore. E neppure egli se ne troverà contento! Quando un giorno l’anima verrà a separarsi dal corpo, lui trarrà nelle fiamme il suo spergiuro».
– «O madre, madre! Non è piú, non è piú: egli è perduto, perduto per sempre. La morte, altro non mi resta che la morte! Oh non fossi io nata mai! Spegniti, luce mia, spegniti in perpetuo. Muori, muori sepolta nella notte e nell’orrore, No, non ha misericordia Iddio. Ahi me misera! misera!»
– «O Dio, ne assisti! Non voler no entrare, o Dio, in giudizio contro la povera tua creatura. Ella non sa quel che la sua lingua si dica: non tener conto dei peccati di lei. – Dimentica, figliuola mia, dimentica la tua afflizione terrena; pensa al Signore, pensa alla beatitudine eterna; e t’assicura che non verrà meno lo sposo all’anima tua».
– «E che è mai, o madre, la beatitudine eterna? Che mai, o madre, è l’Inferno? Con lui, con lui è beatitudine eterna; e senza di Guglielmo non v’ha, che inferno. Spegniti , luce mia, spegniti in perpetuo: muori, muori sepolta nella notte e nell’orrore! Senza di lui, né sulla terra, né fuori della terra posso aver pace io mai».
Cosí a lei nella mente e nelle vene infuriava la disperazione. Più e piú continuò temeraria ad accusare la Provvidenza di Dio; si percosse il seno; si storse le mani, fino al tramonto del sole, fino all’apparire delle stelle auree per la. volta del cielo.
Quand’ecco, trap trap trap, un calpestìo al di fuori come di zampa di destriero; e strepitante nell’armatura smontare agli scalini del verone un cavaliero. E tin tin tin, ecco sfrenarsi pian piano la campanella dell’uscio; e da traverso l’uscio venire queste distinte parole:
– «Su su! Apri, o mia cara, apri. Dormi tu, amor mio, o sei desta? Che intenzioni sono ancora le tue verso di me? Piangi, o sei lieta?».
«Oh cielo! Tu, Guglielmo? Tu… di notte… cosí tardi…? Ho pianto, ho vegliato. Ahi misera! un grande affanno ho sostenuto… E donde vieni tu cosí a cavallo?».
– «Noi non mettiamo sella che a mezzanotte. Lungo viaggio cavalcai a questa volta, fino dalla Boemia. Tardi ho preso il cammino, tardi: e voglio condurti meco».
– «Ah Guglielmo! Entra prima qua dentro un istante. Su presto! Il vento fischia ne’ roveti. Entra, vieni, cuor mio carissimo, a riscaldarti fra le mie braccia».
– «Lascia pure che il vento fischi fra i roveti: lascialo fischiare, anima mia, lascialo fischiare. Il mio cavallo morello raspa; il mio sprone suona. In questo luogo non m’è concesso alloggiare. Vieni, succingiti, spicca un salto, e gettati in groppa al mio morello. Ben cento miglia mi restano a correre teco quest’oggi per arrivare al letto nuziale».
– «Oh cielo! E tu vorresti in questo sol giorno trasportarmi per cento miglia fino al letto nuziale? Odi come romba tuttavia la campana– le undici sono già battute».
– «Gira, gira lo sguardo. Vedi, fa un bel chiaro di luna. Noi e i morti cavalchiamo in furia. Oggi, sí quest’oggi, scommetto ch’io ti porto nel letto nuziale».
– «E dov’è, dimmi, dov’è la cameretta? E dove, e che letticciuolo nuziale è il tuo?».
– «Lontano, lontano di qui…, in mezzo al silenzio…, alla frescura…, angusto… Sei assi… e due assicelle…».
– «V’ha spazio per me?».
– «Per te e per me. Vieni, succingiti, spicca un salto, e gettati in groppa. I convitati alle nozze aspettano; la camera è già schiusa per noi».
La vezzosa donzelletta innamorata si succinse, spiccò un salto, snella si gittò in groppa al cavallo, e con le candide mani tutta si ristrinse all’amato cavaliere. E arri arri arri! salta salta salta; e l’aria sibilava rotta dal gran galoppare. Sbuffavano cavallo e cavaliere; e sparpagliavansi intorno sabbia e scintille.
A destra e a sinistra, deh! come fuggivano loro innanzi allo sguardo e pascoli e lande e paesi! Come sotto la pesta rintronavano i ponti! – «E tu hai paura, o mia cara? Vedi bel chiaro di luna! Arri arri! I morti cavalcano in furia. E tu, mia, cara, hai paura de’ morti?».
– «Ah no! Ma lasciali in pace i morti!».
Da colaggiú qual canto, qual suono mai rimbombò? Che svolazzare fu quello de’ corvi? Odi suono di squille, odi canto di morte! «Seppelliamo il cadavere».
Ed ecco avvicinarsi una comitiva funebre, e recar la cassa e la bara de’ morti. E l’inno somigliava al gracidar dei rospi negli stagni.
– «Passata la mezzanotte, seppellirete il cadavere con suoni e cantici e compianti. Ora io accompagno a casa la giovinetta mia sposa. Entrate meco, entrate al convito nuziale. Vieni, o sagrestano; vieni col coro, e precedimi intuonando il cantico delle nozze. Vieni, o sacerdote; vieni a darci la benedizione prima che ci mettiamo a giacere».
Tace il suono, tace il canto; la bara sparí. E obbedienti, alla chiamata quelli correvano veloci, arri arri arri! lí lí sulle peste del morello. E va e va e va; salta salta salta; e l’aria sibilava rotta dal gran galoppare. Sbuffavano cavallo e cavaliere; e sparpagliavansi intorno sabbia e scintille. Deh come fuggivano a destra, come a sinistra fuggiva e montagne e piante e siepi! Come fuggivano a sinistra, destra, e ville e città e borghi!
– «E tu hai paura, o mia cara? Vedi bel chiaro di luna Arri arri arri! I morti cavalcano in furia. E tu, mia cara, hai paura dei morti?».
– «Ahi misera! Lasciali in pace i morti».
Ecco; ecco; là sul patibolo, al lume incerto della luna una ciurma di larve balla intorno al perno della ruota! [7]
– «Qua qua, o larve. Venite, seguitemi. Ballateci la giga degli ,sposi, quando saliremo in letto». E via via via, le larve gli stormivano dietro a’ passi, come turbine che in una selvetta di noccioli stride fra mezzo all’arida frasca.
E va e va e va; salta salta salta; e l’aria sibilava rotta dal gran galoppare. Sbuffavano cavallo e cavaliere; e sparpagliavinsi intorno sabbia e scintille. Ogni cosa che la luna illuminava d’intorno, deh! come ratto fuggiva, come fuggiva alla lontana! Come fuggivano e cieli e stelle al disopra di lui!
– «E tu hai paura, mia cara? Vedi bel chiaro di luna? Arri arri arni !I morti cavalcano in furia. Ed hai tuttavia paura dei morti, o mia cara?».
– «Ahi me misera! Lasciali in pace i morti».
– «Su su, o morello! Parmi che il gallo già canti. Fra Poco il sabbione sarà omai tutto trascorso. Su, morello, morello! Al fiuto sento già l’aria del mattino. Di qua, o morello, caracolla di qua. Finito, finito abbiamo di correre. Eccolo che s’apre il letto nuziale. I morti cavalcano in furia. Eccola, eccola la meta».
Impetuoso s’avventò a briglia sciolta contro un cancello di ferro. Ad uno sferzar di scudiscio toppa e chiavistello gli si spezzarono innanzi; e le ferree imposte cigolando si spalancarono. Il destriero drizzò la foga su per le sepolture. E al chiaror della luna tutto tutto biancheggiava di monumenti.
Ed ecco, ecco in un subito, portento, ahi, spaventoso! Di dosso al cavaliere ecco, a brandelli a brandelli cascar l’armatura, com’esca logorata dagli anni! In teschio senza ciocche e senza ciuffo, in teschio ignudo ignudo gli si convertí il capo; e la persona in ischeletro armato di ronca e d’oriuolo.
Alto s’impennò e inferocí sbuffando il morello, e schizzò scintille di fuoco. E via, eccolo sparito e sprofondato disotto alla fanciulla; e strida e strida su per l’aere; e venir dal fondo della fossa un ululato! … A gran palpiti tremava il cuore d’Eleonora, e combatteva tra la morte e la vita.
Allora sí, allora sotto il raggio della luna danzarono a tondo a tondo le larve; ed intrecciando il ballo della catena, con feroci urli ripetevano questa nenia:– «Abbi pazienza, pazienza; s’anche il cuore ti scoppia. Con Dio no, con Dio non venire a contesa. Eccoti sciolta dal corpo. Iddio usi all’anima misericordia!».
A differenza della prima, la favola di questo secondo romanzo, a quel ch’io sappia, è tutta invenzione del poeta. Parrebbe dunque che, non sostenuta da una tradizione, l’Eleonora non dovesse trovare né fede né applausi neppure in Germania. E nondimeno è noto come ella sia colà la lodatissima delle poesie del Bürger. A che ascriveremo noi questo? I popoli colti d’una parte della Germania, pe’ quali il Bürger cantava, sono inclinati all’entusiasmo. Avidi essi di emozioni, non aspettano che quelle vengano di per sé; ma per ottenerne, si aiutano fin anche del meditare. Il bisogno fortissimo di emozioni nasce in loro, se mal non veggo, per la mancanza di una continua varietà di oggetti esteriori che possa occuparli e muoverne gli animi piacevolmente. E questa mancanza è prodotta dalle circostanze politiche, da quelle del clima, della geografia loro e della loro vita sociale. Ma le circostanze medesime, se per un riguardo gli offendono, servono per un altro a rinforzare notabilmente la loro riflessione, allorché la noia gli obbliga a concentrarsi in se stessi, a ripiegarsi nell’animo proprio, onde provarne il moto che li faccia accorti dell’esistenza. Educati così alla meditazione, non di rado giungono essi a scoprire qualche lato importante e patetico nelle cose, in cui sguardo superficiale nol vede. Tosto che l’hanno adocchiato, eglino vi si affezionano e s’infervorano; e l’amore di una parte tira seco l’amore del tutto.
Con ciò viene a spiegarsi per noi da che provenga l’affettazione di certo sentimentalismo che governa spesso il discorso de’ romanzieri del nord, e che male è imitato da’ romanzieri di Francia, e mal sarebbe da que’ d’Italia; perché posa su pensieri ed affetti che non sono sentiti in Francia e in Italia né da chi scrive né da chi legge. Quante volte l’uomo del nord, viaggiando in Italia, non fa egli strabiliare gli ospiti suoi, parlando ogni tratto di sensazioni domestiche, di piaceri segreti dell’animo, di simpatie recondite, di compassioni prodigalizzate a un fiorellino del campo, di lagrime sparse per pietà di un asinello defunto, di memorie lugubri suscitate in lui dalla menoma novità di nugoloni colorati! Pare a noi che egli allora monti sull’ippogrifo. Eppure chi sa che per lunga assuefazione egli non abbia il cuore, troppo più che noi non ci figuriamo, pronto a palpitare per tante fantasie? A quelle docili immaginazioni bastò quindi pensare che la finzione dell’Eleonora era omogenea ed analoga alle tradizioni popolari, perché a lei anche estendessero il vero di opinione che quelle hanno. La stravaganza del tutto non nocque allora più all’effetto delle parti. E siccome le parti sono bellissime, l’approvazione e l’ammirazione vennero di per sé.
Noi popoli più meridionali, circondati dalla pompa della natura e dalla perpetua successione delle sue infinite lusinghe, non abbiamo mestieri di andare in traccia di emozioni per sentire la vita. Noi aspettiamo che quelle ci riscuotano come a viva forza; ma non ci curiamo di promuoverle noi col nostro entusiasmo. Di qui, più che lettori appassionati, noi riesciamo critici freddi. E prima di dare una lagrima alle sventure di Eleonora, noi metteremo sul bilancino i gradi di verisimiglianza che ha la storia della fanciulla, e non li pagheremo della nostra credenza che grano per grano.
Forse, e bada bene che tiro a indovinare e non altro, forse gli abitanti d’una parte della Germania, de’ quali ho parlato fin qui, hanno, o nel fondo del cuore o dentro la mente, più religione che noi non abbiamo. Forse, avvezzati essi dalle sette e dalla necessità delle controversie ameditare i dogmi della religione, come noi a prestarle fede senza meditazioni, hanno talmente inclinati i pensieri a lei, che tutto quanto partecipa dello spirito del Cristianesimo essi lo sentono di primo tratto, qualunque sia l’oggetto che gli occupi, qualunque sia lo stato dell’animo loro.
Quindi è forse che il Tedesco, leggendo il Romanzo dell’Eleonora, lascia bensì che il cuore di lui si pieghi a compassione delle sventure della fanciulla; ma immediatamente corre colla idea all’enormità del peccato commesso da lei nel rinnegare la provvidenza di Dio. Associata a quella idea eccoti subito l’altra: che ogni vendetta di Dio, per quanto fiera ella sembri a umano intendimento, non può mai aggiungere a tanto da pareggiare l’immensità del delitto di cui si fa reo chi offende Dio di qualsivoglia maniera. Mesci ora insieme il sussidio delle idee religiose alla somiglianza che la favola dell’Eleonora dicemmo avere colle tradizioni popolari in Germania; e vedi come il tedesco s’induca ad essere liberale di credenza verso la catastrofe del romanzo. Nell’animo di lui direi quasi che il sentimento massimo sarà quello dell’enormità del peccato e della maestà di Dio irritata, e che la compassione per gli affanni amorosi della fanciulla non sarà che un sentimento concomitante.
Se l’Italia leggente fosse composta di uomini tutti profondamente studiosi della loro religione, forse l’Eleonora, scendendo tra di noi, non verrebbe a capitare in terra straniera affatto. Ma quantunque in Italia v’abbiano teologi eruditissimi, io temo che il più degli italiani, ancorché cattolici di buona fede, non si siano addimesticati tanto coi dogmi della loro religione da salvare per questi una costante reminiscenza in tutte le loro sensazioni. Il lettore teologo, anche in mezzo alle seduzioni della poesia, anche sbattuto dai palpiti ch’ella produce, starà fermo alle dottrine da lui conosciute e professate, e stabilirà tosto relazioni tra quelle e ciò ch’ei legge. Un lato della sua mente egli lo tiene vergine sempre di tutt’altri pensieri, salvo i religiosi. Però egli sentirà il maraviglioso e il terribile del Romanzo dell’Eleonora; e l’idea della divinità oltraggiata e della severità onnipossente, che procede dalla giustizia di Dio, gli ingombrerà tanto l’anima, da lasciargliene una parte ben poca in preda ad altre riflessionie ad altri affetti. Pieno di spavento, egli chinerà il capo innanzi a Dio; ripeterà anch’egli la nenia delle larve, e finirà esclamando: «Salvami, o Signore, salvami dall’offenderti!».
Ma avremo, noi, lettori teologi molti? O io m’inganno, o tra di noi sarà maggiore il numero di quelli che, facili a scusare negli altri le passioni perché le vorrebbono scusate a sé medesimi, si lasceranno andare alla pietà, come al sentimento più repentino per essi. Cedendo all’impeto delle prime impressioni cagionate dalle miserie d’Eleonora, e non interrogando gran fatto il sentimento religioso, che in essi, a differenza de’ tedeschi, riescirà il meno forte, eglino, parmi, diranno così: «Una povera vergine innamorata, disperante della vita del suo sposo futuro, inasprita dal peso della disgrazia e dalla importunità dei consigli di una vecchia assiderata, perché nell’impeto del dolore (e che dolore!) si lasciò fuggire di bocca la rinnegazione della provvidenza, meritava ella di essere sepolta viva? meritava che il ministro dell’ira di Dio fosse quello stesso amante per cui ella aveva spasimato tanto? meritava che questi alla gelata indifferenza dovesse anche aggiungere la crudeltà della ironia, e continuarla fino all’ultimo della vita? Se dopo lunghe macchinazioni, ella fredda fredda avesse per avarizia piantato un coltello nel petto al padre e strozzata la madre, le starebbe bene questo ed ogni altro rigore di pena; ma nel delirio dell’amore… per una parola inconsiderata… tanto supplizio! No, non può essere. Il Dio nostro è il Dio della misericordia. Tratto a doverci visitare nell’ira sua, egli guarda pur sempre all’intenzione del peccatore, e distingue il delirio d’una passione innocente dalla gelida, ostinata empietà. Eleonora ha peccato. Ma qual proporzione qui tra ’l peccato e la pena? No no, la storia d’Eleonora non è credibile. E’ una invenzione nera nera che mette ribrezzo; è una favola da nutrici che non è raccomandata da verisimiglianza veruna, e che non merita neppure una, sola delle nostre lagrime». Davvero, io non torrei a difendere innanzi al Santo Offizio l’ortodossia di chi ragionasse cosí. Davvero sono persuaso che qualunque persona trascorresse a discorsi siffatti, dopo piu mature considerazioni se ne disdirebbe. Ma, fattili una volta, e rovinato con ciò l’effetto primo di questa poesia, come trovarla bella dappoi? Come gradir bene dappoi ciò che sulle prime n’è venuto in fastidio?
– E che a molti si aggireranno pel capo pensieri simili a questi ch’io portai qui sopra, oserei scommetterlo.
– Non mi dorrebbe di rimanere perdente; anzi ’l desidero. Ad ogni modo in entrambi questi Romanzi, e piú nel secondo, v’ha qualche cosa di magico che non si lascia definire. Ed io conosco uomini in Italia che, capaci quant’altri di esercitare la critica, pure fu loro necessità metterla in silenzio, perché sentivansi l’anima strascinata dalla prepotenza del terribile, intenerita dal patetico che regna in questi componimenti. E la monotonia stessa che qua e là il poeta vi sparse, rendeva piú profonda e piú perseverante la commozione. Dopo un esperimento siffatto, io credo di potere rispondere a te che in Italia altri rideranno freddamente di questi due romanzi, altri diranno essere un peccato l’avere arricchito di tanta poesia argomenti da non trattarsi, ed altri si trasporteranno alle circostanze del popolo, per cui furono scritti, ed assumendone le opinioni e l’entusiasmo, divideranno con lui la pietà, la maraviglia e il terrore. Parmi che gli ultimi, comeché pochi forse, mostreranno indole piú poetica.
In quanto a te, se mai ti nascesse voglia di scrivere Romanzi in Italia sul fare di questi, va cauto, e fa di non lasciarti traviare in soggetti non verisimili, quando essi siano tolti di peso dalla fantasia tua. Che, se l’argomento ti viene prestato da una storia scritta o da una tradizione che dica: il tal fatto è accaduto cosí, e tu senti che comunemente è creduto cosí, allora non istare ad angariarti il cervello per timore dinverosimiglianze, dacché tu hai le spalle al muro. Però nella scelta siati raccomandato di tenerti piú volontieri ai soggetti ricavati dalla storia, che non agli ideali. Né ti fidare molto a quelle tradizioni che non esciranno mai dal ricinto d’un sol municipio, perché la fama tua non sarebbe che municipale: del che non ti vorrei contento.
Finalmente, se i due componimenti del Burger che ti stanno ora innanzi, e che furono immaginati per la Germania e proporzionati a que’ lettori, non piaceranno universalmente in Italia, bada bene a non inferire da questo che la letteratura tedesca sia tutta incompatibile col gusto nostro. Vi hanno in Germania componimenti moltissimi fondati su maniere e su geni comuni a’ Tedeschi, a noi, ed al resto dell’Europa colta. E il dire che un po’ piú un po’ meno di lucidezza di sole, renda affatto affatto opposte tra di loro le menti umane, ed inaccordabili onninamente le operazioni intellettuali di chi vive tre mesi fra le nebbie con quelle di chi ne vive sei, è puerilità tanto piú ripetuta, quanto ella è piú facile a dar vita ad un meschino epigramma. Se ne’ Greci e ne’ Latini troviamo cose ripugnanti al genio della poesia italiana, e lo confessiamo, perché infastidirci se ne’ Francesi, negli Spagnuoli, negli Inglesi e ne’ Tedeschi ne scopriamo parimenti, che vogliono da noi rifiutarsi? O leggere nulla, o legger tutto fa d’uopo. Però io, portando opinione che il secondo partito sia da scegliersi, credo che anche lo studio del Cacciatore feroce e della Eleonora sarà utile in Italia; perché mostra da quali fonti i valenti poeti d’una parte della Germania derivino la poesia plaudita nel loro paese. Cercarono essi con somma cura di prevalersi di tutte le passioni, di tutte le opinioni, di tutti i sentimenti de’ loro compatriotti; e trovarono cosí argomenti che vincono l’animo universalmente.
Facciamo lo stesso anche noi. E la poesia italiana si arricchirà di nuove bellezze, talvolta originali molto, e sempre caratteristiche del secolo in cui viviamo. Cosí vedremo moltiplicarsi i soggetti moderni, e riescir belli e graditi quanto il Filippo, il Mattino, la Basvilliana e l’Ortis. E forse anche noi conseguiremo scrittori di Romanzi in prosa, tanto quanto i Francesi, gli Inglesi, e i Tedeschi. Figliuolo carissimo, se tu hai ingegno, com’ío spero, ti sarai pure accorto che fin qui la lettera mia non fu che uno scherzo. La gravità, con cui in questa tiritera di commento ho affastellate tante stramberie, è una gravità tolta a nolo: e la costanza della ironia sbalza agli occhi di per sé. Ho voluto spassarmi a spese de’ novatori. Ma con te, figliuolo, con te coscienza di padre mi grida ch’io lasci le baie, e mi metta finalmente sul serio.
Sappi dunque che fuori d’Italia gli uomini vanno carpone in materia di letteratura. Sappi che se tu, tralignando da’ maestri tuoi, metterai naso ne’ libri oltramontani, finirai anche tu col muso al pavimento. Questo voler dividere i lavori della poesia in due battaglioni, classico e romantico, sa dell’eretico; ed è appunto un trovato d’eretici; e non è e non piò esser cosa buona; da che la Crusca non ne fa menzione, e neppure registra il vocabolo «Romantico».
Tutti sanno che in Inghilterra e in Germania non si coltiva da letterato veruno né la lingua greca né la, latina, e che non si ha contezza ivi degli scrittori di Atene e Roma, se non per mezzo di traduzioni, italiane. Separa cosí quasi affatto dalla conoscenza de’ capi d’opera dell’atichità, come potevano quegli infelici far Poesie, e non da in ciampanelle? Poi vollero giustificare i loro strafalcioni e congiurarono co’ loro fratelli filosofi, e tentarono la metafisica e la logica, e dettarono sistemi. Ma tutti insieme i congiurati diedero in nuove ciampanelle, perché la metafisica e la logica sono piante che non allignano che in Italia.
Figurati che arrivarono fino a dire, quasi, che la Religione Cristiana ha resa piú malinconica e piú meditativa la mente dell’uorno; ch’ella gli ha insegnato delle speranze e de’ timori ignoti in prima; che le passioni de’ Cristiani, quantunque rivolte a oggetti esteriori, hanno pure una perpetua mischianza con qualche cosa di piú intimo che non avevano que de’ Pagani; che in noi è frequente il contrasto tra ’l desiderio e ’l dovere, tra l’intolleranza delle sventure e la so messione ai decreti del cielo; che i poeti nostri, per non riescire plagiari gelati, bisogna che pongano mente a ques tinte, e dipingano oggi le passioni con tratti diversi dagli antichi; e che, e che, e cento altri che di tal fatta, e miserabilissimi tutti. E davvero a volere stramazzare quegli atleti sterebbe, a modo d’esempio, instituire, come noi lo possiamo far bene e non essi, un paragone analitico tra Anacreonte Tibullo da una parte, e ‘l Petrarca dall’altra; e dimostrare come i patimenti dei due primi innamorati siano gli stessi stessissimi patimenti che travagliavano l’animo al Petrarca. E chi non sente, infatti, che que’ tre amori, per somiglianza tra di loro, sono proprio tre gocciole d’acqua? Alcuni cervellini d’Italia, che non sanno né di latino né di greco, lingue per essi troppo ardue, vorrebbero menar superbia dell’avere imparate le lingue del Nord, che ognuno impara in due settimane, tanto sono facili. Però fanno ego a tutte queste fandonie estetiche, che in fine in fine non valgono né le pianelle pure di Longino, non che il suo libro Del Sublime, che è la maraviglia dell’umano sapere. Il quale umano sapere non è mica progressivo e perfettibile, come i fatti pertinacemente attestano; ma è sempre stato immobile, e non può di sua natura patire incremento mai, per la gran ragione che nil sub sole novum.
E questi cervellini battono poi le mani ad ogni frascheria che viene di lontano e corrono dietro a Shakespeare ed allo Schiller, come i bamboli alle prime farfalle in cui si abbattono, perché non sanno che ve n’ha di piú occhiute e di piú vaghe.
Ma viva Dio! quello Shakespeare è un matto senza freno; traduce sul teatro gli uomini tal quali sono; la vita umana tal quale è; lascia ch’entri in dialogo l’eroe col becchino, il principe col sicario; cose che non sono permesse che agli eroi da vero e non da scena. E invece di mandarti a fiamme l’anima con belle dissertazioni politiche, con argomenti Pro e contra a modo de’ nostri avvocati, egli ti pone sott’occhio le virtú ed i vizi in azione: il che ti scema l’interesse, e ti fa tepido. Quello Schiller poi, se ’l paragoni, non dico con altri, ma col solo Seneca, ti spira miseria.
A buon conto gli stessi novatori, mentre si aguzzano alla disperata onde predicarne le lodi, sono costretti dal coltello alla gola a confessare che le opere di Shakespeare e dello Schiller; quantunque, come essi dicono, maravigliose in totale, non vanno scevre di magagne, se si guarda separatamente alle parti. E s’ha a dire bel libro di poesia, e degno di lettura quello che non può vantarsi incontaminato d’ogni menomo peccato veniale? I grandi poeti dell’antichità sono invece fiocchi sempre sempre di tutta neve immacolata.
Ed è poco misfatto rispettare l’unità d’azione, che è la meno importante, per dare un calcio poi alle unità di tempo e di luogo, che formano il cardine della nostra fede drammatica, fuori della quale non v’ha salute? E noi dovremmo sorgere ammiratori di ribaldi tanto sfrontati, noi pronipoti d’Orazio, del Vida e del Menzini? Era aforismo che nel giro di ventiquattro ore e nulla piú dovesse andare ristretta l’azione di un dramma. I meno puristi hanno spinta ora la tolleranza fino a concederne altre dodici, purché ciò non passasse in esempio di nuove larghezze; e basta cosí.
L’uomo per virtú della illusione teatrale può arrivare a tanto ch’egli persuada a sé stesso d’essere vissuto trentasei ore, quando non ne ha vissute che le poche tre, per le quali dura lo spettacolo. Ma a un minuto di più la povera mente umana non regge colla sua immaginativa. L’esattezza del computo non è da porsi in dubbio, Poiché il Buon Gusto egli medesimo, armato di gesso, sedeva alla lavagna disegnando, 36 = 3.
E la illusione teatrale noi sappiamo essere la illusione di tutte le illusioni, la magia per eccellenza; da che, come due e due fanno quattro così anche, ad onta della verità, è provato che dallo alzarsi fino al calar del sipario lo spettatore si dimentica affatto di ogni sua occcorrenza domestica, non sa piú d’esser in teatro, giura ch’egli manda occhiate proprio nel Ceramico e nel Partenone, e crede vere proprio le coltellate che si dànno gli eroi sul palco, e vero sangue quello che gronda dalle ferite.
Quanta sia poi l’importanza della unità di luogo è da vedersi in quelle tante pagine che in favore di lei avrebbe dovuto scrivere Aristotile. E il ribellarsi ad Aristotile, parlante o tacente ch’egli sia sarebbe infamia.
Per decreto de’ Romantici la mitologia antica vada tutta in perdizione. Ma, pe’, gorghi Strimoni! questo ostracismo lascia egli sperare briciolo di ragionevolezza in chi l’invoca? Perché rapirci ciò che ne tocca più da vicino? E come prestar venustà alla Lirica, come vestire di verità i concetti, di splendore le immagini, senza Minerve, senza Giunoni, senza Mercuri, che pur sentiamo apparire ogni notte, in ogni ad ogni fedel cristiano? Come parlar di guerre, senza far sedere Bellona a cassetta d’un qualche coupé, senza metterle in mano la briglia d’un paio di morellotti d’Andalusia. E non è noto forse, per deposizione di tutti i soldati reduci, com’anche a Waterloo quella dea sia stata veduta correre su e giú pel campo, vestita di velluto nero, con due pistole nere in cintura, e con in testa un cappelletto nero all’iglese?
Ut pictura poésis. E ciò che concedete alla pittura, lo avete a concedere anche alla poesia, a dispetto della persuasione e delle dimostrazioni irrefragabili del Lessing. E sapete perché? Perché lo ha detto chi poteva dirlo, chi poteva con piena potestà comandarlo, chi aveva rubata al Papa l’infallibilità, prima che il Papa nascesse, Orazio insomma. E zitti per carità.
Non è meraviglia poi se genti farnetiche, le quali mischiano psicologia fino nel parlar di canzoni, vestono oggi il sacco del missionario, ed esclamano: «Voi, Italiani, avete un bel suolo, un bel cielo, una bella lingua; ma dei tesori intellettuali, di cui va ricca oggimai tutta insieme l’Europa, voi non ne possedete quanto certi altri popoli. Voi ci foste maestri un tempo; adesso non piú. Alcuni tra voi coltivano bene le scienze fisiche e matematiche; ma di buone lettere e di scienze morali voi di presente patite penuria, avendo troppo poche persone eccellenti in questi generi».
Noi dunque penuriamo? Bravi davvero! Lasciamo stare che tutto quel poco che si sa fuori d’Italia è tutto dono nostro. Lasciamo stare che noi potremmo comperare mezzo il Mogol, se voi, stranieri, ci pagaste solamente un baiocco per ogni sonetto stampato da venti anni in qua in Italia, e che noi per un baiocco l’uno acconsentiremmo di vendervi. Lasciamo stare che da venti anni in qua noi abbiamo immaginati libri tali di letteratura, da potere squadernarli sul viso a qualunque detrattore, allorché ci risolveremo a comporli ed a svergognare il resto d’Europa. Lasciamo stare che in Firenze e fuori di Firenze vi hanno giornali che vegliano dí e notte alla vendetta, e che con brevi ma calzanti argomenti rovinano i paralogismi, e mandano scornata l’arroganza di chi ne minaccia assalto; e, quel che è proprio edificante, usando sempre rispetto verso le persone, decenza nei modi, e galanteria fiorita coi rivali di sesso gentile: arti tutte non praticate che in Italia, perché il Galateo è nato qui. Lasciamo stare che le ingiurie de’ nostri nimici, non appena scorsi diciannove anni da che sono stampate, cosí calde calde noi le confutiamo: tanto è vero che in Italia non si dorme! Lasciamo stare che da qui ad altri diciannove anni saremo pronti a ripetere le, osservazioni in lode dell’Italia che trovansi stampate ne’ líbri di quegli stessi nemici, e non leggonsi ne’ libri nostri. Lasciamo stare, dico, tutto questo. Sia pur vero l’ozio letteirario, di che ne si vuole rimproverare. Ma che potete voi dire di píú lusinghiero per noi? Questo nostro far nulla per le lettere non è egli il documento piú autentico della ricchezza che n’abbiamo? Chi non ha rinomanza, stenti la sua vita per guadagnarsela. Chi non ereditò patrimonio, sudi la vita sua a ragunarne uno. La letteratura d’Italia è un pingue fedecommesso. Bella, e fatta l’hanno trasmessa a noi i padri nostri. Né ci stringe altro obbligo che di gridare ogni dí trenta volte i nomi e la memoria de’ fondatori del fedecommesso, e di tramandarlo poi tal quale a’ figli nostri, perché ne godano l’usufrutto e il titolo in santa pace.
Però non ti dia scandalo, figliuolo mio, se certi lilliputi nostrali, non trovando altro modo a scuotersi giú dalle spalle l’oscurità, si dànno a parteggiare nel seno della cara patria, e ripetono per le contrade della cara patria la sentenza universale d’Europa contro la cara patria nostra. Oltrediché questi degeneri figli dell’Italia oseranno anche sussurrarti altre bestemmie all’orecchio; come a dire, che la confessione de’ propri difetti è indizio di generosità d’animo; che il nasconderli quando sono già palesi a tutti, è viltà ridicola; che il primo passo al far bene è il conoscere di aver fatto male; che questa conoscenza valse a’ Francesi il secolo di Luigi decimoquarto, alla Germania il secolo diciottesimo; e che infine poi anche Dante, anche il Petrarca e l’Ariosto e ’l Machiavello e l’Alfieri stimarono lecito lo scagliare invettive amare contro l’Italia. Oibò! non è vero. Que’ brutti passi [8] furono malignamente inseriti nelle, opere loro dagli editori oltramontani; e la trufferia è manifesta. È egli credibile che gente italiana per la vita cadesse in tanta empietà? Chiunque ama davvero la patria sua non cerca di migliorarne la condizione. Chi tasta nel polso al fratello suo la febbre mortale, se ama lui davvero, gliela tace; non gli consiglia farmaco mai né letto, e lo lascia andar diritto al Creatore.
E tu, allorché uscirai di collegio, preparati a dichiararti nemico d’ogni novità; o il mio viso non lo vedrai sereno unquanco. «Unquanco» dico; e questo solo avverbio ti faccia fede che il vocabolario della Crusca io lo rispetto; come ché io, conciossiaché di piccola levatura uomo io mi sia, a otta a otta mal mio grado pe’ triboli fuorviato avere, eper tal convenente io lui, avegna Dio che niente ne fosse, in non calere mettere parere disconsentire non ardisca.
Per l’onor tuo intanto e pel mio e per quello della patria nostra, ti scongiuro ad usar bene del tempo. Però bell’e finito mandami presto quell’idillio in cui introduci Menalca e Melibeo a cantare tutta quanta, alla distesa, la genealogia di Agamennone miceneo. La via della gloria ti sta aperta. Addio.
*******
[1] Dunque l’Italia è bagascia, vecchia, bevona, oziosa, senza occhi, senza bontà, corrotta e fetente. Se tutte queste contumelie fossero farina proprio del sacco degli autori a cui sono attribuite, e non tradimenti stranieri, bella e bizzarra materia di discorso avrebbe chi pigliasse a dimostrare che le vere glorie d’Italia derivano da chi la sgrida e ch’ella tanto piú onora i suoi, quanto piú liberamente le rinfacciano le vergogne di lei.
Nota di GIACOMO fratello di GRISOSTOMO.
[2] Il Bouterweck nella sua Estetica, riconoscendo tuttavia l’eccellenza di questi due Romanzi, ne censura l’autore per questo solo, che dava ad essi titolo di Poesie epico-liricbe: censura che in un filosofo mette stupore; da che l’epiteto di «epico-lirici» caratterizza ottimamente sí fatti componimenti. Tutti sanno che la poesia epica, definendone il senso più generico e più filosofico e prescindendo dalle distinzioni de’ Retori, significa poesia narrativa: e i due poemetti, di cui trattasi, sono narrazioni. E la forma epica è poi mescolata in essi colla forma lirica, attesa la qualità del metro, che è di versetti lirici rimati e scompartiti in tante strofe. Nell’edizione, per altro, che ho sott’occhio i due Romanzi, stampati in un fascio con altri, non portano titolo che di Poesie semplicemente: Gedichte. Volendo servire ad una scrupolosa esattezza nel classificare i lavori de’ poeti, parmi che alcune Odi di Orazio ed alcune Odi e Canzoni nostre meriterebbero anch’esse il nome di Romanzi, consistendo appunto in narrazioni: come, a modo d’esempio, la Canzone del Guidi sulla Fortuna. E che altro è, infatti, quella Canzone, se non un racconto di una apparizione immaginaria della Dea Fortuna, di un dialogo seco lei, e d’una vendetta che ella consuma? Ma ho detto che poesie del genere di codeste del Bürger non furono forse mai scritte da’ letterati in Italia, per la somma differenza che codeste hanno per cento lati coll’ode del Guidi, e con altre che si potrebbero citare.
[3] Il testo ha «der Wild-und Rheingraf». Certa famiglia di Conti del Reno discendente da Rheingrafenstein porta il nome di Wild-und Rheingraf.-Adelung, Gran. Dizion.O (Art. Rheingraf.).
[4] I comuni in Germania pagano un mandriano. Questi ha l’obbligo di menare al pascolo comunale, e di guardare tutte insieme le bestie che i contadini gli affidano; e ciò perché la povera gente abbia tempo di badare alle proprie faccende domestiche e rurali, e i ragazzi non siano tolti alla scuola per mandarli a condurre vacche e asinelli.
[5] Le ragioni sono, che a nessuno il quale abbia veduto il portento è lecito rivelarne la particolarità. Così comandando la tradizione superstiziosa ha provveduto ella stessa alla propria durata.
[6] Il testo ha «Rabenhaar», vocabolo composto da corvi e da chioma, «chioma corvina». In italiano, per la sola necessità dei due vocaboli separati, l’idea perderebbe rapidità, e parrebbe affettazione.
[7] Terminato il supplizio de’ rotati è uso in Germania di Piantare in mezzo del’ palco un palo alto, in cima a cui è ficcata Orizzontalmente la ruota fatale. Su di questa buttansi i cadaveri de’ giustiziati. E vi stanno a spavento dei tristi e ad orrore de’ viandanti, finché il tempo ve li lascia stare.
[8] Dante: Non donna di provincie, ma bordello (l’Italia).
Purg., Canto VI.
Petrarca: Italia, che suoi guai non par che senta,
Vecchia oziosa e lenta
Dormirà sempre … ?
Canz. XI, «Spirto gentil»
Ariosto: … l’accecata Italia, d’error piena.
Orl. Fur., Canto XXXIV.
E altrove: O d’ogni vizio fetida sentina,
Dormi, Italia imbriaca…
Machiavello: «Non si può sperare nulla di bene nelle provincie che in questi tempi si veggono corrotte, com’è l’Italia sopra tutte le altre; e ancora la Francia e la Spagna di tale corruzione ritengono parte», ecc.
Discorsi sop. T. L., Lib. I, cap. 55 e passim passim passim su questo gusto.
Alfieri: Nell’ozio e ne’ piacer noiosa immersa (l’Italia).
Sonetto 143.