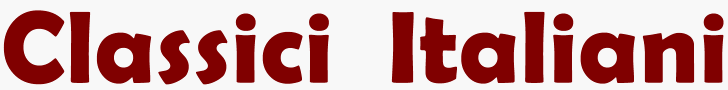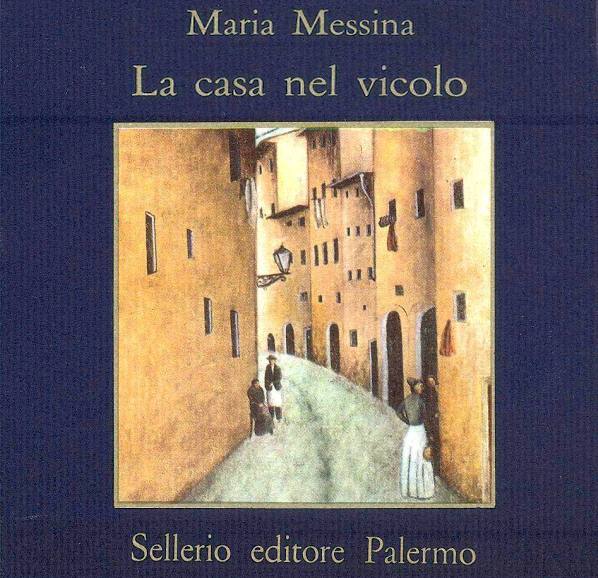Maria Messina.
La casa nel vicolo.
Capitolo 1
| Note Diritti d’Autore: no Edizione di riferimento: Maria Messina, La casa nel vicolo, Sellerio Editore, Palermo, 1982 |
Capitolo 1
Nicolina cuciva sul balcone, affrettandosi a dar gli ultimi punti nella smorta luce del crepuscolo. La vista che offriva l’alto balcone era chiusa, quasi soffocata, fra il vicoletto, che a quell’ora pareva fondo e cupo come un pozzo vuoto, e la gran distesa di tetti rossicci e borraccini su cui gravava un cielo basso e scolorato. Nicolina cuciva in fretta, senza alzare gli occhi: sentiva, come se la respirasse con l’aria, la monotonia del limitato paesaggio. Senza volerlo, indugiava a pensare alla casa di Sant’Agata; rivedeva il balconcino di ferro arrugginito, spalancato sui campi, davanti al cielo libero che pareva mescolare le sue nubi col mare, lontano lontano.
Era quella, per Nicolina, l’ora più riposata, benché la più malinconica, della giornata. Tutte le faccende erano sbrigate. Nella casa, come nell’aria, come dentro l’anima, si faceva una sosta, un accorato silenzio. Allora pareva che i pensieri, i rimpianti, le speranze, si facessero innanzi circonfusi della stessa luce incerta che rischiarava il cielo. E nessuno interrompeva i vaghi, incompiuti soliloqui.
Antonietta era in camera, presso il lettino di Alessio che da sei giorni aveva la febbre. Il cognato, al solito, restava seduto presso la tavola, che Nicolina aveva sparecchiata. Nella stanza mezzo buia si scorgeva, simile a un piccolo punto rosso, il fuoco della lunga pipa. Dopo aver cenato, e cenavano mentre era ancora giorno per non andare a letto col cibo sullo stomaco, egli fumava per un’ora giusta (il pendolo oscillava nel mezzo della parete), tenendo gli occhi socchiusi, placidamente.
Annottava, e l’ultima luce era fuggita; Nicolina ripose il lavoro nel cestino, alzandosi un po’ a malincuore. Doveva preparare il bicchiere d’acqua che il cognato sorseggiava lentamente, due ore dopo aver cenato. Antonietta, che aveva la testa al malatino, non se ne sarebbe occupata.
Strizzò poco meno di mezzo limone nell’acqua, badando che col succo non cadesse qualche seme; aggiunse tanto vino quanto bastava a tinger l’acqua; vi sciolse un cucchiaino scarso di zucchero; agitò, rimestò, lasciò riposare. Poi guardò il bicchiere contro il lume, per accertarsi che la bibita fosse perfettamente limpida, come sapeva prepararla Antonietta. E finalmente portò il bicchiere, su un piatto, cautamente.
Tornò a riaffacciarsi. Ma il cognato chiamò subito.
— Vuoi ammalarti anche tu? C’è umido, fuori.
Nicolina avrebbe voluto spiegare che l’aria le pareva insolitamente tiepida. Ma rientrò senza replicare.
— Chiudi.
Socchiuse il balcone, sospirando.
— Chiudi bene.
Chiuse anche gli scuri, senza fare rumore. Si ricordava di suo padre che non voleva serrassero le finestre; diceva: «Il viandante stanco, che entra di notte in paese si solleva se vede un po’ di luce nelle case…».
Sedette presso la tavola e riprese a lavorare, cercando di non dar noia al cognato con la mano, nel tirar la gugliata. Carmelina, trascinati i balocchi presso la zia, cominciò a cullare una pupattolina fatta con due cenci e un fil di spago, canticchiando: «Dormi… Dormi…». Ma si interruppe subito, e tacque, guardando il padre un po’ spaurita.
Poi venne Antonietta, pallida e preoccupata, e sedette anche lei.
— Hai fatto bene, – disse all’orecchio della sorella –, a pensare per la limonata.
— Tu non venivi…
— C’eri tu. Stavo tranquilla.
Sempre sotto voce aggiunse, accarezzando la bambina:
— È ora che vada a letto, non ti pare? Io debbo tornare di là.
— Finisco la cucitura e vado subito.
Tacquero. Di solito stavano sempre zitte mentre lavoravano e don Lucio era in casa, per non dargli noia.
Antonietta, che mostrava una penosa inquietudine in tutta la persona, ruppe due volte il pesante silenzio con due sospiri profondi. Tutte e due le volte Nicolina levò gli occhi dal lavoro e la guardò con espressione angustiata.
Don Lucio assaporava la sua fumata con sodisfazione quasi voluttuosa. Tenendo gli occhi socchiusi, seguiva ogni piccolo movimento delle due sorelle. L’una e l’altra avevano nell’espressione, nella maniera di muoversi, di guardare, lo stesso impaccio, la stessa goffaggine che nascevano dal continuo misterioso timore di recargli fastidio. Egli provava una compiacenza sempre nuova ogni qual volta si avvedeva come fosse profonda la soggezione che ispirava alle due donne, specie a Nicolina che, sul principio, aveva mostrato di avere una vivacità quasi irruente e sgradevole.
Nicolina si alzò, e Carmelina la seguì dopo aver baciato in fretta la mano dura e fredda che il padre allungava ogni sera, senza smettere di fumare.
— Prendi le mie carte e gli occhiali.
Antonietta portò sulla tavola la cartella gonfia di registri, e la cassetta con le penne e il calamaio, che stavano disposte in bell’ordine su una piccola scansia presso il balcone. Don Lucio guardava compiaciuto la moglie che andò e tornò due volte. Ammirando le molli movenze dei fianchi forti e pieni della sua donna, era contento di se stesso, così come era contento ogni volta che si soffermava a contemplare i mobili costosi de’ quali aveva abbellito la casa.
Nicolina, tornando, disse:
— Sono stata a vedere Alessio. Si lagna nel sonno.
Antonietta guardò supplichevolmente il marito. Andò e tornò subito in punta di piedi.
— Lucio! – chiamò timidamente, restando sull’uscio, con la voce piena di lacrime. – Credo che stia peggio!
Egli finse di adirarsi:
— Ci avete gusto a tormentarmi? – gridò. – Ad avvelenarmi i pochi minuti di riposo, dopo una giornata di fatica?
Antonietta tornò in camera, umiliata e dolente. Non le credeva mai, quando gli comunicava le sue paure!
— La colpa è mia, – confessò alla sorella, – mi manca il garbo, nel dire le cose…
— Vuoi che gli parli io?
— No, è inutile. Stasera è in collera. Vattene, Nicolina. Pare che si confabuli, qui tra noi. Non è giusto.
Ma quella sera, l’umore di don Lucio era disposto alla pace. Aveva mangiato di buon appetito, digeriva senza fatica, era sodisfatto. Solo gli dava un po’ di noia, sentir piangere la moglie, di là…
Si alzò finalmente ed entrò in camera, mentre Nicolina, ch’era tornata al lavoro, impallidiva, spaurita.
La moglie, seduta accanto al lettino, in penombra, nell’abbandono doloroso di tutta la persona, pareva quasi bella. Don Lucio desiderò di abbracciarla. Già gli pareva di sentire tra le braccia secche il tiepido molle corpo della moglie che si abbandonasse docilmente alla sua stretta.
In quel momento essa non pensava affatto a essere docile. Tutta l’anima sua era presa dal figlio malato.
Don Lucio guardò il lettino con una specie di ripugnanza. Quel ragazzo, da quando era nato, non aveva procurato che fastidi a lui e preoccupazioni alle donne.
— Stupidetta! – esclamò con insolita mitezza nella voce. – Ti pare che tuo figlio stia per morire?
Antonietta trasalì, udendo la voce del marito. Ma, poi che lo vide sorridere, osò spiegare:
— Rigetta anche l’acqua… E poi… senti come scotta…
— Si vede che ti manca l’esperienza! – replicò don Lucio senza guardare il piccolo malato. – Se ci fosse qui tua madre ti direbbe che sei una stupida. I ragazzi sono come le giornate di primavera…
Antonietta si rinfrancò un poco. La sola presenza del marito, mentre la intimidiva fortemente, bastava a farle apparire piccole e infondate tutte le sue apprensioni.
Ma il conforto durò quanto la presenza di don Lucio. Rimasta di nuovo sola, nella camera in penombra, fu ripresa dalle paure. Il fanciullo pareva assopito; il fine visetto di lui, bianco come la cera, la spaventava. Lo fissava dolorosamente, come se avesse sperato di trasfondergli vitalità con lo sguardo.
— Alessio, anima mia… Alessiuccio… – chiamò, sommessamente, per vedergli riaprire gli occhi. Ma poi pensò che il riposo poteva fargli bene, e tornò a guardarlo in silenzio. Con tutta l’anima dentro lo sguardo fisso e spaventato, si scordava del marito, della figlia, dell’ora tarda. Se la casa fosse crollata intorno, avrebbe continuato a guardare il suo piccolo figlio malato senza muoversi. Nessuno si curava del piccolo che pareva assopito ma non riposava e soffriva. Ecco che poteva spegnersi così, nel silenzio grande, mentre il marito continuava a riempire di cifre i fogli di carta con le belle righe rosse e blu… Che avrebbe fatto, che avrebbe detto, se lo avesse chiamato gridando: «Lucio! Alessiuccio è morto…»?
Gli voleva veramente bene, lui, ad Alessio? Certo, gli doveva voler bene, perché era il primo figlio, il maschio… Certo… Ma bastava l’ombra del dubbio, che le passava attraverso la mente come il volo d’un pipistrello nella notte, per raddoppiare il suo amore di mamma.
In verità, da quando era nato, Alessio non aveva dato che trepidazioni… Gracile, diafano, tranquillo, pareva che camminasse sulla terra guardato dalla morte…
Chi aveva detto queste buie parole, che proprio ora, mentre era così malato, le tornavano nelle orecchie? Certo le avevano dette per il suo Alessiuccio… Essa gli aveva dato la vita più di una volta, con lo stesso dolore. Dio mio! Dio mio! gemette, saprò farlo diventare ben presto forte e allegro e rumoroso come gli altri ragazzi?
Il marito tornava, con una candela in mano.
— Non ti sei ancora coricata? – esclamò.
— Eccomi – rispose Antonietta. Subito pregò: – Non mandargli tutta la luce sugli occhi…
Si spogliò e si coricò, per obbedienza. Ma cercò di non addormentarsi. A mezzanotte scese di letto per fare bere Alessio; altre due volte per guardare il termometro.
— Mamma! – si lamentava il malato vedendola. – Non è ancora giorno?
Scendeva cautamente, camminava a piedi nudi, per non svegliare il marito. Don Lucio si svegliò lo stesso e la mattina disse:
— Finché non si rimette – e accennò con la mano al lettino –, io dormirò di là. Non posso perdere così le nottate.
Antonietta abbassò gli occhi, mortificata. Lui aveva ragione. Un uomo che deve far lavorare la testa ha bisogno di riguardi e non può sacrificare il sonno come una femminetta.
Tuttavia non seppe trattenere le lacrime, quando don Lucio uscì dalla camera per andare a prendere il caffè. Sentì un gran freddo, quasi fosse rimasta per sempre sola e abbandonata nella camera mezzo buia dall’aria satura del tristo afrore della febbre.
Nicolina chiamava. Lasciò il lettino del malato per non far maggiormente seccare il marito facendosi attendere.
La fanciulla s’era alzata prestissimo e, preparato il caffè, aveva spazzato e rassettato la grande stanza che, forse perché aveva il parato scuro e perché dava nel vicolo, restava senza luce fino a tardi. Le robe del cognato, di già tutte spazzolate e piegate, erano pronte sul divano, e le scarpe, ben lucidate, erano posate sullo sgabello perché lui non dovesse chinarsi nel prenderle. Dalla cucina giungeva una forte e piacevole fragranza di caffè fresco.
Antonietta ingollò il caffè e mentre la sorella passava in fretta con un candido asciugamani sulle braccia, le raccomandò:
— Torno da Alessio, Nicoli’… Provvedi tu alla colazione.
Nicolina non rispose. Sapendo che la sorella non poteva aver la testa alle faccende di casa, aveva di già provveduto, fin dalla sera innanzi. In cucina don Lucio si lavava, strofinandosi col sapone odoroso le braccia secche e vellose e le gote sbarbate, e poi sciacquandosi abbondantemente. Nicolina aspettò umilmente che finisse, per dargli l’asciugamani, vincendo la sgradevole impressione che le ispirava la vista di quelle braccia nude di uomo. Poi gli portò lo spazzolino dei denti. Infine si rammentò che Antonietta lo pettinava.
Don Lucio sedette davanti al balcone chiuso, con un asciugamani asciutto intorno al collo.
— Vediamo se sei brava.
Nicolina spruzzò l’acqua Migone nei pochi ciuffi di capelli, stropicciò lievemente con una spugnetta finché la cute diventò rosea. Poi prese il pettine.
— Va bene così?
— Va bene.
— Vi faccio male?
— No. Continua.
Nicolina sapeva fare. Sempre aveva osservato e imparato ogni più piccolo movimento della sorella mentre pettinava il marito, due volte al giorno. Si studiava di pettinare anche lei adagio adagio, senza impazienze, animata dal timore di lasciare scontento il cognato che affidava il calvo roseo cranio alle sue mani inesperte.
— Va bene così?
— Va bene.
— Vi faccio male?
Don Lucio gustava il primo piacere della giornata. Il massaggio lento e uguale gli faceva bene; colle spalle comodamente appoggiate alla bassa spalliera, gli occhi socchiusi, si abbandonava tutto alla piccola voluttuosa sensazione.
— Basta – ordinò a un certo punto.
Nicolina ripose i pettini e la boccetta con l’acqua, e corse a lavarsi. Poi volò nelle stanze di sopra: Carmelina si era svegliata: la vestì, le ravviò i capelli; rassettò le due stanze con tutta quella vivacità di movimenti che le era naturale e che riusciva tanto sgradita a don Lucio. Tornò giù e, preparando la colazione, ritrovò tutta la posatezza necessaria che aveva imparato ad avere nel servire il cognato.
Stese la tovaglia; imburrò il pane bianco (si faceva a parte col fiore di Maiorca per lui solo) e versò il latte, non troppo caldo e non freddo. Mentre egli mangiava – un dottore gli aveva consigliato di masticare il boccone trenta volte lentamente, – Nicolina non tralasciava di servirlo. Andava e tornava dalla cucina (sul fuoco c’erano altre fette di pane in caldo), si trovava pronta a imburrare, ad aggiungere latte o zucchero, senza vincere la pungente paura di non accontentare il cognato. Intenta a servirlo, non si curava di sbrigare le molte faccende che l’aspettavano, o a preparare la colazione per sé e per Antonietta. Del resto loro donne si adattavano facilmente con un po’ di pane e un pezzo di ricotta mangiato in piedi. Spiava in faccia il cognato, desiderosa di sentirsi approvare. Ma don Lucio era nero come mezzanotte. Andò in camera, a passi lenti, trascinando le pantofole.
Antonietta lo guardò tra le lacrime.
— Lucio! – esclamò dolcemente. – Che te ne pare?
Don Lucio sbirciò il malato che lo fissava con occhi ardenti e dilatati.
— È raffreddato – disse seccato. – Non vedi che gli lacrimano gli occhi? Fagli fare una buona sudata.
E si allontanò per vestirsi. Non poteva soffrire scene di malati che si lagnano, di donne che piangono… Che pretendevano da lui? Perché lo tormentavano, inseguendolo con sguardi così contristati che parevano pieni di rimproveri? Non la teneva in pugno lui, la salute di quel ragazzo! Aveva fatto una buona colazione e gliela volevano guastare. Ecco tutto.
Ebbene, la vita di un ragazzo non poteva certo essere utile quanto la vita di un uomo adulto che «lavora e produce». Quanto la sua, infine. Aveva il cuore malato, lui. Gli erano state vietate le emozioni. E loro si accanivano ad amareggiargli la vita con le piccole angustie, gli sciocchi timori, con che le donne s’infrascano la testa. Ebbene, se lui fosse morto, loro avrebbero finito di mangiar pane!
Ma questi pensieri erano incresciosi, e inopportuni, quanto la vista del figlio malato.
Non bisognava pensare a «quel fatto». Si palpò le gambe, le braccia, si guardò a lungo nello specchio, donde la sua immagine sembrò emergere come da un’acqua verdastra. Viveva, respirava, vedeva. Respirò profondamente. Specchiandosi, scoprì due nuovi capelli bianchi; li strappò e li buttò via con ribrezzo. Non era più tanto giovane. Forse la dissoluzione del suo corpo cominciava di già, mentre un’altra creatura nata da lui doveva sopravvivergli. Ogni giorno che passava, ed era un passo che lui faceva verso la morte e che l’altro faceva verso l’avvenire. Andavano contro due mete opposte. Era così. La Natura è così.
Vestendosi per uscire, il suo sguardo si posò sul lettino, involontariamente. Subito voltò gli occhi.
Sì, l’altro sarebbe certamente guarito. Aveva tutta una vita davanti a sé, una vita fresca e nuova…
Antonietta guardava il marito, mortificata. Lo vedeva sempre più scorrucciato.
Aveva ragione. Lo trascurava da molti giorni e forse Nicolina non riusciva a contentarlo. Per farsi perdonare, gli spazzolò con cura la giacca, lo accompagnò fin sulla saletta dove Nicolina aspettava tenendo la spolverina chiara con le due braccia alzate. Don Lucio l’infilò senza parlare. Sulla porta si voltò, lungo lungo, e disse con tono aspro, senza rivolgersi ad alcuna delle due:
— Ricordati di farmi trovare il mio letto nel salottino.
Come furono sole, le due sorelle provarono una specie di sollievo, senza confessarlo. Parve che nella casa, nella vasta casa in poca luce, si respirasse più liberamente. Nicolina domandò:
— Come sta?
— Male, Nicolinedda mia. Ho paura. Ciò che mi fa più paura è il non sapere che abbia.
E siccome Nicolina domandava ancora con gli occhi, aggiunse:
— Non vuol credere che sia tanto malato. Gli uomini son tutti così… Gli pare che io esageri…
— Pure papà, buon’anima, ti ricordi… Quando Alfonso ebbe la meningite…
— Papà era una mosca bianca. Gli uomini son tutti come lui. Lo so io che ho più esperienza di te, Nicolinedda.
Nicolina sospirò profondamente. Certo, doveva essere proprio così.
Andò a vedere il nipotino. Ma davanti a quello sguardo grave e intelligente di fanciullo malato che domanda aiuto, si agitò tutta, presa da un senso di sgomento e di oppressione. Sentì anche lei che la solitudine più disperata le circondava nella casa. Non conoscevano alcuno che potesse essere chiamato per conforto o per consiglio: alla loro porta non picchiava se non gente ignota, gente che domandava di don Lucio con tono umile, squadrando le donne ostilmente.
Lasciò la camera, per liberarsi dal senso di angoscia e di solitudine, e cominciò a sistemare un lettino di ferro nel piccolo salotto, mentre Carmelina le girellava attorno rallegrata dalla novità.
Bisognava che don Lucio non si sentisse come accampato; e perciò trascinò nel salottino – dopo aver levato il tappeto orientale e l’orologio di bronzo sotto la fragile campana di vetro – tutte le piccole comodità di cui egli amava circondarsi. Ecco la vaschetta di cristallo che conteneva il sapone profumato, la spugna, lo spazzolino. Ecco la graziosa spera oblunga. E la misteriosa cassetta di ebano che teneva, sempre chiusa a chiave, sul cassettone. La cassetta color cuoio, coi pettini. La scatolina con la limetta d’acciaio e le forbicine ricurve. E finalmente l’astuccio con l’occorrente per farsi fare la barba in casa ogni tre giorni… Nicolina aveva una specie di culto per tutti i piccoli oggetti che andava collocando sui mobili del salotto. Cose che parevano inutili, o almeno superflue… Suo padre, buon’anima, era tanto semplice! E anche i fratelli delle sue amiche d’un tempo lontano… Tutti erano così diversi da lui!
Chiudendo le imposte per impedire che entrasse il sole nel salottino trasformato, pensò che lei, una povera ragazza fatta per la fatica, non avrebbe mai osato dormire in una camera così ricca e bella.
Certo certo… pensò convinta, lui è diverso da tutti gli altri. E si pentì di non aver saputo dimostrare abbastanza fiducia in lui, restando sola con Antonietta. Se non si allarmava era proprio segno che Alessio non doveva essere in pericolo. Sapeva quel che si faceva; era sicuro di sé e conosceva la vita come uno che legge dentro un libro aperto. Bisognava affidarsi a lui, con animo tranquillo.
E tornò a provare il vivo senso di gratitudine e di ammirazione che pareva colmasse la distanza che separava la sua povera anima dal cognato.
Avrebbe potuto sposare una ricca e istruita signorina della città e invece si era degnato di guardare la piccola Antonietta, la quale non gli aveva portato altra dote che il corredo, non altri gioielli che le sue virtù di donna di casa…
Ebbene, ripeté dentro di sé, indugiando come estatica in mezzo alla camera in penombra, Antonietta è stata fortunata.
Passate quelle piccole contrarietà, sua sorella avrebbe di nuovo goduto la gioia di appartenere a un uomo che sapeva guidarla, di avere una casa proprio sua, dei bambini proprio suoi…
Sì, essa era stata fortunata. Non le mancava quasi nulla, per essere felice.
La storia del matrimonio di Antonietta era molto semplice.
Don Lucio Carmine, da alcuni anni, era amministratore o meglio factotum del barone Rossi. Ogni primavera andava a Sant’Agata, dove il barone possedeva terre e case, per riscuotere, ed era ospitato dal segretario comunale, don Pasquale Restivo.
La buon’anima di don Pasquale gli serbava una riconoscenza così profonda che per lui si sarebbe fatto tagliare le mani.
Si trattava di questo: il segretario si era messo in mente di darsi al commercio, per far la dote alle figlie, e aveva cominciato a fabbricare. Ma fece come uno che se ne va in alto mare, dentro una fragile barchetta… presto consumò l’esiguo capitale.
Mentre era come si suol dire nelle peste, la moglie gli portò davanti il nome di don Lucio Carmine.
— Non è ricco, ma comanda il foglio da cento. Lo stesso fatto che è uomo di fiducia del barone dà la certezza che non farà sapere i fatti nostri alla gente. Dicono che abbia prestato denari al farmacista quando si rovinò col gioco…
Forse l’ispirava un angelo, povera donna, forse uno spiritello maligno. Ma chi, mentre è stretto dalla necessità, distingue ciò che è bene da ciò che è male?
Don Pasquale andò a cercare don Lucio fino in città; firmò delle cambiali; garantì il suo nome mettendo innanzi la casetta e una piccola terra che gli dava grano per l’annata. Don Lucio tornò apposta a Sant’Agata, con un amico perito che stimò la casa e la terra; e sborsò il denaro.
Una provvidenza, in quel momento!
Il tempo passò rapidamente. Don Pasquale, che non era nato per fare l’appaltatore, continuò a rovinarsi dietro una fabbrica che pareva maledetta dal Signore. E una sera, mentre meno se l’aspettava, ricevette un biglietto da visita del signor «Lucio Maria Carmine, segretario del barone Rossi, ecc., Presidente del Circolo dei Commercianti, ecc. ecc., Socio della Lega per l’Infanzia abbandonata, ecc. ecc.».
Era in paese e faceva «osservare» che le cambiali scadevano.
Don Pasquale corse come un disperato all’alberguccio dove alloggiava don Lucio. Questi l’accolse con l’abituale freddezza.
— Vedremo… – si limitava a rispondere senza alzare gli occhi (allora non portava gli occhiali), da certe sue cartacce sparpagliate sul letto. – Vedremo… Ma io mi trovo allo scoperto. Io ho fatto dei sacrifici per lei.
— Ha ragione! – gemeva il segretario. – Ha tutte le ragioni. Ma pensi alla condizione di un povero padre di famiglia! Lei è giovane e non sa che significhi! Ne va del buon nome dei Restivo. Che vergogna! E dove me la metterò la faccia, se ci levano la casa? Non abbiamo fatto a tempo. Ma ora pagheremo. Lei ha ragione. Ma non perderà niente. Ha da fare con un galantuomo. Io, finora, gli interessi li ho pagati…
— E chi le parla di interessi? O che mi prende per uno che faccia quel bel mestiere? – interruppe don Lucio alzando la voce e il mento. – Bel profitto a far del bene alla gente!
— Non volevo offenderla! – spiegò il segretario sospirando penosamente. – Non le faccio proposte contro la giustizia!
— Vedremo… – ripeté don Lucio che, così lungo lungo e accigliato com’era, con un ciuffo di capelli mezzo grigi su una tempia, mostrava più anni di quanti ne avesse realmente. – Io il cuore non l’ho cattivo. Non faccio male a una mosca, io, e la mia coscienza è netta come quella di un bambino di latte. Ma capirà! Ho aspettato fin troppo e ora mi trovo allo scoperto…
Si compiaceva a sentirsi pregare e scongiurare da un uomo già vecchio, che in paese era rispettato da ognuno, e ora stava in piedi davanti a lui, a capo scoperto, con le tremule mani tese avanti come a parare un pericolo.
— Vedremo… – Non diceva altro, fingendo di continuare a cercar fra le carte, con aria infastidita. Finalmente aggiunse:
— Le farò avere una risposta.
Il segretario se n’andò col cuore morto.
Ogni sera tornando a casa, domandava:
— È venuto? Ha scritto?
— Non è venuto. Non ha scritto… – rispondeva la moglie. – Ma non ti allarmare. Tra amici e parenti…
— Sì! Amici e parenti! – esclamava il segretario sconsolatamente. – Mettere i fatti miei «coram populo!». Non lo sai che il povero e il malato è scacciato dal parentato!
— Resterebbe mastro don Biasi…
— Mastro don Biasi?! Cacciarmi tra le grinfie di uno strozzino! Quello sì che si mangia tutto!
Così per una settimana intera intera. Una settimana che pareva quella della passione. Anche i ragazzi pensavano alle cambiali, e le nominavano sotto voce, quando il padre non c’era.
Finalmente don Lucio Carmine si fece vivo: rinnovava le cambiali, a lunga scadenza, e prendeva per sé la fabbrica avviata – quella fabbrica che aveva ingoiato tutti i capitali, come la bocca di un pozzo. Bisognava contentarsi. Quel che era fatto era fatto. Ora non si trattava che di pagare, senza pensare mai più a speculazioni sbagliate.
Don Pasquale Restivo tornò dalla morte alla vita. Ciò che lo consolava maggiormente era che, in mezzo a tanto rovinìo, la terra non si fosse toccata.
— Ma c’è la minaccia… – fece la moglie. – La terra è lì, a garantire. E se…
Il segretario si aggrottò. Ma si rianimò subito. Sciocchezze. Il debito, a costo di mangiare pane asciutto, l’avrebbero pagato.
— Un altr’anno – concluse – lo inviteremo a pranzo. È un galantuomo.
Parlava di lui con rispetto, quasi fosse stato il deputato del paese.
— Un galantuomo! Un altro, al suo posto, mi avrebbe rovinato. Certo… con le dita schiacciate ci resto un pochino… Ma non importa. La terra e la casa sono nostre. E non me le lascio scappare.
I figli, una nidiata, lo stavano a sentire a bocca aperta. Loro avevano quasi paura di quell’uomo lungo e accigliato che poteva fare il sole e il maltempo, come il Padreterno.
Allora Caterina, la più grande, poteva avere vent’anni; Antonietta, Nicolina e i fratelli venivano tutti dopo di lei.
L’anno appresso don Lucio fu invitato a pranzo, per tutti i giorni che si fermava a Sant’Agata.
E questa dell’invito a pranzo, diventò un’abitudine. Come sapevano l’arrivo di don Lucio Carmine, donn’Amalia e le figlie si davan da fare quasi fosse Pasqua. Facevano grandi pulizie per tutta la casa, lavando persino i vetri delle finestre, persino le maniglie di rame delle porte, e mettevan fuori dalla «corriola» la tovaglia di lino con la cifra rossa e bianca, per ricevere degnamente l’ospite che giungeva dalla città. La sua venuta, per via del pranzo più abbondante del solito e per tante piccole novità, rallegrò sempre i figli del segretario.
Solo chi restava vinta da un’indefinibile senso di paura, era Antonietta. Quel giovanotto che pareva invecchiare anzi tempo, che a tavola masticava così adagio ch’era una angustia tenergli dietro, che parlava poco e non rideva mai, le ispirava una soggezione tanto forte che le toglieva il respiro, proprio come se l’aria venisse improvvisamente a mancare nella piccola stanza da pranzo piena di luce. Col tempo la paura diventò quasi piacevole, quasi attraente. Senza sapere perché aspettò le visite di don Lucio con una certa impazienza. Forse le aspettava come l’unica novità che venisse a interrompere l’uniformità della sua vita casalinga.
Egli giungeva regolarmente ogni primavera, in compagnia dell’amico perito che aveva stimato la roba dei Restivo; non veniva solo per conto del barone, ma anche per badare a interessi proprio suoi e veder la fabbrica che progrediva a vista d’occhio e che lui, una volta finita, aveva intenzione di rivendere.
Lavorando nell’orticello, dietro la muriccia che d’estate odorava di sole, Antonietta pensava a don Lucio e cercava di figurarsi la casa dove abitava solo solo… Ma subito rideva di se stessa, dentro di sé, perché le pareva una cosa stupida svariare la mente dietro una persona che forse non pensava neppure di averla veduta. Il chiuso e taciturno ospite di ogni anno, non l’aveva mai guardata in faccia, né le aveva mai rivolto la parola direttamente. Non era, per lui, che una delle figlie del suo debitore… Forse era già fidanzato con una ricca e superba signorina della città.
La piccola Antonietta si ingannava. Don Lucio, nelle sue brevi lontane visite, l’aveva studiata e osservata. Da tre anni accettava gli inviti a pranzo per non guastarsi lo stomaco coi mangiari intrugliati della locanda, e per conoscere a fondo la seconda figlia del segretario. Nicolina era troppo giovane. Caterina mostrava un carattere chiuso e superbo; e i suoi modi un poco bruschi e la maniera di guardare, facevan temere che fosse troppo sicura di sé e aspettasse il momento di spadroneggiare.
Antonietta gli piaceva. Non era bella, ma neppure brutta. Aveva un paio d’occhi castani pieni di mitezza. La veste scura modellava un corpo di già sviluppato e ben fatto. Le mani ruvide e grandi, i polsi forti, sapevano le umili necessarie fatiche della casa. Gli piaceva. Gli sembrava la vera immagine della donna. Lui, che si rammentava in confuso delle sue sorelle, non poteva soffrire le ragazze della città che civettano e frequentano le scuole maschili. Da molto tempo pensava di prender moglie: ora aveva anche trovato una ragazza come ci voleva per lui. Ma doveva abituarsi all’idea di dover vivere con Antonietta, e soprattutto, accertarsi che il carattere di lei fosse veramente docile mansueto, fatto per essere plasmato come l’argilla fresca.
Un’altra cosa era necessaria: aspettare che don Pasquale Restivo avesse finito di pagarlo (in poco tempo gli interessi avevano superato il capitale); perché gli affari e il sentimento non camminano bene assieme.
Quando gli parve l’ora si decise. E per non affaticarsi con un viaggio straordinario aspettò di andare a Sant’Agata per conto del barone. Del resto non era affatto impaziente di portare Antonietta nella vasta casa che abitava solo, e dove di tanto in tanto conduceva una sua umile devota amante.
Era il quinto anno che il segretario l’ospitava, con immutata cordialità.
Egli parlò della fanciulla con gravità, scotendo ogni tanto, meccanicamente, per il suo innato amore della pulizia e dell’ordine, il miglio che i canarini dalla gabbia gli spruzzavano sulle ginocchia. Il segretario restò incantato dalla delicata onestà di quel giovane che aveva frequentato la sua casa – con un sentimento ben delineato – senza turbare la pace di Antonietta o approfittarsi della sua condizione di creditore…
Antonietta fu chiamata lì per lì. Era nell’orto; sgranava un cesto di baccelli e cantava accompagnata da Nicolina. Le voci fresche e gaie delle due sorelle giungevano nella stanza da pranzo.
Sulla scala la madre le mormorò, prendendole una mano:
— Figlia mia, don Lucio Carmine è venuto a domandarti in isposa.
Antonietta si sbiancò. Volle fuggire smarrita. La madre la trascinò dolcemente nella stanza da pranzo. Don Lucio voltava le spalle all’uscio, oscurando, con la lunga persona, tutta la vetrata; il segretario gli additava certi orti, lontano, che in antico erano appartenuti alla famiglia Restivo. Si voltarono. Antonietta restava in mezzo all’uscio, con la faccia più bianca della cera; si guardava attorno, come se cercasse aiuto nello smarrimento che la soffocava.
— Mi sembri una piccola stupida… – fece la madre sorridendo. – Che penserà di te il signore don Lucio?
Tutti erano imbarazzati. Allora don Lucio disse:
— Voglio che la risposta di donna Antonietta sia ben ponderata.
E uscì. Anche questo era un atto da galantuomo.
Ma Antonietta si turbò ancora più profondamente, come se l’avessero abbandonata su una strada deserta. Se l’ospite l’avesse appena guardata negli occhi, se le avesse detto una parola buona, il suo cuore si sarebbe aperto alla gioia e all’amore come un fiore che sboccia toccato dal sole.
Che era mai quella pena grande che l’opprimeva così? Cominciò a piangere sommessamente, col grembiule sulla faccia. Il canarino continuava a saltellare nella gabbia e qualche seme di miglio restava intricato fra i lucidi neri capelli.
— È giusto che sfoghi – disse il segretario. – Le ragazze fanno tutte così. Ti ricordi, Amalia?…
E donn’Amalia e don Pasquale crollarono la testa, sorridendosi dolcemente, come due fanciulloni, ricordandosi dei giorni lontani, pieni della felicità di esser giovani e di volersi bene. Bei giorni! Anche donn’Amalia piangeva, allora, e gli altri sorridevano. E poi s’erano fatto il ritratto (quello che pendeva, ingiallito, nel salottino); lei seduta, lui in piedi, con una mano posata sulla spalliera della poltrona, rigidi impettiti per venir somiglianti, mentre il cuore picchiava come un tamburo… Bei giorni! Tutto era svanito piano piano, come il sole d’estate che, nel tramontare, s’indugia in mezzo al mare.
E la dolce storia passata, credevano di riviverla nei figli.
Nicolina che saliva, trovò Antonietta con gli occhi rossi. Si sbiancò anche lei, perché amava molto la sorella.
— Non è nulla – spiegò la madre, con la voce che le tremava un poco. – Don Lucio Carmine è venuto a domandarla in isposa.
Anche Nicolina non domandò se Antonietta accettava. Si mise a ridere, rallegrata, e ripeté con cantilena, come se raccontasse la vecchia favola, a un bambino…
— È venuto Barbablù! Mi date la più gentile delle vostre sorelle?
— Ma taci! – esclamò Caterina, che non aveva aperto bocca. – Scherzi sempre fuori di proposito. Ebbene, che c’è da ridere, adesso? Aiutami ad apparecchiare.
Caterina provava gran dolore che sua sorella sposasse. Non era abbastanza bella e piacevole la vita, mentre restavano tutti uniti, tutti assieme, come i chicchi d’uno stesso grappolo?
Ora una di loro doveva andarsene via dalla casa tranquilla, per seguire un uomo straniero. Avrebbe voluto domandare: «Ti piace? Lo sposerai?…».
Ma non parlò. Non doveva mettersi, con la sua parola, tra lei e la sorte.
Forse per la medesima ragione, ognuno evitò di parlare della «cosa nuova».
E quella mattinata trascorse come le altre, in mezzo alle faccende accresciute per il pranzo all’ospite.
E la sera, a pranzo, don Lucio Carmine offrì ad Antonietta, senza domandarle la risposta ponderata, un anello che parve straordinariamente ricco e bello. E dopo la sua partenza, le cose tornarono come prima.
Grandi novità furono il corredo della promessa sposa; le visite delle amiche che venivano a rallegrarsi e a curiosare. Tutte invidiarono la fanciulla; moltissime si presero il velenoso piacere di mormorare che quello era un matrimonio voluto, ché il segretario affidava la figlia a un forestiero, senza informarsi chi fosse, in patto di gratitudine, per l’affare di certe cambiali…
Per un pezzo non parlarono d’altro, poi non ne parlarono più, come succede di tutte le cose nuove che fanno impressione.
Antonietta non vinse la soggezione che le ispirava il fidanzato. Egli venne altre due o tre volte, durante l’annata, per «familiarizzarsi» e dar consigli a proposito del corredo, badando che non facessero spese inutili, spese pazze. Antonietta non si «familiarizzò» mai. Si persuase sempre più di essere una povera creatura che non avrebbe mai pigliato confidenza con quell’uomo saggio e taciturno e non si sarebbe mai resa amabile. «Perché scegliere proprio me?» si domandava sgomentata. E le pareva di trascinare un peso insopportabile.
La vigilia delle nozze osò domandare al fidanzato un grosso favore, «una grazia» disse lei.
Voleva condurre Nicolina, per non esser sola, nella casa nuova, almeno nei primi giorni.
— È ancora una bambina, si può dire. Non darà fastidio.
Certo, che fastidio doveva dare? Don Lucio s’era abituato a veder Nicolina a fianco di Antonietta, gaio immancabile testimonio dei loro brevi colloqui di fidanzati, e acconsentì subito.
Così Nicolina rassettò le proprie robe nella cassetta (una di quelle piccole casse tinte verdi che giungono da Palermo piene di dolci): ebbe la sua sacca da viaggio e la spolverina. Era felice di andare in una città e mostrava la sua felicità così vivacemente che pareva fosse lei la sposa.
— La sposa senza anello e senza sposo… – diceva ridendo alle amiche.
Quando scese le scale, preceduta dal facchino con la cassetta verde sulle spalle, fremeva, impaziente, come un uccello di primo volo. Lasciava la casa, la madre, senza l’ombra del rimpianto. La sua esuberante giovinezza era assetata di veder cose nuove. E poi, sapeva che sarebbe tornata presto.
Era deciso che doveva restare con la sorella non più di un mese o di un mese e mezzo. Ma Antonietta volle rimandare la partenza, e il marito la contentò.
Antonietta non poteva assuefarsi all’idea di restar sola, lasciando partire la giovane sorella. In presenza del marito essa non osava avere desideri, o speranze. Era una povera cosa senza volontà. Se il marito avesse avuto il capriccio di ordinarle: «Buttati dalla finestra!» lei si sarebbe buttata a capofitto, peggio d’una cieca. Le diceva: «Ho da fare», e lei camminava in punta di piedi, parlava a segni con Nicolina, o lasciava addirittura le stanze dalle quali poteva giungere al marito qualche rumore che lo disturbasse. La chiamava e accorreva subito. E se egli voleva, gli si abbandonava sul petto con dedizione assoluta e passiva.
Non era felice. C’era, nel suo cuore, un freddo che le vietava la gioia. Se qualche momento restava sola nelle stanze di sotto, grandi e silenziose, si sentiva inquieta sperduta e correva a cercar Nicolina. Pensava con terrore al giorno che Nicolina avrebbe dovuto lasciarla per sempre.
Sedevano tutte e due sul balcone che dava nel vicolo e lavoravano, chiacchierando come due buone amiche. Parlavano poco del presente, evitando di nominare don Lucio, e molto del passato. Dell’uniforme passato che ora si presentava alla memoria con bellezze non mai vedute, non mai sentite «prima». Ne parlavano come di un bene perduto per sempre. Pure non si lamentavano mai. La tristezza che aduggiava i loro giovani cuori non aveva una causa determinata. La respiravano nell’aria: ne era impregnata tutta la casa, la casa vasta e isolata dove ogni rumore risonava gravemente; saliva su dal vicolo fondo e scuro, dove talvolta si vedeva una povera sciagurata, la Rossa, accoccolata sullo scalino corroso della propria casupola. Il primo piano, con due grandi balconi di ferro sempre chiusi, pareva disabitato. Qualche volta si affacciava una donna pallida, vestita di nero; usciva fuori per annaffiare un geranio stento e ingiallito. Era una vedova ancora giovane, che viveva col padre paralitico.
Don Lucio aveva sentenziato:
— Case come questa, in città se ne trovano poche. Chiusa la porta, non abbiamo più niente da fare coi vicini.
Ebbero una confusa penosa impressione della città intraveduta appena. La città (piena di strade affollate nelle quali ci stringiamo a don Lucio per non sperderci, di gente che non conosceremo forse mai, che non farà mai un sorriso festoso…), la città rimase lontana, ignota, quasi paurosa.
Parlavano sempre della partenza di Nicolina che andava perdendo il bel colore della salute. Ma Antonietta non sapeva staccarsene.
Quando giunse il telegramma che annunciava la morte improvvisa del segretario, la partenza di Nicolina diventò affatto fuori di luogo. Don Lucio permise che andassero a visitare la madre. E al ritorno Nicolina seguì la sorella maritata, come cosa convenuta; e questa volta pianse amaramente perché sapeva di andare nella tetra casa del vicolo, non più per contentare la sposa ma per accettare la generosa ospitalità del cognato.
La casetta di Sant’Agata, rossa davanti due agili pioppi, chiuse le sue finestre. La vedova restrinse l’abitazione in due stanze; e mise fuori, sul portoncino, un cartello dove era scritto: «Si loca un piccolo appartamento con cucina». L’idea del «si loca» fu di don Lucio, abituato in città. Ma fu inutile, s’intende, perché tutti sapevano che la casa la davano a pigione. Alcuni mobili furono portati in soffitta, altri furono lasciati qua e là nelle stanze vuotate. La famiglia si sbandò, si divise. Uno zio di San Fratello prese con sé Alfonso. Il nonno paterno si occupò di Antonio…
Caterina disse:
— La partenza di Antonietta ci ha portato sfortuna. È così quando cade la prima pietra… Presto tutto il muro si sfascia e crolla.
Don Lucio assicurò che avrebbe pensato lui per l’avvenire dell’orfana, di Nicolina, e non si sarebbe dimenticato della vedova. In paese lo ammirarono, lo compatirono. Volere o no aveva fatto un cattivo matrimonio! Ecco che gli cascava sulle braccia una famiglia intera! Allorché uscì della casa, per partire, le due donne avanti, vestite di nero, che si voltavano a guardare singhiozzando il portoncino col «si loca», lui dietro, secco inferraiolato, molte persone si avvicinarono per stringergli la mano.
Le due sorelle, ritrovandosi nella casa del vicolo come dopo un sogno pauroso, si attaccarono più fortemente l’una all’altra. La riconoscenza per don Lucio fu senza limiti. Pensando alla famigliola povera e sparpagliata, comprendevano che significasse avere una casa ampia e comoda e la credenza piena e, soprattutto, potersi affidare a un uomo che provvede al presente e all’avvenire. Egli non era soltanto il marito di Antonietta, ma una specie di benefattore. Nel profondo avvilimento in cui le gettò la recente disgrazia, vollero ricompensarlo in qualche modo.
Nicolina pregò che fosse licenziata la serva, una vecchia che sbrigava le faccende grosse e faceva il bucato. Si vergognava a esser di peso al cognato. E siccome in quel tempo Antonietta era incinta per la prima volta, e aveva bisogno di certi riguardi, si addossò tutto il peso della casa.
Con la nascita di Alessio – un bambino minuto, malaticcio, che pareva impastato del dolore di quei mesi di lutto e della malinconia che spirava dalla casa, – Nicolina non ebbe più riposo.
— Nicolina, l’acqua calda!
— Nicolina, a momenti torna Lucio e la cena non è pronta! – chiamava Antonietta.
E don Lucio ordinava:
— Antonietta, di’ a Nicolina che mi prepari la pipa. Di’ a Nicolina che mi porti le scarpe pulite.
E Nicolina, pronta, pareva farsi in due, in quattro, per sbrigare tutto, per contentare tutti. Era magrissima, ma forte. Pareva fatta di acciaio fine. Tante volte, Antonietta, se allattava il bambino o lo sfasciava, pregava:
— Corri a vedere se Lucio ha bisogno di me!
Da prima don Lucio si infastidiva di aver continuamente la cognata tra i piedi, e borbottava contro il marmocchio che gli rubava le cure della moglie. I giovani occhi sfavillanti, le movenze vivaci di lei, non gli ispiravano fiducia.
Poi, a poco a poco, si abituò, ché la fanciulla si trasformava in sua presenza e nel servirlo diventava grave e silenziosa come Antonietta.
Col tempo, facendosi i conti, don Lucio si compiacque di aver fatto il generoso: Nicolina valeva più d’una serva, ché alla serva doveva passare un salario e Nicolina costava solo un po’ di mangiare e qualche veste…
Per fortuna, vesti e scarpe ce ne volevano pochissime, tanto per lei quanto per Antonietta. Erano uscite tre o quattro volte appena. Con la morte del padre si tapparono dentro per necessità. Il lutto, che si porta per anni e anni, è una cosa economica… Poi le cure del bambino di latte… Infine Antonietta ricominciò a soffrire, come quando doveva nascere Alessio…
Del resto, è questa la vita di tutte le spose.
Perciò non parlavano mai di pigliare un boccone d’aria, fuori. E don Lucio, da parte sua, si guardava bene dal far balenare un desiderio simile. Troppe noie… Troppe noie… Ci sarebbe voluta la serva per portare il bambino che non camminava ancora, una mantiglia nera per Antonietta che non poteva andare in mostra in quello stato… Spese pazze, spese inutili! E inoltre avrebbe dovuto alterare le comode abitudini. Addio fumata del dopopranzo, addio limonea da sorseggiare senza fretta… Niente, niente, meglio che la vita scorra come un orologio e le donne siano assestate. Del resto – assicurava a se stesso per levarsi ogni scrupolo, – le monache di clausura stanno benissimo e vivono a lungo. Le donne non sciupano energia.
Era dopo avere ruminate queste cose sonnecchiando dopo aver fatto la sua fumata, a fin di cena, che tante volte concludeva con un piccolo stiramento delle braccia.
— Sì! La felicità si trova nell’abitudine!
E guardava le due sorelle che cucivano assorte al lume della lampada (usava la lampada a olio, don Lucio, perché il petrolio e il gas irritano gli occhi), per sentirsi approvare.
Loro approvavano, con un cenno del capo, perché le cose dette da lui non potevano essere se non giuste e vere. Ma non avevano sentito l’osservazione.
Tacendo tutta la serata avevano pensato intensamente alla casetta rossa col «si loca», alla piccola famiglia sparpagliata qua e là.
Alessio peggiorava. Don Lucio sentiva in confuso di essere responsabile della vita del fanciullo malato.
— Ci vorrebbe un medico… – diceva Antonietta timidamente.
— Certo un medico… – appoggiava Nicolina sotto voce.
Il solo pensiero che un uomo estraneo dovesse penetrare nella sua casa, impadronendosi della fiducia e della riconoscenza della moglie, gli dava un profondo malessere.
Ma il fanciullo peggiorava. E don Lucio, non sapendo più tollerare le lagrimucce delle donne che parevano quasi tacciarlo di poco interessamento, una sera andò lui stesso in persona, nella più vicina farmacia, a chiamare un medico qualunque.
Mentre la madre e la zia, col naso e gli occhi rossi, aspettavano trepidanti, seguendo ogni gesto del medico che osservava il malato in silenzio, anche lui aspettava, con l’aria un po’ fiera di chi si è sacrificato per compiere il proprio dovere. Pareva dire: «Ho fatto quanto stava in me di fare». E in verità la sua coscienza era in pace. Alessio poteva anche morire ormai, se questo era il suo destino e le due donne non avrebbero mai più il diritto di fargliene carico.
Si trattava di tifo. Per ben cinquanta giorni Antonietta non lasciò la camera. Sorbiva qualche uovo, una tazza di brodo, per tenersi in piedi. Non si interessava di nulla, di nessuno. Tutto il suo mondo era il piccolo Alessio, i mille bisogni del malato, i lunghi abbattimenti, le fugaci migliorie.
Don Lucio, che aveva gran paura del contagio, continuò a dormire solo e a mangiare solo.
Il peso della casa lo sopportava tutto Nicolina. Da che si alzava, – e si alzava mentre era ancora scuro –, fino a notte tarda, non si concedeva un minuto di riposo. Lei a sbrigare le faccende grosse e minute, a stirare, a cucinare, a provvedere a tutto. La sua preoccupazione era di non far pesare troppo sul cognato le conseguenze di quella benedetta malattia. All’ora dei pasti rimaneva in piedi, anche se le gambe le tremavano dalla stanchezza, pronta a cambiargli il piatto (per portargli la vivanda ben calda come piaceva a lui che la voleva veder fumare, riscaldava il piatto al riverbero della fiamma), a mescer da bere, a sbucciare la frutta. Sbucciare la frutta era il compito più delicato. Antonietta non era mai riuscita a pelare così bene un’arancia, dopo averla sbucciata, liberandola con un temperino da ogni piccola peluria, da ogni filamento, senza bucarla! Le pere, le mele, accuratamente mondate, tagliate a pezzetti; un pezzetto di già infilato nella forchettina d’argento…
Mettersi a tavola col cognato, mentre Antonietta non c’era, le pareva una sconvenienza. Però ingollava dopo un boccone, assieme a Carmelina che aspettava in cucina, come un gattino, sperando che la zia riportasse indietro qualche rimasuglio dei delicati manicaretti preparati a parte per il capo di casa. Dopo avere sparecchiato, riempiva la pipa. Preparava la limonata. Metteva a letto la nipotina (che da quando era malato Alessio dormiva nelle stanze superiori, in un lettino accanto al suo). Poi aspettava, rannicchiata in un cantuccio, con le palpebre pesanti, che bruciavano dal sonno. E il tempo passava più adagio; e le ore parevano più lente; il ticchettìo sommesso del pendolo, il sordo ‘mpe ‘mpe delle labbra di don Lucio che succhiava placidamente la pipa, incrinavano il profondo silenzio. In confuso pensava, insonnolita, che il ticchettìo lento lento segnava i passi del tempo che va e va senza posa e senza ritorno.
Aspettava che il cognato, posata la pipa, domandasse le carte posate sulla scansia, e dicesse senza guardarla:
— Puoi andare, se hai sonno.
Allora andava in camera a salutare Antonietta. La scorgeva, nella discreta luce verdolina della lampada, a vegliare il malato; pallida, spettinata, dolente.
— Vado. Hai bisogno di me?
Paziente e umile sbrigava qualche faccenda in camera, aiutava la sorella a rifarsi il letto, adagio adagio per non disturbare il piccolo malato, e finalmente saliva la scaletta di legno, finalmente libera. Si svestiva in fretta, spegneva: si lasciava cadere sul letto, pesantemente.
Alcune sere stentava ad addormentarsi. Sentiva un formicolio per tutto il corpo, una gran voglia di piangere, e poi chiudere gli occhi per non svegliarsi più. Era, certo, l’avvilimento della stanchezza.
Come Alessio guarì, a Nicolina parve di essersi liberata da un incubo. Si sorprese a canticchiare, qualche volta, mentre era affatto sola, come fosse tornata ai tempi spensierati di Sant’Agata.
Il salottino fu sgomberato e rassettato. Le finestre di nuovo spalancate. Alessio uscì due o tre volte con Carmelina, che si era molto sciupata, accompagnati dal padre. Ma siccome don Lucio non era disposto a uscire nelle ore calde, e l’aria fresca della sera non giovava al convalescente, non parlarono più di passeggiate. Del resto, i ragazzi sarebbero presto usciti ogni giorno, col riaprirsi delle scuole.
Ogni cosa tornò come prima. Pure Nicolina continuò a servire lei il cognato. Se Antonietta accorreva, chiamata dal marito, questi diceva:
— Se hai da fare, manda tua sorella.
E Antonietta mandava Nicolina.
— A momenti sei più brava di me! – esclamava allegramente. Volentieri si scaricava di gran parte delle fastidiose cure che doveva avere di don Lucio. Nicolina, beata lei!, era nell’età che si pigliano le cose alla lettera.
Rideva, Antonietta, osservando con che trepidazione, si accostava al cognato per riempirgli la pipa; con che meticolosità gli sbucciava la frutta, gli preparava la limonea della sera!
— Nicolina – aveva detto don Lucio, in tono di buon umore – è più brava di te!
— E non mi meraviglio! – aveva esclamato Antonietta sorridendo. – Se avesse i pensieri che ho io!
— Ma prima…
— Prima era un’altra cosa, s’intende…
— …Non si vuol persuadere che una madre di famiglia non può sempre occuparsi del marito come fosse un bambino di latte! – si giustificava Antonietta.
Cominciava a pettinarlo con una certa calma, ma dopo dieci minuti si rammaricava di perder tempo e la sua mano diventava nervosa, impaziente.
Ma le agili mani di Nicolina diventavano meccaniche. Passava e ripassava il pettine tra i radi capelli spruzzati d’acqua Migone, sul roseo cranio quasi nudo, adagio adagio, a lungo, mentre don Lucio, con la pipa tra le labbra, si abbandonava alla voluttuosa sensazione del massaggio, chiudendo gli occhi, come un gatto accarezzato, se il pettine scorreva proprio sulla nuca. Qualche volta dimenticava persino che qualcuno, dietro a lui, si poteva stancare. Tanto la mano di Nicolina restava leggera e uguale.
Beneficava anche la famiglia della moglie, don Lucio. Amministrava la piccola terra. Quando Antonio era venuto in città, a sostenere gli esami di licenza nelle scuole tecniche, lo aveva ospitato. E tre volte aveva mandato del denaro alla vedova, in regalo.
— Scrivi a tua madre – diceva in quell’occasione ad Antonietta mostrandole la lettera sigillata –, che io faccio quel che è umanamente possibile, per lei e per voi.
E soggiungeva:
— Scrivile che mi faccia sapere con precisione in qual modo impiegherà il mio denaro. Il buon senso non è il suo forte.
E Antonietta, prima di scrivere, restava un pezzo agitata non sapendo come esprimere il volere del marito senza offendere la mamma. Poi compilava la lettera con l’aiuto di Nicolina. Chi non lo conosceva poteva mal giudicarlo, credere che fosse tirato… E invece…
Il regalo accompagnato dalle affettuose parole di Antonietta che mal mitigavano l’asprezza dell’ordine di don Lucio, acquistava doppio valore.
— È giusto – ripeteva la vedova, cercando di persuadere i figli che borbottavano. – Non posso pretendere che mi tratti come la buon’anima… Io sono un’estranea, per lui. È già troppo quel che fa… Purché Antonietta sia sempre così felice, che importa di me?
E rendeva conto del denaro:
«Carissimo genero. Delle cinquanta lire che mi avete mandato con la vostra pregiatissima assicurata, ho pagato venti lire di debito al calzolaio. Ho dato inoltre venticinque lire in acconto alla tessitrice, che giusto avevo armato il telaio per la tela delle lenzuola. Con le altre cinque lire ho comperato un po’ di spigato per fare grembiuli a me e a Caterina che se ne aveva bisogno».
Don Lucio, inforcati gli occhiali, leggeva e rileggeva più volte quella povera lettera listata di nero, mentre Antonietta aspettava trepidante, come una bambina che sa di meritare un castigo.
— Ecco le donne – diceva finalmente don Lucio. – Perché fare delle scarpe sul debito? Perché armare un telaio quando non si hanno i mezzi? In quattro e quattr’otto ha liquidato fino all’ultimo centesimo. Prevedevo queste cose. Sapevo che mandare il mio denaro a Sant’Agata, o buttarlo dalla finestra, era l’identica cosa.
Antonietta non fiatava. Don Lucio piegava lentamente la lettera e andava a chiuderla nel cassetto della scrivania, tutto sodisfatto di essere stato obbedito anche dalla suocera e di aver dato un’equa valuta al proprio regalo.
L’amministrazione degli stabili del barone Rossi che don Lucio teneva assieme al notaio Marulli (due fattori si occupavano delle terre), gli portava via molto tempo. Il barone, straricco, possedeva magnifici palazzi anche in città.
Don Lucio esigeva le pigioni, contrattava, assumeva obblighi di fare riparazioni… Ed era così economo, e si irritava così visibilmente quando una casa restava sfittata o quando lo mandavano a chiamare per mostrargli qualche grave guasto, che pareva ci perdesse del suo. Case e palazzi che al tempo del barone vecchio restavano chiusi e abbandonati, fruttavano tutti. Per le sue continue prove di interessamento e di attività, don Lucio meritò a poco a poco la completa fiducia del barone Rossi. Ogni primavera faceva un viaggetto per esigere o per rinnovare locazioni nei paesi, e si mostrava inesorabile con quelli che non si trovavano «in regola». Volentieri, pur di presentare i conti al barone senza lacune e senza manchevolezze, imprestava lui il denaro ai morosi solvibili. Così, senza avvedersene, si trovò ad avere presto messo in commercio i propri capitali. Col tempo, la cosa si seppe. Come si seppe? E anche in città cominciarono a ricorrere a lui, nascostamente. Mogli di poveri impiegati, signore ritirate, venivano a cercarlo in casa, o l’aspettavano sul portone appena sapevano che lui non voleva ricever debitori, liete di aver da fare con un «signore» che non avrebbe messo in piazza le loro miserie e non si sarebbe approfittato d’un soldo. Gli offrivano dei gioielli in pegno, che lui nascondeva nella misteriosa cassetta d’ebano.
Parlando con la moglie, non accennava mai alle sue piccole speculazioni, benché gli sarebbe piaciuto mostrarle quanto gli costasse l’agiatezza di cui la circondava. Era persuaso, persuasissimo, di esercitare un commercio lecito (dopo tutto si riduceva a cavar d’impiccio certi disgraziati che altrimenti sarebbero finiti tra le grinfie d’uno strozzino…). Ma temeva che Antonietta e Nicolina potessero non comprendere che il lavoro che faceva per conto proprio fosse quasi tanto onesto quanto quello che adempiva per conto del barone. La sera si faceva portare sulla tavola la cartella – che le donne non pensavano neppure di aprire –, e passava qualche ora attorno a tre o quattro registri: qua segnava le «entrate» e là le «uscite», qua scriveva fitto fitto e uguale dentro una colonna blu intitolata «pro memoria», là riempiva di cifre una colonna rossa che portava la data del giorno… Tutto in bell’ordine nelle carte; come in tutte le cose sue.
Tutte le cose, oh, sì! Aveva una mensolina da posarvi la pipa, il tabacco, i cerini; una cassetta dove custodire le scarpe nuove (ne aveva di tutte le forme: stivali, stivaloni, tronchetti…), e una dove riporre le scarpe vecchie; e non gli mancava una scatola tonda per i colletti, una oblunga per le cravatte… né una scansia per le carte; un armadietto per le chiavi… Le cassette più grandi erano allineate in uno stanzino. Nicolina, spolverando le stanze, ogni mattina dedicava un buon quarto d’ora, alla spolveratura dello «stanzino di Lucio», dove le cose erano così bene ordinate che a cercare un oggetto di notte, senza lume, si sarebbe trovato con certezza nella tale cassetta, nel tale punto.
Così, come teneva in ordine i conti e gli oggetti d’uso, don Lucio teneva sistemate le proprie abitudini. La vita era divisa anch’essa – come lo stanzino e come i registri –, in tante parti, ognuna delle quali conteneva un’occupazione, un’abitudine, un bisogno. Per lui non c’erano lati oscuri o incerti dell’avvenire. Tutto era metodicamente stabilito, tutto preveduto.
Qualche volta, fumando nella lunga pipa (le pipe corte nuocciono alla salute), era assalito dal torbido ricordo della sua fanciullezza povera, senza affetti familiari, rattristata dalla solitudine e dall’indifferenza in cui lo lasciava un vecchio parente…
Sì, aveva molto sofferto, e sapeva di aver diritto al benessere che si era saputo procurare!
Ma un’ombra passava tra le belle e facili previsioni: ed era l’ombra cupa della morte – della morte che poteva agguantarlo da un momento all’altro, inchiodandolo per sempre su quella stessa poltrona sulla quale stava placidamente sdraiato.
Impallidiva, lasciando spegnersi la pipa fra le labbra, preso dal terrore di non potersi godere la facile vita sapientemente creata, la facile comoda vita sognata nelle ore amarissime della desolata miseria, allorché, intirizzito affamato inasprito, gli passavano vicino i ricchi uomini col cappotto di pelliccia e i grossi guanti di felpa…
Era malato. Sentiva battere il cuore a scatti ineguali, sotto la palma aperta sul petto.
Le privazioni, le incertezze, le fatiche del passato, avevan sciupinato quel fragile organo che nessun medico può risanare…
Ora anche le apprensioni e i ricordi gli facevano male, eccitandolo. Però chiamava la moglie o la cognata, o si contentava dei ragazzi, per sentire la propria voce, parlando loro di qualche cosa insignificante.
Ora che Alessio aveva ripreso gli studi e anche Carmelina tornava a scuola dalle monache, restava molto tempo libero nel dopo pranzo.
Nicolina prese il cestino col lavoro (soffici camiciole, tenui delicate camicine lunghe un palmo…), e sedette fuori sul balcone.
Antonietta era in faccende: metteva in ordine l’armadio della biancheria e riponeva le robe d’estate, quelle troppo leggere. Era di nuovo incinta. Ogni volta rassettava la casa, da capo a fondo, con le proprie mani, e andava a confessarsi nella chiesa vicina, come se avesse dovuto partire per un lungo viaggio.
— E non è come s’io partissi? – diceva dolcemente. – Debbo staccarmi dalle cose, da voialtri. Chi mi assicura che io stessa, con le mie mani, riaprirò queste casse, toccherò di nuovo queste robe? Voi direste allora: «Antonietta era una cattiva disordinata massaia…».
Nicolina cuciva un po’ svogliatamente. Le ultime rondini passavano a stormi nel cielo e parevan salutare stridendo i luoghi che dovevano abbandonare. I tetti splendevano nel riflesso affocato dal sole. Un torraiolo stava immobile sul cornicione come un grande uccello di bronzo. C’era nell’aria un tepore quasi primaverile, un vasto ronzìo fatto di mille voci rotte e lontane, di mille rumori confusi. Era l’estate che smoriva dolcemente, ogni giorno un poco. Dal vicolo saliva il lagno della Rossa, ch’era stata battuta e scacciata dall’amante. S’era buttata lunga distesa dietro l’uscio chiuso, e un piccolo bambino dai piedi nudi e la camicina corta fino al ventre, stava a guardarla da lontano. Anche Nicolina la guardò un momento, più sorpresa che impietosita. Era sudicia, laida, scarmigliata. Perché continuava a soffrire, e non fuggiva, e non si liberava dalla catena che la teneva legata a quell’uscio chiuso? Nicolina arrossì, pensando che dietro l’uscio doveva esservi l’amante, l’uomo che l’aveva battuta e che più tardi l’avrebbe lasciata rientrare, come sempre. L’amante… Ripeté fra sé e sé, con le labbra, la parola piena di seduzioni.
Ma era quello l’amore?
Corrugò la fronte e tornò a guardare la Rossa senza volerlo.
Ebbene, anche l’immagine dell’amore può dare disgusto certe volte.
Pensò a Caterina che non si voleva maritare. Ora capiva perché. Molte, come Caterina, hanno ripugnanza dell’amore pur senza sentire che cosa esso sia. È così…
Riprese a lavorare. La vedova s’era affacciata per stendere una coperta giallognola scolorita, indugiando fuori a strappare qualche foglia secca dal geranio che fioriva senza sole. Le due bande dei capelli, neri come il corpetto a lutto, davano riflessi di marmo al suo volto. Rientrò, lasciando la coperta distesa. Anche quel colore giallo, sul balconcino nero, faceva tristezza.
Il crepuscolo invermigliò il cielo e i tetti e il vicolo. Poi la vivida luce svanì tutta, improvvisamente, nell’aria violacea.
Nicolina rientrò. Nella vasta casa c’era un gran silenzio. I ragazzi avevano acceso il lume e facevano i compiti.
— I tre regni del-la na-tu-ra… – leggeva Carmelina facendo scorrere il dito sulla pagina.
— Per piacere! – l’interrompeva Alessio. – Non mi fai capire! Leggi fra te e te.
Nessuno aveva bisogno di lei. Pure andò in camera. Forse Antonietta la voleva. L’abitudine di servire gli altri non le lasciava godere un’ora di completo riposo.
Marito e moglie erano seduti contro i vetri del balcone chiuso: don Lucio fumava e teneva un braccio attorno alla vita di Antonietta. Egli era insolitamente lieto, questa volta, della gravidanza di sua moglie: gli pareva un segno di rinascente giovinezza.
Parlavano a voce bassa. Nicolina rimase sulla soglia non osando entrare e dolendosi di dover tornare indietro. Il suo fine e pallido viso si colorì fugacemente. Si domandò, con ansietà quasi rabbiosa quasi dolorosa, che mai si dicessero piano, in mezzo a tanta pace…
Tornò sul terrazzo imbiancato dalla luna, con la gola stretta da una gran voglia di piangere.
Nessuno aveva bisogno di lei.
Essa era venuta per contemplare la felicità di sua sorella. Sì, Antonietta era felice…
Rivedeva, in visione, la sorella sposa, nei primi tempi. Tempi già lontani, che riviveva intensamente in un attimo. Ricordava molte cose, fugaci inafferrabili come frammenti di sogni, certi sguardi scambiati fra i due sposi, un tono di voce languido e smarrito, certe maniere di sorridere, e trasaliva tutta come se «essi» le fossero dinanzi come «allora». Rivedeva Antonietta che usciva dalla propria camera con aria di abbandono un po’ stanco… Ciò non le aveva destato alcuna impressione «allora»; era come uno che legga senza comprendere, e poi rilegga e ogni parola diventa viva e piena di significato. Ecco che Antonietta tornava a muoversi lentamente per le stanze e don Lucio le ordinava di usarsi riguardi:
— Lascia fare a Nicolina. Non ti strapazzare.
Sì, toccava a lei la parte faticosa, come all’umile serva pagata. E la sua vita sarebbe trascorsa così, sempre? Sempre?
Ma a poco a poco svaniva l’amarezza nel suo cuore. Si guardò a lungo le rosse e ruvide mani. Chi sa se avrebbe mai cucito delle fini spoglie per un bambino suo? Arrossì forte, come se qualcuno le fosse stato davanti e avesse potuto intendere gli incompiuti pensieri che fluttuavano nella sua mente come le tenui nubi chiare che velavano a momenti la luna, nel cielo. Poi non pensò più nulla. Si smarrì tutta in un tumulto di sensazioni piene di turbamento e di gioia. Le pareva di dormire e di svegliarsi, di svegliarsi e di dormire.
Dal cielo pioveva una calma luce di stelle e la casa nel vicolo non pareva più tanto triste. Una tenerezza quasi angosciosa, un bisogno di esser voluta bene, di voler bene a qualcuno, soffocava il suo cuore.
— Nicolina! Nicolina!… – chiamava Antonietta. – Alessio, dov’è tua zia?
Si alzò. Don Lucio era seduto presso la tavola. Carmelina infilava delle perline e Alessio leggeva.
Aveva dimenticato la limonata. La preparò, la portò sul piatto azzurro. Posandola accanto al calamaio, guardò furtivamente il cognato, piena di curiosità. Come poteva render felice sua sorella?…
Sperò che levasse gli occhi dai registri, volendo cogliere nel suo sguardo un’espressione di dolcezza. Non poteva essere sempre così rigido, così freddo e severo, allorché era solo con Antonietta!
Ma don Lucio non alzò la testa. Ordinò, quasi bruscamente:
— Riempi la pipa.
Già, la pipa… Dimenticava tutto, Nicolina! Ubbidì subito, mezzo mortificata.
Ebbene, perché doveva guardarla? Che cosa rappresentava, lei, nella vita di suo cognato? Una povera ragazza che si tiene per carità, null’altro. Pure essa, venuta ancora piccola nella casa, non era un po’ come Alessio, come Carmelina? Gli sarebbe stata così grata d’una buona parola! Anche nel Vangelo è scritto che l’uomo non si sfama di solo pane.
Tornò ad affacciarsi per vuotare il bocciolo della pipa. La serata era calma e luminosa. Pensò a certe tranquille passeggiate fatte a quell’ora a Sant’Agata a braccetto di un’amica, chiacchierando. Di che aveva chiacchierato con tanto piacere? Di tutto… Di niente… Rivide la piccola casa piena di gaiezza e di amore. Adesso era sola.
Sì, era sola. Antonietta pareva staccarsi da lei, ogni giorno di più. Viveva in un altro mondo. Era passato il tempo beato, quando, tutte e due fanciulle, ridevano e piangevano e ridevano con uguale facilità per ogni piccolo avvenimento triste o lieto.
Don Lucio domandava:
— Che leggi, con tanta attenzione?
— Ecco, papà.
Don Lucio guardava il libro che il fanciullo gli porgeva, aperto, con visibile rincrescimento. Lo sfogliava e lo chiudeva seccamente.
— Non mi piace che t’ingombri il cervello di romanzacci.
— Non è un romanzaccio, papà – rispondeva Alessio timidamente. – È del Foscolo. Iacopo Ortis di Foscolo.
— È sempre un romanzo. Ti proibisco di leggerlo. Chi te l’ha dato?
— Il Rossi.
— Riportaglielo domani. È troppo presto per te.
— Ma lui, che ha pure l’età mia…
— Pensa per te. Ti proibisco e basta. Vergogna! Un bambino che va ancora nelle scuole elementari!
Alessio si alzò, con gli occhi lustri di lacrime. Nicolina gli sussurrò:
— Non ti affliggere. Papà ha ragione.
— No… – fece Alessio con un cenno della testa, allontanandosi.
Nicolina portò la pipa al cognato. Era di nuovo immerso fra le carte, accigliato ma tranquillo. Come Alessio poteva ribellarglisi dentro il cuore? Egli era un uomo che non si sbagliava mai, che conosceva il bene e il male. Bisognava affidarsi a lui come al marinaio che guida la barca in alto mare. È così bello aver fiducia in qualcuno… E il suo cuore tornò a gonfiarsi della sconfinata ammirazione per il cognato.
— Ecco la pipa… – disse con dolce umiltà. E tornò ad aspettare ch’egli levasse la testa, per cogliere nel suo sguardo una espressione di benevolenza. Sedette accanto alla sorella, un po’ afflitta, un po’ umiliata. Sentiva un gran bisogno di parlare, di muoversi, di sentir parlare.
E la sua vita sarebbe trascorsa sempre così? Sempre? Simile a una di quelle serate eterne pesanti silenziose? Ci sono ore nella giovinezza in cui l’anima è così debole che non sa sopportare la solitudine. E la solitudine pare una creatura visibile; una creatura d’incubo che ci prema il cuore con le due mani aperte.
— Guarda, che cuffietta, Lucio!… – diceva Antonietta.
— Brava – rispondeva don Lucio sorridendo.
La cuffietta l’aveva cucita Nicolina, di tutto punto. Così tutto il suo lavoro restava senza merito e senza compenso, come fatto nella sabbia… Per la prima volta provò una malevole punta di gelosia, un pungente rancore per la sorella.
«Sì, sì… – ripeteva il suo cuore col sordo tumultuoso battito, mentre il silenzio tornava gravemente nella stanza – …sì, tu sei invidiosa di tua sorella…».
— C’è una visita in salotto! – annunciò Alessio correndo in cucina, dove Nicolina stava schiumando il brodo.
— Una visita? Sarà qualcuno venuto a cercar di papà.
— No, no. È proprio una visita. È stata chiamata anche la mamma.
— Ma che dici!
— Ecco, va via.
— E allora corri a vedere chi è.
— Mi vergogno, zia Nicoli’. È un signore cogli occhiali d’oro, questo è certo. Ma sento papà… Non dirgli niente, zia Nicoli’…
— Vado io – propose Carmelina. – Mi nascondo e guardo.
— È inutile – replicò Alessio. – Se n’è andato. Sento papà…
Don Lucio veniva nella stanza da pranzo. Cambiò idea, sulla soglia, e si diresse in camera. Vedeva che Antonietta aveva una gran voglia di parlargli e temeva che lo facesse in presenza di Nicolina. Antonietta lo seguì, con occhi brillanti di gioia e d’impazienza, ma vedendolo abbuiato si perdette d’animo.
— Si è fatto un bell’uomo… – esclamò finalmente.
— Sì?! Con quella faccia da minchione! – replicò don Lucio, seccato.
— È intelligente… Tu gli avrai messo soggezione… Ti parlava di Nicolina quando mi hai fatto segno d’andarmene…
Il marito la squadrò. Disse, dopo un silenzio:
— Sì, di tua sorella. Ma io gli ho risposto come si meritava. Si guarderà bene dal rimettere piede in casa mia.
Antonietta si fece pallida. Balbettò:
— Che hai fatto, Lucio! È un galantuomo. Ci conosce… La buon’anima di papà ne faceva gran conto… Ha una buona posizione… Infine… – esclamò con dolore, a bassa voce – …era la sua fortuna, povera figlia…
— Ti piace? – interruppe don Lucio ironicamente. – Vuoi dargli tua sorella? Ho fatto male? Ti domando perdono in ginocchio. E corro a chiamarlo. Corro… Non sapevo che volessi sbarazzarti di tua sorella buttandola tra le braccia del primo venuto… Bel profitto… – riprese duramente, dopo un nuovo e più pesante silenzio. – Bel profitto logorarmi la vita per il vostro benessere! Per sentirmi rimproverare! Per raccogliere la vostra ingratitudine!
— Sì, tu mi dai torto! – Affermò, poiché Antonietta faceva dei cenni col capo, piangendo. – Tu ti permetti di giudicarmi secondo le tue corte vedute. Io so quel che mi faccio. Tua sorella non è più una povera provinciale, un’orfana senza dote e senza avvenire! Essa avrà un buon partito, degno della cognata di don Lucio Carmine.
La sua voce si rabbonì. Antonietta fece per lasciare la camera, pentita, umiliata. Ma egli la chiamò:
— Non ti venga in mente – le disse, – di parlare di questo fatto a tua sorella! Le ragazze fanno presto a lavorar di fantasia!
Per quel giorno non uscì di casa, neppure nel pomeriggio, e a una donna che venne a cercarlo fece dire che non c’era. Temeva che Antonietta potesse raccontare la cosa alla sorella, e la teneva d’occhio.
Ma Antonietta non ardì disubbidirlo subito. Verso sera andò a buttarsi sul letto, assalita dalle doglie. Don Lucio respirò, si sentì sollevare. Mandò Alessio di corsa con un biglietto per donna Filomena Zuppola e circondò di premure la moglie. Era quasi contento che lei soffrisse così forte, dimenticando la piccola novità della mattinata. Ordinò a Nicolina di ritirarsi coi ragazzi nelle stanze superiori.
— Non è affar tuo. Andate a letto tutti e tre.
Nicolina ubbidì senza replicare. Altre due volte si era spaventata, ma non così fortemente. «La cosa» era successa di giorno, e lei ignorava ancora la gravità del pericolo a cui era esposta sua sorella.
— Dormi – ripeté rincalzando il fanciullo che l’interrogava con gli occhi. – Non è nulla. Passerà tutto.
Carmelina si addormentava di già.
Non si coricò. Era inquieta, eccitata: si aspettava di esser chiamata da un momento all’altro. S’affacciava sulla scala e tendeva l’orecchio. La porticina in fondo era chiusa. C’era un gran silenzio. Un momento si sentì un lagno accorato. Chi si lagnava così? Non poteva essere Antonietta… Forse la voce veniva di fuori, dal vicolo… Tornava a sedere presso il letto di Carmelina e si alzava subito, torcendosi le mani per non gridare. Il tempo era lento, eterno, implacabile. Dio, Dio mio, mormorava senza muover le labbra, fate che questo tormento finisca.
Tendeva di nuovo l’orecchio. Non si sentiva più nulla. Il silenzio gravava sulla casa, ma un silenzio nuovo, come quello che fa un uomo, nella notte, che veglia e pensa.
Riudiva le meste parole:
— Ebbene, non è come s’io mi avviassi per un viaggio?
Domandava perdono a Dio della punta di gelosia che aveva avvelenato il suo cuore, poche sere innanzi. No, la sua povera sorella non era felice. Se la figurava nei momenti più brutti: o su quel letto di dolore, o accanto ad Alessio malato, o sotto lo sguardo severo del marito. Non aveva fatto che soffrire e lei non l’aveva compresa. Nell’eccitazione da cui era pervasa, l’invidia, i malevoli sentimenti provati, le sembravano mostruosi imperdonabili.
Sua sorella era sola, sola nella nottata eterna, sola col suo tormento. – Dio mio! – gemette forte, – com’è brutta la vita!
La notte passò così. La sua anima vibrava come un arco teso. L’alba imbiancò in una cornice di luce chiara, la finestra. La lampada si spense crepitando.
Ascoltò di nuovo. Udì la voce robusta di donna Filomena, poi quella di don Lucio. Che dicevano?
Sentì sbattere una porta.
Avrebbe dovuto assisterla lei, non lasciarla sola…
Che rimorso se Antonietta…
Sì, dev’essere finito tutto… – si disse con terrore. Scese risolutamente. A piedi della scaletta incontrò il cognato. Si sentiva, con la porta aperta, un fievole pianto di bambino: un pianto che pareva un belato, che non aveva niente di umano.
— Dove vai, Nicolina? – fece don Lucio.
— Sì – aggiunse, – grazie a Dio è finita. È un’altra bambina. Venivo a dirtelo. Torna nella tua camera. Ti chiamerò. Tieni con te i ragazzi. Ma non tremare così. Ti ammalerai.
Quel tono di voce sommesso, quasi malinconico, la calmò.
Egli era sinceramente commosso. La tragica semplicità di ciò che era avvenuto, gli aveva lasciato un’impressione di sgomento. In quell’attimo, così pieno di mistero e d’angoscia, la sua anima pareva liberarsi dall’egoismo e aprirsi a un sentimento di simpatia – tanto penoso quanto fugace – verso coloro che soffrivano.
— Sì, Nicolina mia, la morte e la vita entrano insieme talvolta nella casa dove si aprono due occhi nuovi!
Dolcemente la spinse verso la scaletta, sfiorandole appena la vita col braccio.
Nicolina risalì lentamente.
— Dio mio! – gemette di nuovo – com’è brutta la vita!
Perché si nasce? Chi aveva desiderato quella creatura che piangeva?
La veglia, l’eccitazione, l’attesa affannosa e poi la voce velata d’insolita tenerezza del cognato, tutto un insieme di sensazioni e di commozioni provate, le toglievano le forze. Si accasciò a piedi del lettino e pianse. Svenne. Riavendosi, vide Alessio che teneva in mano un bicchiere d’acqua. Era bianco e spaventato. Forse non aveva dormito neppure lui.
— Zia Nicoli’ – esclamò un po’ rinfrancato poiché non riusciva a far bere l’acqua alla zia -, ho chiamato, chiamato… Ma nessuno mi ha risposto. Credo che anche papà si sia coricato.
Carmelina dormiva ancora.
— Aspettami, Alessio – fece Nicolina.
Scese in punta di piedi. Nell’attaccapanni non c’era più lo scialle nero di donna Filomena.
Spinse cautamente l’uscio della camera. Don Lucio dormiva, russando sonoramente, nel lettino. Nel letto grande Antonietta, senza una goccia di sangue nelle vene, pareva assopita. Aprì gli occhi, udendo il lievissimo rumore. Nicolina le si inginocchiò vicino.
— Povera sorella mia – mormorò Antonietta. – Pensavo che non ti avrei più veduta, e avevo il gran dolore di non averti raccomandato le mie creature… Ma tu non le avresti abbandonate… Dimmelo, Nicolina! Che fanno in questo momento?
— Carmelina dorme. Alessio è alzato. Vuoi vederlo?
— No, il povero Lucio riposa. Più tardi. Più tardi. Tacque sfinita.
Nell’altra metà del letto, in un viluppo di biancheria fine, coperta da un velo, dormiva anche l’altra, coi piccoli pugni chiusi. Nicolina si alzò per guardarla, a un invito della sorella. Ma il suo sguardo si posò sulla nuova venuta, senza simpatia. Per quella creatura nuova, Antonietta era stata – un attimo eterno – tra le grinfie della morte… Perché era sbocciata, nella casa malinconica?
Ma contemplando i piccoli rosei pugni serrati, ebbe pietà anche dell’intrusa.
«Fosse almeno un maschietto» si disse. La sua sorte sarebbe più facile. Le donne sono nate per servire e per soffrire. Non per altro.
Che mai teneva nei piccoli pugni chiusi? Forse la felicità… Ognuno di noi, nascendo, stringe i pugni per non lasciarsi sfuggire un bene che non ritroverà mai più…
I pensieri le turbinavano nella mente, senza regola. Le doleva la testa e il cuore. Si allontanò, in punta di piedi, e andò in cucina a preparare il caffè.
Alessio la seguì. Nell’incerta luce dell’alba il suo visetto spaurito, aureolato dai morbidi chiari capelli, pareva quello d’una bambina.
La nostra vita non è che abitudine, come diceva don Lucio. Da più di due mesi Antonietta giaceva in fondo al letto, quasi senza speranza di guarire, e tutta la casa ripigliava il suo sistema, impercettibilmente trasformato qua e là, come se la padrona fosse stata sempre malata. Alessio andava a scuola dai Domenicani, due volte al giorno; Carmelina andava dalle monache; Nicolina accudiva alla casa, accorta e sollecita come sempre, e badava anche alla piccola Agata.
Avevano finito di desinare. La stanza era calda, luminosa, impregnata del grave odore dei cibi. Carmelina guardava Alessio, con occhi brillanti di vivacità e di impazienza, così neri che parevano quelli d’un topolino. E Alessio osservava la tovaglia per non ridere.
— Andiamo? – domandavano gli occhietti neri e birichini.
— Aspetta… Non è l’ora – rispondevano gli occhi castani pieni di mansuetudine.
Finalmente don Lucio respinse il piattino e fece un cenno ai ragazzi. Potevano andare. Carmelina scivolò cautamente dall’alta seggiola, corse via inseguita dal fratello soffocando le fresche risate.
Nicolina sparecchiò. Preparò il caffè. Portò il brodo alla malata. Sapeva quel che c’era da fare e lo faceva con precisione, senza spazientirsi, camminando in punta di piedi per l’abitudine ormai invecchiata di non dar molestia al cognato.
Antonietta la ringraziò con lo sguardo, nel renderle la tazza vuota.
— Dove sono i bambini? – domandò – Che fanno?
— Sono di sopra. Giocano. Alessio deve tornare a scuola. Anche Carmelina… Lui vuole che rimanga dalle monache fino all’ora di cena. Non esce e gli dà noia sentirla…
— E tu lasciala andare. Dalle monache sarà più libera, povera bambina. È così vivace!
Ecco infatti che uscivano. Giocavano ancora e si spingevano l’un l’altro sull’uscio, entrando per salutare la madre.
— Ci benedica!
— Ci benedica!
— Santa, figlia mia. Santo, figlio mio. Non fate tutto questo chiasso! E attenti alle carrozze nella strada! Tenetevi per la mano…
Corsero via ridendo. Si sentì sbattere la porta.
— Non hanno prudenza! – osservò la madre sorridendo.
Nicolina non rispose. Da qualche giorno provava una specie di inquietudine al pensiero di restare affatto sola col cognato, l’intero pomeriggio. Avrebbe voluto tenere con sé almeno Carmelina… Ma non aveva osato contrariare don Lucio esprimendogli il suo desiderio. E poi, come dirgli?
Tornò nella stanza da pranzo, per sbrigare qualche faccenda. Poi andò in cucina e cominciò a stirare. C’era un gran caldo e si sbottonò il colletto. Le parve che Antonietta avesse chiamato e andò di nuovo in camera. Non aveva chiamato e stava per assopirsi.
— Che fai, Nicolina? – domandò aprendo gli occhi.
— Stiro. Mi pareva di aver sentito la tua voce.
— No, Nicolina. Non ho bisogno di nulla. Puoi stare tranquilla.
Accostò la finestra e si allontanò dalla camera in penombra. Si rimise a stirare. La grossa fatica le pesava, a quell’ora, dopo aver mangiato, e guardò con una sorta di avvilimento il gran cesto di biancheria preparato. Meglio esser malata, quasi quasi… poter sonnecchiare in una stanza fresca…
Don Lucio entrava lentamente, fumando. Nicolina arrossì, turbata e sorpresa. Lui non metteva mai piede in cucina, altro che la mattina per lavarsi.
— Avete chiamato? – domandò.
— No.
Si piantò davanti la finestra, con le gambe larghe, e la sua figura si frastagliò nello sfondo luminoso come un enorme compasso. Portava uno dei suoi abiti estivi, a piccoli dadi bianchi e nocciola, che lo faceva parere più lungo.
Si sentiva distinto il ronzio d’una mosca che si sbatteva contro i vetri aperti cercando invano l’uscita, e il metodico succhiar delle labbra incollate al cannello della pipa.
— Senti caldo?
— Un poco.
— Non dovresti mai stirare a quest’ora. Ti affatichi troppo.
Nicolina arrossì più forte, commossa dell’insolita osservazione. Chi aveva pietà di lei?… E a questo pensiero ebbe una violenta voglia di piangere.
— C’è una signora – disse don Lucio avvicinandosi alla tavola – che fuma.
— Fuma? – esclamò Nicolina cercando di interessarsi alla notizia, per compiacenza.
— Sì. La cognata del notaio Marullo. Fuma come un uomo.
E il silenzio si rifece profondo, ma vigile. Don Lucio ora pareva assorto a contemplare la spoglia che Nicolina stirava.
— A te non dà noia il fumo?
— No. Ormai sono abituata.
— Perché non l’hai mai avuto sulla faccia.
— Che idea!
— Ecco, così. – Piegandosi un poco, don Lucio le soffiò sul viso una boccata di fumo. Nicolina si scostò, nauseata. Don Lucio rideva.
— Vedi che non lo puoi soffrire?
Nicolina non rispose. Il fumo, l’aria graveolente della cucina, e più di tutto l’inquietudine che tornava a provare pensando di essere affatto sola, le procurarono un acuto malessere.
Ebbene, bisognava lasciar di stirare, andare in camera con una scusa e restarvi finché fossero tornati i ragazzi. Doveva chiedere che Carmelina, da domani in poi, rimanesse a darle compagnia… Ma non si moveva; i nervi e i muscoli diventati flosci non ubbidivano alla sua volontà.
Don Lucio le cinse la vita, sfiorandola appena, come quando l’aveva incontrata in fondo alla scala, nell’alba.
Nicolina si scostò, posando il ferro, e fece per uscire, finalmente, facendo uno sforzo per camminare. Don Lucio la seguì sull’uscio, senza fretta. Quasi la ghermì. Nicolina volle divincolarsi, fuggire; volle gridare, ma la voce le si spense nella gola. Ora don Lucio se la teneva stretta sul petto, con un braccio solo. Non rideva più. Quasi accigliato, come quando dava un ordine, disse:
— Antonietta non ti chiamerà…
Tenendola sempre stretta, uscì dalla stanza da pranzo. Col braccio nervigno quasi la sosteneva. Entrando nel salottino, ripeté meccanicamente:
— Antonietta non ti chiamerà…
S’era rifugiata nella propria cameretta; e ora, accasciata sulla sponda del letto, guardandosi i ginocchi aguzzi scossi da un tremito che non riusciva a frenare, si meravigliava di aver trovato la forza di fare le scale. Aveva perduta la conoscenza del tempo. Forse la vita fuggiva come la luce. Fuori della tonda finestra si vedevano i tetti invermigliati dal tramonto di fiamma. E i tetti tremolavano e fuggivano, il letto, le seggiole, ogni oggetto girava e spariva, si faceva un gran buio e poi tutto tornava con uno schianto e tornava la rossa luce.
Antonietta, i nipoti, erano lontani. Pensava a Sant’Agata, alla madre. Povera mamma! perché hai lasciato andar via la figlia più piccola?
Le pareva, a momenti, di essere sospesa nel vuoto e di precipitare con la luce senza potersi aggrappare. Sentì la voce della Rossa, la voce roca ben nota nel vicolo. Veniva da lontano, quella voce. Tutto era lontano.
Che fare domani? doman l’altro?
Ebbe orrore, ribrezzo della vita. Il tempo passa uguale, indifferente alle nostre miserie, ai nostri dolori. L’orologio grande della parete continua a mormorare le ore, senza tregua. Tutto sarà immutato, anche se dentro l’anima si è scatenato l’inferno.
— Dio! – pregò angosciata. – Fate ch’io possa non rivedere più il mio simile e la luce del giorno. Fate ch’io possa morire…
Ecco un passo affrettato nella scaletta che cigola un poco al lieve peso. È Alessio.
— Zia Nicoli’! Perché allo scuro? Papà ti manda a dire che prepari la cena.
Trasalì. Alessio l’abbracciava, trascinandola festosamente. Lo respinse con dolcezza.
— Vengo – disse. – Vengo.
— Che t’ho fatto, zia Nicoli’?
— Niente. Ma lasciami in pace. Adesso vengo.
Le sue labbra non avrebbero più osato posarsi sulla pura fronte degli innocenti bambini. Il bacio aveva perduto per sempre ogni soavità.
Discese legando macchinalmente i nastri del grembiule scuro.
La stanza immersa nella quieta luce del lume pareva piena di pace familiare. Alessio e Carmelina ritagliavano delle figure da un vecchio libro. Don Lucio, occupato a scrivere in un registro, non alzò gli occhi udendo il passo di lei.
Andò in cucina. Poi aprì il cassetto della tavola e prese la tovaglia.
«Possibile!» pensava angosciata. «Possibile che tutto sia come ‘prima’?».
E disse a Carmelina, per abitudine:
— Aiutami ad apparecchiare…
Ma subito trasalì, udendo la sua stessa voce, che risuonò tranquilla e pacata, come prima, nella stanza piena di silenzio e di quiete.